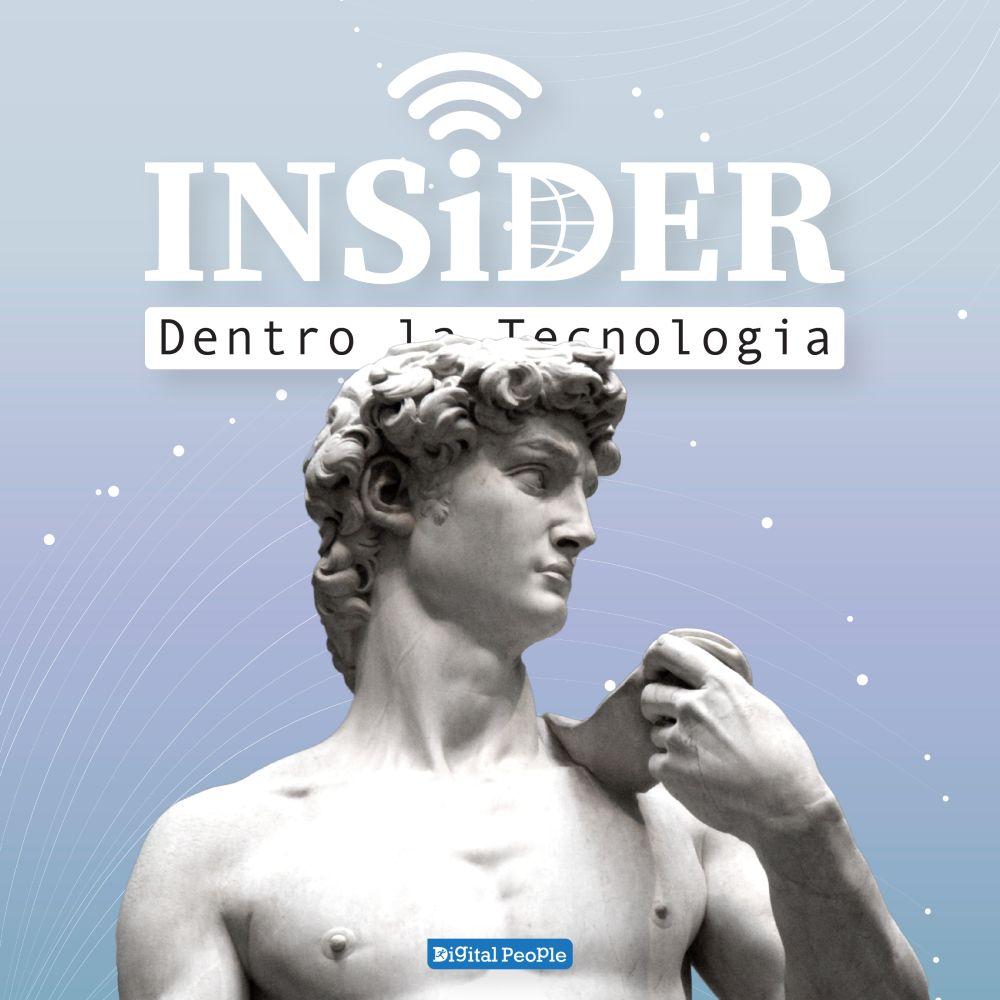Il cinema si è imposto sin da subito come una delle più efficaci forme di comunicazione esistenti. Oggi cercheremo di capire il ruolo che ha avuto nel modificare la società e come nello specifico, il genere fantascientifico, sia stato lungimirante nel descrivere il nostro presente e il nostro futuro tecnologico portandoci spesso a compiere riflessioni molto profonde grazie a capolavori del calibro di Ritorno al futuro, Blade Runner e Matrix.
Nel consueto spazio dedicato alle notizie affronteremo il problema della scarsità dei semiconduttori per produrre hardware, del nuovo Enel X Store di Roma e di come l’Agenzia delle Entrate potrebbe usare l’Intelligenza Artificiale per portare alla luce il denaro sommerso.



Brani
• Ecstasy by Rabbit Theft
• Idyll by Peyruis
Salve a tutti, siete all'ascolto di INSiDER - Dentro la Tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host, Davide Fasoli.
Oggi parleremo di come il cinema, e più nello specifico il genere fantascientifico, abbia influenzato il nostro presente e il nostro futuro tecnologico.
Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a @dentrolatecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina, su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito.
La carenza dei dispositivi a semiconduttori potrebbe durare per tutto il 2021.
Sono queste le parole di Cristiano Amon, presidente e futuro amministratore delegato di Qualcomm, che in una recente intervista ha rivelato al mondo intero che la poca reperibilità dei chip a materiali semiconduttori potrebbe durare più del previsto.
Crisi che, secondo il dirigente americano, si ripercuoterà inevitabilmente anche sul mercato della produzione di smartphone.
Secondo quanto dichiarato nell'intervista, le ragioni di tale carenza sono state principalmente due.
La prima è sorta in seguito alle richieste troppo elevate di semiconduttori subito dopo la riapertura delle fonderie, che essendo rimaste totalmente chiuse nei primi mesi di crisi sanitaria, erano praticamente prive di scorte.
La seconda ragione invece si rifà le ultime restrizioni imposte a Huawei dell'ex amministrazione Trump.
In questo caso, i diversi concorrenti dell'azienda cinese hanno subito colto la palla al balzo, cercando di sopperire al vuoto lasciato da Huawei intensificando la domanda di chip, mettendo ancora più in difficoltà un settore già di per sé in forte crisi economica.
Enel X ha inaugurato a Roma in corso Francia, in collaborazione con Volkswagen Group Italia, la prima area cittadina per la ricarica ultrafast dei veicoli elettrici.
Enel X Store offre tecnologie per l'efficientamento energetico, servizi finanziari e soluzioni per la mobilità elettrica oltre a un punto ristoro.
Sono anche presenti le prime quattro stazioni high power charge in area urbana.
Ciascun punto di ricarica ha una potenza fino a 350 kW e permette alle auto elettriche compatibili di fare il pieno di energia in circa 20 minuti.
Oltre ai caricatori ultrafast e tradizionali è presente una Juiced Media, lo schermo digitale integrato con due stazioni di ricarica riservato ai test drive dei brand Volkswagen Gruppe Italia.
Negli scorsi mesi abbiamo intervistato sia Enel X che Volkswagen Group Italia per parlare rispettivamente di infrastrutture di ricarica che di veicoli elettrici.
L'agenzia delle entrate raccoglie ogni anno più di 3 miliardi di dati e informazioni, tra cui dichiarazioni dei redditi, informazioni sui bilanci, fatture elettroniche e molto altro.
Dati che vengono revisionati quasi completamente a mano, per trovare evasori fiscali o incongruenze nei dati forniti dai cittadini e dalle aziende.
Presto però, grazie a un progetto finanziato dall'Unione Europea, questo lavoro verrà fidato a un'intelligenza artificiale che, addestrata dalle operazioni svolte finora, sarà in grado di potenziare i controlli dell'agenzia delle entrate.
In particolare, l'ente avrà a disposizione tre strumenti, le Network Analysis per trovare relazioni nascoste tra le società analizzate, il Machine Learning, ovvero l'intelligenza artificiale, e infine la Data Visualization, che mostrerà graficamente ai funzionari i risultati delle analisi svolte.
Una riforma strutturale, come è stata definita dall'Unione Europea, in grado quindi di contrastare ma soprattutto di prevenire, in tempi sempre più rapidi, i gravi problemi di evasione fiscale che da sempre affliggono il nostro Paese.
Una tra le principali forme di comunicazione che più ha contribuito a plasmare la società contemporanea sia nel bene che nel male è senza ombra di dubbio il cinema.
Sin dalla sua comparsa risalente a circa 120 anni fa grazie ai fratelli Lumière, la cinematografia intesa come la proiezione in sala di una pellicola stampata di fronte ad un pubblico pagante si imposta sin da subito come una delle più efficaci
forme di comunicazioni esistenti a quel tempo, arrivando in poco più di vent'anni a costituire le fondamenta di quella che oggi definiremmo la mecca del cinema, Hollywood.
Con il passare degli anni, poi, la filiera cinematografica è arrivata ai giorni nostri a rappresentare per un paese come l'Italia, i cui contenuti iniziarono ad essere creati già all'epoca dei fratelli Lumière, un giro d'affari di quasi 4 miliardi
di euro e che vedeva attive, prima dell'attuale crisi sanitaria, oltre 2.000 aziende, delle quali circa 300 coinvolte nella distribuzione delle pellicole cinematografiche.
Purché si tratti comunque di un settore d'edito a ricavo economico, le motivazioni che hanno portato Ricciotto Canudo a coniare la definizione di settima arte, ancora nel lontano 1921, risiedono essenzialmente nelle modalità con cui le informazioni
vengono veicolate e soprattutto tramandate nei decenni, fondate su valori come la narrazione e l'impostazione scenica, le quali hanno contribuito a consolidare il settore dell'intrattenimento per eccellenza in molti paesi di tutto il mondo.
Ad ogni modo, nella puntata di oggi non arriveremo a trattare il cinema in tutte le sue sfaccettature, ma ci focalizzeremo su un genere cinematografico che ha fatto della tecnologia il suo cavallo di battaglia, la fantascienza.
Partiamo da un film che nel 1985, anno della sua uscita in sala, divenne sin da subito un cult movie, per merito soprattutto dell'allora sperimentatore Robert Zemeckis, regista di futuri capolavori come "Chi ha incastrato Roger Rabbit" e "Forrest Gump", e del produttore Steven Spielberg, il cui curriculum parla praticamente da solo.
Ci stiamo riferendo naturalmente a Ritorno al futuro, i cui espedienti narrativi composti non tanto da predominanti elementi fantascientifici, benché siano comunque la chiave di volta dell'intero film, e poi vedremo perché, quanto da un clamoroso
sotto testo narrativo, imbevuto di epoche passate e costellate da continui riferimenti e citazioni, tra i quali spicca anche la famosa scena in cui Marty McFly suona nel passato la celebre canzone Johnny B.
Goode, esattamente tre anni prima che venisse scritta.
Ma Ritorno al futuro, seguito poi da parte 2 e parte 3, non è costituito solamente da rimandi al passato.
All'interno dell'intera saga troviamo un elemento peculiare che, senza la sua esistenza all'interno della storia, non avrebbe mai e poi mai potuto incidere con l'indelebile nella cultura pop contemporanea.
La nota automobile in grado di trasportare i protagonisti in epoche passate come il 1955 del primo film o il 1885 del terzo film e infine il 2015 nel secondo capitolo è stata realizzata a partire da una vera DeLorean Dmc12 che nel contesto narrativo della storia, grazie allo zampino dello scienziato Emmett Doc.
Brown, è stata aggiornata con l'aggiunta di avanzatissimi sistemi che oggi definiremo di infotainment, in grado di avviare e gestire un flusso catalizzatore che, una volta raggiunta alla potenza di 1,21 gigawatt e la velocità di 88 miglia orari, avrebbe consentito ai protagonisti di viaggiare indietro e avanti nel tempo.
Il successo della Dmc12, inconfondibile per le portiere con apertura ad ala di Gabbiano e per il design futuristico, è avvenuto in parallelo all'enorme applauso che ricevette il ritorno al futuro, ma non fu solo quello il motivo di tale affermazione nell'immaginario collettivo.
Per colpa dell'arresto per spaccio di droga del proprietario della DeLorean Motor Company, John DeLorean, la casa automobilistica in seguito a tale evento dovette scioglierci, il che portò alla produzione di solamente 9.200 veicoli, tutti assemblati tra il 1981 e il 1982, e divenuti sempre più rari da trovare negli anni seguenti.
Ma un'ottima notizia è arrivata giusto qualche mese fa, poiché il nuovo proprietario del marchio DeLorean ha annunciato che la celebre Dmc tornerà sul mercato ma in versione full electric.
Contrariamente a quanto si possa pensare, nonostante il notevole successo riscosso verso la fine degli anni 80, i nuovi proprietari del marchio DeLorean non furono più in grado di risollevare le sorti dell'azienda, salvo l'ultimo tentativo
effettuato dal magnate texano Steven Winn che intende riesumare la storica vettura ma in chiave elettrica.
Al momento non sono state ancora diffuse informazioni specifiche al riguardo e non si sa nemmeno se il progetto riuscirà effettivamente ad arrivare alle fasi conclusive.
L'unica certezza è che la scelta di rendere elettrico questo storico veicolo non è casuale, infatti in seguito alle nuove politiche ambientali relative alle missioni del particolato in atmosfera, ridare vita nuova al Dmc12 mantenendo comunque il motore termico, seppur migliorato rispetto all'originale, sarebbe stato presso che impossibile.
Ma di ritorno al futuro non è rimasta solamente l'auto alimentata a plutonio di Doc e Marty.
Nel corso dei tre capitoli anche altri elementi hanno contribuito a rendere celebre la saga diretta da Zeminski, tra questi ricordiamo il famoso volo pattino, uno skate fluttuante, comparso nel secondo film, le scarpe Nike in grado di autoallacciarsi
oppure gli occhiali super tecnologici di Doc in grado di raccogliere precise informazioni relative alle zone circostanti.
Anche in questo caso, sebbene si tratti di oggetti fantascientifici, un minimo sviluppo nella realtà, soprattutto di questi ultimi, l'hanno avuto.
Sul finire del 2016, ad esempio, il volo pattino del film, ricavato da Marty a partire da un monopattino volante, è rinato nel famoso hoverboard, ossia un piccolo veicolo a due ruote laterali che mediante sensori giroscopici ed elettronici riesce a mantenere il passeggero in equilibrio verticale.
L'avrete sicuramente visto sfrecciare nei marciapiedi di qualche città.
Persino le scarpe autoallaccianti sono state realizzate da Nike.
Parliamo in questo caso di vari modelli, tra i quali troviamo le Nike Mag Air, dotate di un sistema di autoallacciamento alimentato da una batteria da 500 mAh.
E prodotta in edizione limitata, il cui ricavato è andato poi alla Michael J.
Fox Foundation, associazione gestita dallo stesso interprete di Marty, McFly, che si occupa della ricerca sul morbo di Parkinson.
Disponibili tuttora sul mercato sono invece le Nike Adapt, che come le Mag Air riescono ad allacciarsi da sole non appena vengono indossate, con la possibilità eventualmente di regolare la calzata tramite l'app Nike Adapt.
Terminiamo infine con gli occhiali, definiti dallo stesso doc super tecnologici, che anche in questo caso sono arrivati ad un passo dall'affermarsi sul mercato.
Parliamo della prima generazione dei Google Glass, che prima del comunicato di chiusura diffuso dalla casa di Mountain View avrebbero dovuto trasformare l'interazione con il mondo reale tramite la realtà aumentata.
Passiamo ora ad un altro film, il cui eco, dopo quasi 40 anni dalla data di uscita in sala, continua a farsi sentire nelle opere cinematografiche e nei videogiochi da cui traggono tuttora ispirazione.
Stiamo parlando di una pellicola che come poche altre è riuscita ad avere una fortuna così trasversale nel tempo, nonostante un inizio decisamente poco incoraggiante e che ancora oggi continua a far discutere fan e critici sul significato del film e sull'eterna questione umano o replicante del protagonista Rick Deckard.
I più appassionati di cinematografia avranno sicuramente intuito il titolo del film a cui ci stiamo riferendo, Blade Runner, il capolavoro di Ridley Scott uscito nel lontano 1982 che ha gettato le basi nella cultura cinefila del dispotismo scientifico.
Traendo ispirazione dal capolavoro letterario, gli androidi sognano pecore elettriche?
Le vicende del film narrano del cacciatore di taglie o Blade Runner, Rick Deckard, il cui compito consiste in quello di eliminare un gruppo di androidi assassini e replicanti sfuggiti dal loro creatore e arrivati poi nella Los Angeles del 2019, anno
in cui si svolge la trama del film e da cui partirà la tormentata ricerca del protagonista, il quale dovrà poi fare i conti con una verità alquanto indigesta, la possibilità di essere egli stesso un replicante.
Partendo da questo presupposto l'obiettivo dei prossimi minuti sarà quello di focalizzare la nostra attenzione sul secondo protagonista della pellicola, al pari dell'agente Deckard, ossia il contesto tecnologico in cui si trova immersa la città.
La Los Angeles del 2019, anno in cui si svolgono le vicende del film, è una città perfettamente distopica, un gigantesco ghetto sovrappopolato senza alcuna identità e oppresso da una persistente pioggia decisamente poco salutare.
Ma nel sequel Blade Runner 2049, uscito giusto tre anni fa, il regista Denis Villeneuve arriva a calcare la mano ancora più del predecessore sul tema che ci interessa approfondire.
La trasposizione di un universo completamente artificiale è malinconico, in cui l'organico ha ceduto definitivamente il posto al progresso tecnologico, costellato da androidi dotati di un'intelligenza artificiale anni luce più avanti di quanto potremmo immaginare al giorno d'oggi.
Anche per queste ragioni molti studiosi hanno individuato in Blade Runner, torniamo all'opera precorritrice dell'82, un'erede ideale del Frankenstein letterario, il quale narra di una creatura che si ribella al proprio creatore e le cui ambizioni
prive di freni, esattamente come nel film di Scott, devono fare i conti con eventi che sfuggono pericolosamente al controllo umano.
Il tema della consapevolezza della macchina, che si sottrae allo scopo per cui è stata creata, ricomparirà più e più volte in pellicole di genere fantascientifico, passando da altri capostipiti del genere come i primi due Terminator diretti da
James Cameron o dai più recenti Matrix, Ghost in the Shell, l'uomo bicentenario, ex macchina e così via.
Ad ogni modo, dell'importanza etica di questa tematica ne parleremo in modo ancora più approfondito sicuramente in una prossima puntata.
Avviamoci ora verso la conclusione della questione, dando infine il merito a Blade Runner di aver trasposto per la prima volta nella settima arte il concetto di futuro retro, poiché è notoriamente risaputo che il contributo dell'opera dell'82 è
stata fondamentale per dare forma all'immaginario cyberpunk, ripreso successivamente da pellicole fantascientifiche come Ghost in the Shell e Matrix, o da noti videogame tra cui Cyberpunk 2077, uscito giusto l'anno scorso.
A proposito della trilogia di Matrix, ideata dalle sorelle Wachowski, come già sottolineato poco fa, l'idea di un futuro in cui l'umanità esso, giocata dall'intelligenza artificiale, diventa un eufemismo, talmente sottile il confine che distingue il complesso uomo-machina.
Così sottile che per arrivare a scorporare le due entità è sufficiente assumere una banalissima pillola rossa.
La vera questione, infatti, su cui si interroga la trilogia di Matrix, consiste nel rapporto tra uomo e tecnologia, arrivando persino a profetizzare una relazione di tipo simbiotica tra le due parti.
Essere umani e macchine sembrano dunque due facce della stessa medaglia, le quali non possono esistere l'una senza l'altra, per cui la prima ha persino oltrepassato il distopico confine delineato dalla pellicola ispiratrice Blade Runner, arrivando a distruggere completamente il pianeta che da sempre gli ha ospitati.
Ed è proprio in questo passaggio chiave che si inserisce la tecnologia, ormai sempre più sviluppata e intelligente, in cui da una parte mantiene in vita il genere umano affinché non si autodistrugga, ma dall'altra prosciuga quest'ultima della propria energia vitale per autoalimentarsi.
Naturalmente durante lo svolgimento del film, l'ago della bilancia pende sicuramente a favore del genere umano, al quale va però dato il torto di essersi approfittato dello stesso pianeta, che sin dall'arrivo delle macchine lo manteneva in vita, con la possibilità tuttavia di decidere per il proprio futuro.
Benché vi sia un presupposto ecologico di base, nella saga di Matrix le tematiche ambientali non sono particolarmente approfondite, anzi spesso vengono palesemente trascurate per far spazio all'intrattenimento, con mirabolanti scenografie chiaramente ispirate alla cinematografia giapponese.
Ma ad ogni buon conto è di fondamentale importanza ricordare a noi stessi che la realtà in cui viviamo attualmente è una soltanto e che proprio per queste ragioni dobbiamo trattarla con rispetto e consapevolezza, perché come ci insegna il cinema
di fantascienza, con gli esempi appena trattati, la tecnologia può essere fonte di deperimento e autodistruzione.
Perciò resta solamente a noi decidere cosa farne, perché come già sottolineato nella puntata sulle criptovalute, non conta quanto potente o avanzata sia la tecnologia, ma importa solamente il modo in cui viene utilizzata.
E così si conclude questa puntata di INSiDER - Dentro la Tecnologia, io ringrazio come sempre la redazione e in special modo Matteo Gallo e Luca Martinelli che ogni sabato mattina ci permettono di pubblicare un nuovo episodio.
Per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione@dentrolatecnologia.it, seguiteci su Instagram a @dentrolatecnologia dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti.
In qualsiasi caso nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social.
Se trovate interessante il podcast condividetelo che per noi è un ottimo modo per crescere e non dimenticate di farci pubblicità.
Noi ci sentiamo la settimana prossima.