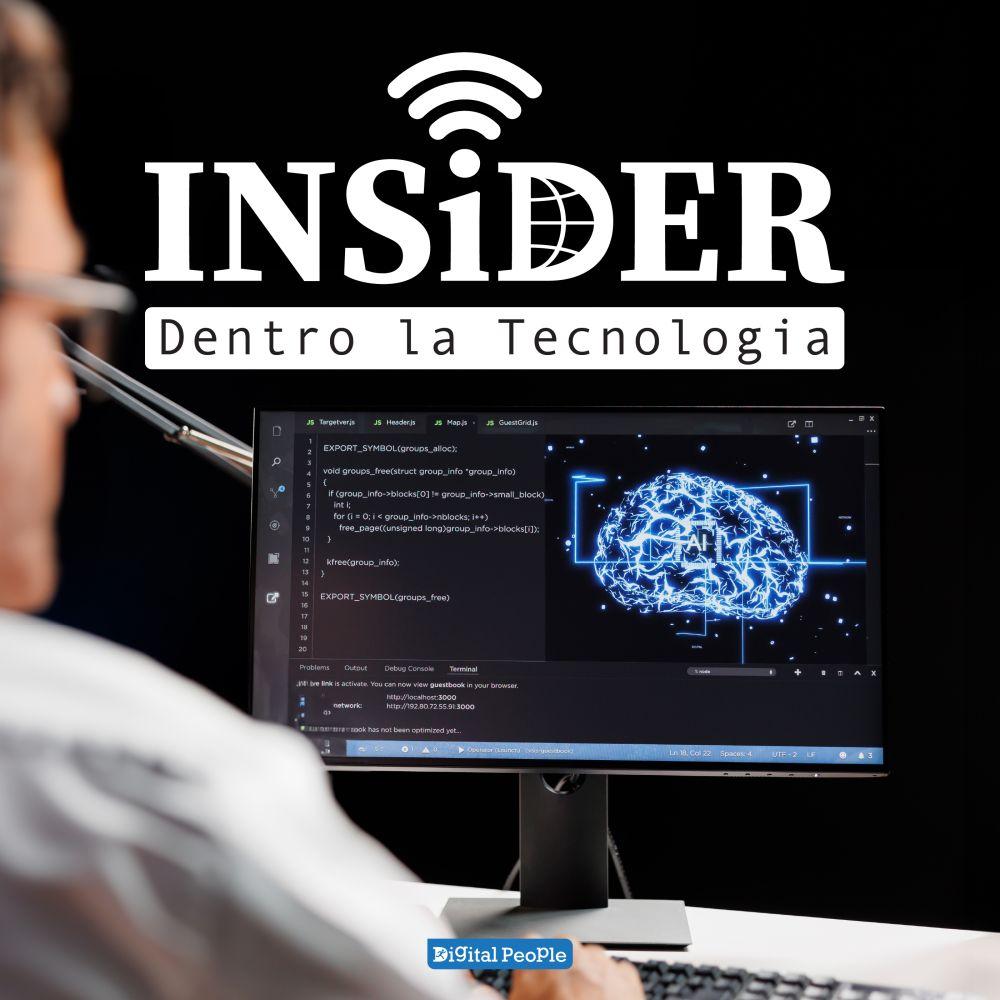L’opera letteraria che più di tutte esalta il potere, talvolta fuori controllo, della scienza, è sicuramente Frankenstein di Mary Shelley. Un romanzo di fantascienza che è diventato presto famosissimo perchè l’idea di dare vita a una creatura significava, per così dire, giocare ad essere Dio. Ma oggi dopo 200 anni possiamo ancora parlare di pura fantascienza? Per rispondere, in questa puntata abbiamo analizzato come la tecnologia può e sta già contribuendo nell’ambito della chirurgia e in particolare della neurochirurgia.
Nella sezione delle notizie invece riparleremo della possibilità di acquistare una Tesla con i bitcoin, dello spegnimento delle antenne 3G di TIM e infine di SIAE che utilizzerà la blockchain per proteggere il diritto d’autore.




Brani
• Ecstasy by Rabbit Theft
• Jnathyn by Dioma
Salve a tutti, siete all'ascolto di INSiDER - Dentro la Tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host, Davide Fasoli.
Oggi cercheremo di capire se è possibile creare nel 2021 la creatura di Frankenstein o, più realisticamente, che contributo sta dando la tecnologia nell'ambito della chirurgia e della neurochirurgia.
Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a @dentrolatecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito.
Mercoledì 24 marzo Elon Musk, tramite il proprio profilo Twitter, ha finalmente annunciato che le automobili elettriche Tesla potranno essere acquistate d'ora in avanti anche tramite Bitcoin.
L'ufficialità di tale notizia era attesa ormai da diverse settimane, poiché già lo scorso mese la casa automobilistica di Elon Musk aveva deciso di investire ben 1.5 miliardi di dollari in Bitcoin, generando tra l'altro diverse polemiche nell'opinione pubblica per aver manipolato il valore delle criptovalute, tramite una serie di tweet pubblicati dallo stesso Musk.
Parliamo in effetti di una mossa che, a detta di molti analisti, può essere definita come Game Changer, dal momento che Tesla è divenuta ufficialmente la prima casa automobilistica ad accettare come forma di pagamento una moneta digitale dall'alto tasso di volatilità e che potrebbe rappresentare sia per gli acquirenti sia per la stessa Tesla un'eventuale fonte di ricavi ma anche grosse perdite economiche.
Alla presentazione dei risultati finanziari del quarto trimestre 2020, Tim ha definitivamente ufficializzato la volontà di spegnere le proprie reti 3G a partire dall'anno prossimo.
Esattamente come Vodafone, che ha bloccato giusto il mese scorso le proprie reti di terza generazione, anche Tim arriverà nei prossimi anni a dismettere progressivamente tutte le trasmissioni 3G, per poi dedicarsi interamente sul consolidamento delle reti di nuova generazione e del miglioramento dei servizi 4G.
Ad ogni modo, è merso invece che l'ancora più obsoleta rete 2G inizierà ad essere dismessa solamente a partire dal 2029, dato che ancora oggi molti apparecchi che utilizzano la forma di comunicazione M2M, ossia da macchina a macchina, come ad esempio vecchi POS, sistemi di controllo industriali o antifurti, richiederebbero costi troppo elevati e poco convenienti per essere aggiornati.
SIAE, la società italiana che si occupa di gestire e proteggere i diritti d'autore, nel 2019 aveva iniziato una collaborazione con Algorand e oggi ne vediamo i primi importanti risultati.
Algorand, infatti, è una blockchain simile ad Ethereum, che tra le altre cose può essere sfruttata per creare, comprare o vendere opere digitali sotto forma di non-fungible tokens.
A differenza di altre tecnologie, però, gli scambi con Algorand sono più efficienti, sia in termini di costo sia dal punto di vista energetico.
Tornando a SIAE, la società ha annunciato di aver caricato su questa piattaforma oltre 4 milioni di diritti d'autore.
L'obiettivo ovviamente è quello di digitalizzare completamente l'intero archivio.
E questo è un primo passo verso una gestione decentralizzata, più efficiente e soprattutto trasparente, dei diritti degli oltre 95 mila artisti associati a SIAE.
Se dovessimo pensare nella letteratura dell'età contemporanea all'opera che più di tutto esalta il potere, talvolta fuori controllo della scienza, tanto da produrre un mostro o un'espressione della paura umana verso il fin troppo rapido sviluppo tecnologico, è sicuramente Frankenstein di Mary Shelley.
Un romanzo che è diventato presto famosissimo e che è stato soprattutto nel secolo scorso più volte interpretato o reinterpretato sotto forma di spettacoli teatrali, musical e film.
E forse in molti ricordano la celebre scena tratta dal film parodistico Frankenstein Jr., nella quale il dottore riesce a capire come creare e dare vita a quello che poi diventerà il mostro o la creatura, come chiamata dallo stesso scienziato pazzo.
Un'immagine che nella mente di Shelley e della società del 1800 era decisamente fantasiosa, d'altronde creare un essere vivente significava, per così dire, giocare ad essere Dio.
Ma oggi, dopo 200 anni, possiamo ancora parlare di pura fantascienza? In altre parole, si può realmente fare? Per rispondere bisogna analizzare come la tecnologia può e sta contribuendo nell'ambito della chirurgia, e in particolare della neurochirurgia.
Ed è proprio quello che faremo in questa puntata.
Iniziamo con le cose relativamente semplici, i trapianti di organi.
Attualmente, e già dal secolo scorso, la medicina riesce a realizzare dei veri e propri miracoli, se paragonata al periodo di Shelley.
Il primo trapianto avvenne infatti in tempi abbastanza recenti, solo nel 1954.
Si trattò di un trapianto di rene avvenuto con successo, tra due gemelli monozigoti.
Ed allora la medicina ha fatto enormi passi in avanti, nel 1964 fu trapiantato per la prima volta il fegato, nel 1966 il pancreas, fino al primo trapianto di cuore nel 1967.
E tuttora questi sono gli organi maggiormente oggetto di tali operazioni.
Ma non solo, negli ultimi anni sono infatti stati effettuati anche trapianti di pelle, ossa, utero e perfino di faccia.
Quest'ultima, in particolare, è una delle operazioni più all'avanguardia e delicate, e che porta con sé non pochi problemi per quanto riguarda soprattutto il rigetto psicologico.
Apurato dunque che praticamente tutti gli organi potrebbero essere assemblati tra loro, con la tecnologia e la conoscenza che abbiamo oggi a disposizione, la sfida più grande nel realizzare la creatura ideata da Shelley, tralasciando tutte le questioni etiche di un esperimento simile, resterebbe sicuramente trapiantare e connettere il cervello e in generale il sistema nervoso.
A tal proposito, nel 2017 si è parlato molto di un possibile trapianto di testa, questione che è di certo da approfondire.
L'operazione fu infatti annunciata e ipotizzata da un neurochirurgo italiano, Sergio Canavero, ed effettuata in Cina, grazie a un'equipe che in 18 ore di intervento hanno connesso nervi, vasi sanguigni e colonna vertebrale di un corpo con la testa di un altro corpo.
Tuttavia, non si può certo parlare di un successo.
Le due, fra virgolette, metà utilizzate furono infatti prese da corpi già morti, quindi al momento non si può, e ancora non si potrà, capire se l'operazione potrà effettivamente funzionare per un essere vivente.
E i problemi da affrontare sono veramente tanti.
Il primo è sicuramente la complessità di un organo come il cervello, se umano che non.
Conosciamo ancora talmente poco della sua struttura, formata da miliardi di neuroni e milioni di connessioni, che sarebbe impossibile ripristinarle e riconnetterle insieme tra loro, come si farebbe ad esempio con i relativamente pochi vasi sanguigni da collegare in un trapianto di cuore.
Un secondo problema poi riguarderebbe la degradazione dello stesso cervello.
In assenza di ossigenazione, infatti, questo subirebbe dei danni permanenti, e con la tecnologia attuale, anche raffreddandolo il più possibile, una possibile operazione andrebbe conclusa in pochi minuti.
Dunque molto meno rispetto alle 18 ore impiegate dall'equipe cinese.
Come detto prima, infine sono già stati tentati dei trapianti di mano o volti su pazienti che avevano subito ferite gravi al viso o amputazioni.
Operazioni che hanno avuto, tra l'altro, successo dal punto di vista medico, ma che hanno portato a gravi problemi psicologici nei pazienti, che non riuscivano più a riconoscere il nuovo arto come parte di sé.
Figuriamoci cosa succederebbe con un intero corpo totalmente diverso.
In sostanza, arrivati a questo punto è chiaro che l'immaginario mostro del dottor Frankenstein, dopo due secoli, rimane e probabilmente rimarrà solo negli scritti fantascientifici di Shelley.
A pensarci bene, poi, la volontà di creare artificialmente un essere umano, o perlomeno un'intelligenza umana, è certamente rimasta, ma con un approccio totalmente diverso.
Quello dell'intelligenza artificiale.
E pure in questo caso, e ne abbiamo parlato nella scorsa puntata Intelligenza artificiale verso un mondo "humanless", ci vorranno decenni forse per portare a termine un progetto così ambizioso.
Ok, ma quindi cosa possiamo fare? Il per così dire progetto Frankenstein è da abbandonare completamente? Beh, non proprio.
Forse è necessaria una diversa visione, un'altra prospettiva, di come la scienza e la tecnologia possono ridare la vita ad una persona.
Pensiamo ad esempio alle 46 milioni di persone affette da malattie come l'Alzheimer o il Parkinson, o ai 90 milioni che magari in seguito a un incidente che ha lesionato la spina dorsale, sono costretti a passare una vita intera su una sedia a rotelle.
Si tratterebbe in questo caso di concentrare le forze e le ricerche non per un tentativo egoista dell'uomo di comandare la natura.
E stiamo vedendo a nostre spese cosa accade quando per orgoglio per interessi ci dimentichiamo di non essere i soli esseri viventi sul pianeta.
Quanto più di aiutare chi, per svariati motivi, non può più camminare, correre o vivere in completa autonomia.
Ed è proprio la direzione che la neuroscienza e la bioingegneria stanno prendendo, con risultati molto promettenti.
Andiamo con ordine.
Prima di tutto, va detto che un danneggiamento del midollo spinale dopo un incidente comporta, nella maggior parte dei casi, l'impossibilità di controllare i muscoli della parte del corpo inferiore alla lesione.
In altre parole, se si è infortunati, si può perdere per così dire solamente l'utilizzo delle gambe.
Un danno che al momento è ancora irreparabile, ma su cui esistono degli studi promettenti.
A differenza di altre parti del corpo, infatti, le cellule del midollo spinale e del sistema nervoso centrale, fatta eccezione per alcuni casi particolari, non hanno la capacità di rigenerarsi.
Se quindi quando ci graffiamo, tagliamo o rompiamo un osso dopo qualche giorno o mese il corpo guarisce, lo stesso non avviene in casi come quello di cui stiamo parlando.
Tuttavia, una recente scoperta ha portato i ricercatori sulla giusta strada per trovare una possibile cura.
Si tratta della proteina NO-GO-A.
Questa molecola, infatti come si può intuire dal nome NO-GO, ovvero non andare, è prodotta dall'organismo ed è la principale responsabile che blocca la rigenerazione e la crescita delle cellule nervose, sia del cervello, sia del midollo spinale.
Con un trattamento adeguato e rapido, utilizzando dei particolari anticorpi, in grado di ostacolare la relazione della proteina NO-GO, dunque è possibile stimolare la crescita di nuove cellule che andranno a guarire la lesione subita.
I risultati di questo trattamento sono promettenti.
Infatti già tre pazienti con lesioni anche gravi del midollo sono riusciti a recuperare, almeno parzialmente, il controllo di alcuni muscoli, come quelli delle dita dei piedi, se non addirittura tornare a camminare, anche se ovviamente con l'aiuto di un bastone o di un supporto.
Non è molto ed è decisamente lontano da un miracolo in grado di restituire l'uso delle gambe a milioni di persone.
Ma è un piccolo grande passo verso questa direzione.
Già oggi, grazie a questa tecnologia, siamo riusciti a realizzare ciò che fino a qualche decennio fa sarebbe sembrato impensabile.
Ovviamente, questa non è l'unica strada percorribile.
Un'altra possibile soluzione per guarire lesioni al midollo o curare malattie ritenute fino ad ora incurabili, come il Parkinson o la leucemia, potrebbe essere servendosi delle cellule staminali.
In sostanza, queste cellule, che si possono prelevare ad esempio dagli embrioni o dal liquido amniotico, sono in grado di svilupparsi in qualsiasi tipo di tessuto.
Da una cellula di questo tipo, quindi, è potenzialmente possibile creare nuovi neuroni, con cui riparare il midollo spinale o malattie degenerative, produrre midollo osseo perfettamente compatibile col paziente, o magari formare praticamente da zero interi organi da trapiantare in caso di necessità.
Le potenzialità di questa tecnologia sono insomma pressoché infinite, e per questo è fondamentale conoscere a fondo il comportamento di queste cellule.
Proprio per questo motivo, gli studi in questo campo avanzano ancora molto lentamente, e ad oggi le cellule staminali vengono utilizzate principalmente come terapia oncologica per curare alcuni tipi di tumori del sangue.
Per quanto riguarda la riparazione di lesioni al midollo spinale o la cura a malattie come il Parkinson, invece i risultati sono molto al di sotto delle aspettative.
Il rischio, infatti, è che queste cellule sfuggano dal nostro controllo, dando origine a tumori.
Un'altra motivazione per cui la ricerca in questo campo è molto rallentata è invece di tipo etico, e riguarda appunto se sia giusto o meno utilizzare cellule embrionali a questi scopi.
Come non citare, poi, l'editing genico.
Anche questa, in realtà, è una pratica ancora molto controversa, soprattutto se applicata all'uomo.
Ma nell'eterno gioco degli uomini a sostituirsi a Dio è forse la tecnologia con le più ampie potenzialità.
Si tratta letteralmente di modificare il DNA di una cellula per cambiarne le caratteristiche, e ci sono diversi metodi per farlo, anche se quello più affermato è chiamato CRISPR, ma non andremo troppo nel dettaglio.
Gli studi anche in questo caso sono solo agli inizi, e non c'è ancora possibile modificare o spesso prevedere i risultati delle modifiche genetiche.
Si è parlato molto, a inizio pandemia, di un complotto per cui il virus SARS-CoV-2, responsabile della Covid-19, sarebbe stato realizzato in laboratorio.
Teorie che si sono dimostrate completamente false proprio per il fatto che non abbiamo ancora le conoscenze adatte per modificare così tanto il DNA di una cellula, o come in questo caso di un virus.
E se è così difficile lavorare con una sequenza genetica relativamente corta come quella di un virus, figuriamoci per un organismo complesso come l'uomo.
Una forte spinta in questo campo la potrebbe dare sicuramente l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che potrebbe essere usata proprio per prevedere le modifiche applicate al DNA.
E se usata nel modo corretto, questa tecnologia potrebbe essere utilizzata, ad esempio, più che per decidere il colore degli occhi o dei capelli del proprio figlio, per rimuovere eventuali malattie o difetti genetici.
Fino ad ora, però, ci siamo focalizzati su soluzioni, per così dire naturali, ovvero che comunque prevedessero l'uso di sostanze già esistenti o cellule umane e non.
Esiste tuttavia una strada alternativa, quella artificiale, che sta prendendo molto piede negli ultimi anni.
Sicuramente di questa categoria fanno parte le protesi o gli esoscheletri.
Non è sicuramente come avere un reale arto funzionante, ma la tecnologia migliora esponenzialmente.
E tornando, come detto all'inizio, al discorso del rigetto psicologico, molte persone tuttora preferiscono ad esempio avere una mano artificiale, piuttosto che un trapianto che non viene riconosciuto come parte di sé.
E già in questi anni i progressi sono tali per cui una mano o un arto artificiale riesce a ricevere i segnali attraverso le terminazioni nervose recise durante l'amputazione.
E si stanno studiando tecnologie anche per inviare al cervello dei feedback per restituire il senso del tatto.
Un altro esempio di dispositivi artificiali in grado di connettersi col cervello è invece il famoso Neuralink, dell'omonima azienda fondata da Elon Musk.
Sono stati già mostrati dei test eseguiti sui animali al momento della presentazione, ma anche in questo caso il lavoro da fare è ancora molto, prima che si possano raggiungere effettivi benefici per l'uomo.
Si pensi ad esempio alla possibilità, anche in questo caso, di curare malattie degenerative o di aumentare, tra virgolette, la potenza di calcolo del nostro cervello.
Infine, dopo aver parlato di protesi artificiali, è doveroso parlare anche di organi artificiali.
È un fatto risaputo, purtroppo, che la donazione e il trapianto degli organi, del cuore in particolare, non è sempre possibile.
Vanno infatti considerati molti fattori, primo fra tutti la compatibilità fra il donatore e il ricevente, con conseguenti lunghissime attese anche di anni affinché un paziente possa avere un organo sostitutivo.
Problema che appunto non ci sarebbe con organi realizzati artificialmente.
E al momento esistono diverse tecnologie e tutte con risultati molto promettenti.
La prima strada è quella di organi stampati in 3D, che usano tessuti prelevati dal paziente e permettono di avere un sostituto naturale e perfettamente compatibile con il ricevente.
L'altra strada, invece, forse più semplice, è quella di realizzare dei materiali biomimetici.
Questi speciali materiali infatti non vengono riconosciuti come intrusi dall'organismo, evitando quindi il problema principale del rigetto.
Non sarebbe inoltre necessario avere a disposizione il paziente da cui prelevare il tessuto necessario per la stampa, e questo permetterebbe anche di produrre organi su larga scala, disponibili per chiunque ne avesse bisogno.
Di esempi pratici ce ne sono già diversi.
Ne avevamo infatti parlato in una notizia nella puntata IPE, la prima challenger bank in Italia, dove un uomo è riuscito a riottenere la vista grazie a una corne artificiale.
Recentemente, invece, il primo cuore artificiale funzionante, sempre realizzato in materiale biocompatibile, ha avuto l'approvazione alla vendita dall'Unione Europea.
E nel mondo sono già 13 pazienti che hanno ricevuto un trapianto con questo dispositivo.
L'unica barriera è il costo, di 200.000 euro, che però con il tempo, come tutte le innovazioni tecnologiche, è destinato a scendere.
Giunti alla fine, è giusto fare delle considerazioni conclusive su quanto abbiamo sentito.
Realizzare nel XXI secolo la creatura immaginata dal Dr.
Frankenstein è possibile? Come abbiamo constatato, le difficoltà non sono certamente poche, e forse l'unico modo per avvicinarci all'immaginario di Mary Shelley è sfruttare l'editing genetico.
Tuttavia, si tratterebbe solo di un capriccio umano, una mera e inutile dimostrazione di cosa potremmo essere in grado di fare.
La domanda più giusta sarebbe forse, ha veramente senso proseguire questa strada? Probabilmente anche in base alle considerazioni fatte finora, no.
Ciò che possiamo fare invece è utilizzare la tecnologia e la conoscenza che abbiamo a disposizione, non tanto per ridare la vita a chi ormai la persa, magari da tempo, ma invece restituirne una, magari quanto più normale possibile, a chi per pura sfortuna non ne ha più avuto l'opportunità.
E così si conclude questa puntata di INSiDER - Dentro la Tecnologia.
Io ringrazio come sempre la redazione e in special modo Matteo Gallo e Luca Martinelli che ogni sabato mattina ci permettono di pubblicare un nuovo episodio.
Per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione@dentrolatecnologia.it, seguiteci su Instagram a @dentrolatecnologia dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti.
In qualsiasi caso nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social.
Se trovate interessante il podcast condividetelo che per noi è un ottimo modo per crescere e non dimenticate di farci pubblicità.
Noi ci sentiamo la settimana prossima.