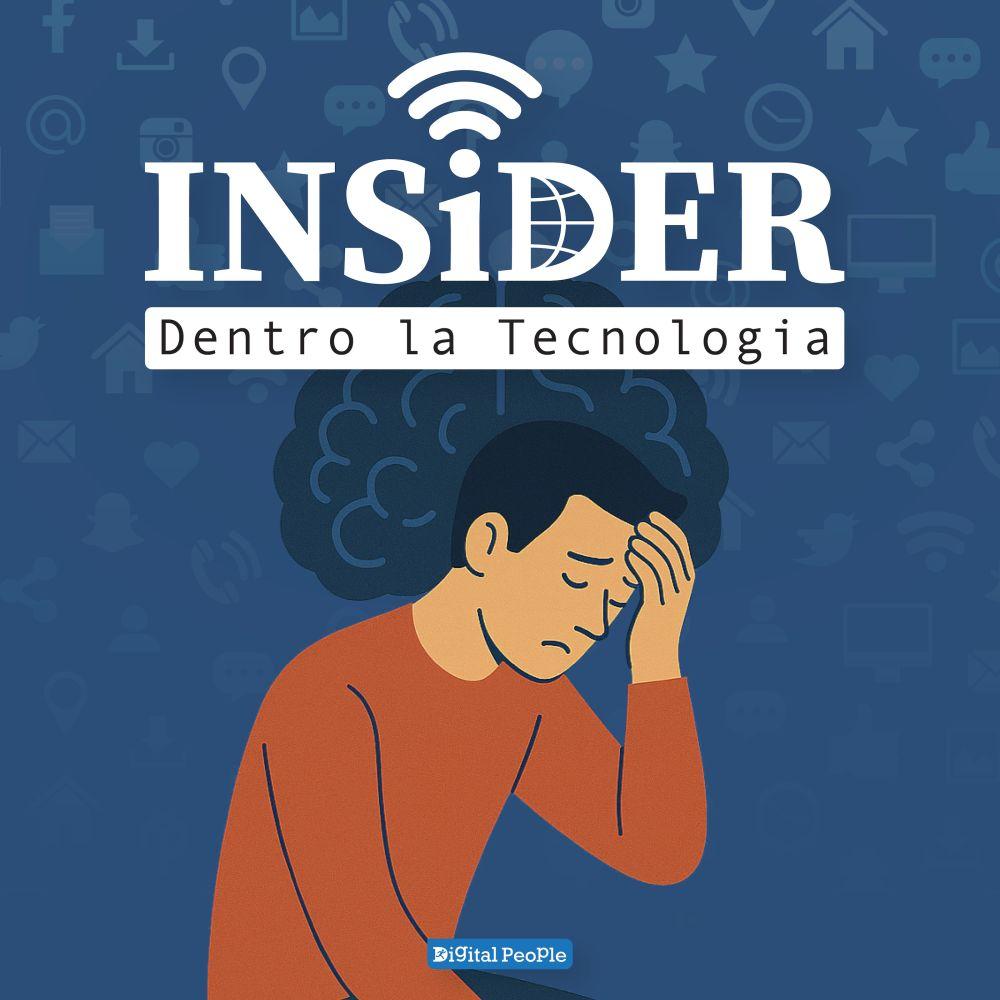Viviamo in un mondo interconnesso in cui tutto influenza tutto e dove chiunque può creare e diffondere notizie, sia vere ma soprattutto false. E quella delle Fake news è forse una delle più grandi piaghe sociali dell’ultimo periodo. Negli ultimi anni nuove tecnologie, tra cui i social media, stanno amplificando questo fenomeno. Per approfondire ulteriormente questo tema e capire come contrastare le notizie false ci siamo fatti aiutare da Giovanni Zagni, giornalista e direttore di Pagella Politica e di Facta.
Nella sezione delle notizie parliamo invece dei disservizi a internet causati da un bug di Fastly e della revoca del ban americano per TikTok e WeChat.
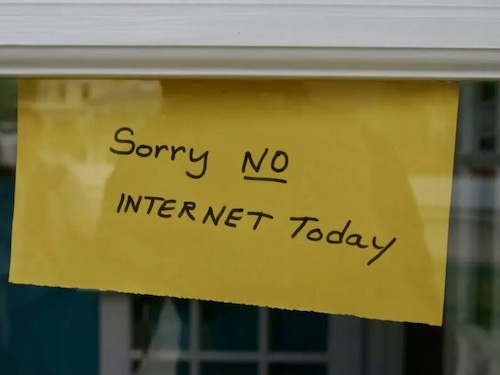


Brani
• Ecstasy by Rabbit Theft
• Found You by Time To Talk, Avaya & RYVM
La disinformazione è un po come un iceberg, c'è una piccola punta che affiora perché raggiunge migliaia e migliaia di persone, mentre invece ci sono tantissimi piccoli contenuti disinformativi che raggiungono decine o centinaia di persone, ecco questo noi lo vediamo tutti i giorni nel nostro lavoro.
Salve a tutti, siete all'ascolto di INSiDER - Dentro la Tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host, Davide Fasoli.
Oggi cercheremo di capire meglio cosa sono le fake news, le notizie false e quale ruolo gioca ovviamente la tecnologia ma anche il giornalismo e la politica nella loro propagazione.
Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a @dentrolatechnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito.
Martedì migliaia di siti di tutto il mondo, tra cui Amazon o Twitch, sono rimasti irraggiungibili per quasi un'ora.
Il problema riguardava un bug software di Fastly, società che si occupa di archiviare i siti dei clienti nei propri server per velocizzare il caricamento sui computer degli utenti.
Il bug è stato rilevato solo 40 minuti dopo le prime segnalazioni, ma tanto è bastato per creare di servizi all'85% dei clienti Fastly e ai cittadini di tutto il mondo.
Mercoledì scorso il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha revocato il ban imposto dalla precedente amministrazione Trump nei confronti di TikTok e WeChat.
L'obiettivo, prefissato dall'ex numero uno della Casa Bianca, puntava infatti ad escludere dagli store digitali e i social network, accusati entrambi di spionaggio e violazione della privacy.
Ad ogni modo, nonostante la linea dura di Trump sia stata respinta, le nuove intenzioni di Biden non sono da intendere come un via libera.
Anzi, l'attuale presidente ha infatti ordinato al Dipartimento del commercio USA un'ulteriore valutazione di sicurezza su WeChat e TikTok, in modo tale che i cittadini americani possano fruire di servizi sicuri volti alla tutela della privacy.
Viviamo in un mondo interconnesso in cui tutto influenza tutto e dove chiunque può creare e diffondere notizie, sia vere ma soprattutto false.
E quella delle fake news è forse una delle più grandi piaghe sociali dell'ultimo periodo e negli ultimi anni purtroppo nuove tecnologie stanno amplificando questo fenomeno.
Per approfondire questo tema e capire come contrastare le notizie false, siamo in compagnia di Giovanni Zagni, giornalista e direttore di Pagella Politica e di Facta.
Benvenuto a Giovanni.
Grazie, grazie.
Prima di iniziare, poco fa ti ho introdotto come direttore di Pagella Politica e di Facta.
Cosa sono quindi queste due realtà e di che cosa vi occupate al loro interno?
Dunque, Pagella Politica è un sito che si occupa di fact checking, cioè di verifica delle dichiarazioni politiche.
In particolare, diciamo, il focus di Pagella Politica, come suggerisce anche il nome, è un po limitato al mondo della politica, quindi quello che facciamo normalmente è prendere dichiarazioni pubbliche di personaggi pubblici, quasi esclusivamente di politici italiani di rilevanza nazionale e di verificare se quello che viene detto
è corretto in base ai numeri o al parere degli esperti o comunque ad atti di fatto facilmente verificabili e diciamo anche disponibili o a tutti, oppure anche che si possono trovare con un normale lavoro giornalistico, ad esempio se dei dati che servono a verificare una dichiarazione non sono pubblicamente disponibili, chiediamo alle autorità che se ne occupano e ce li facciamo dare.
Questo progetto è attivo già da parecchio tempo, è attivo dal 2012, fine del 2012 per inizi del 2013, invece quello che abbiamo lanciato solo un anno fa, che si chiama appunto Facta come dicevi, Facta.News, è un progetto che si occupa anche di disinformazione non necessariamente politica, perché abbiamo visto come ci saremmo accorti tutti che durante soprattutto le prime settimane, i primi mesi della pandemia
girava moltissima informazione non verificata magari sulle chat di gruppo o sui social network in generale e quella diciamo la verifica di quelle informazioni ci stava un po male sul sito di Pagella Politica che insomma tende a essere appunto associato più al mondo della politica, dell'economia, di altre questioni e quindi abbiamo creato una redazione separata che si occupa solo di disinformazione non politica e di approfondimenti collegati che è appunto il progetto Facta.
Ho capito e parliamo quindi di fake news, che cosa sono effettivamente e una notizia falsa? Come nasce e perché si presta a essere così popolare?
Beh, dunque, anzitutto per definire che cosa è una fake news la cosa più facile per definirla e pensandoci è pensarci come una scala di grigi, cioè tra le cose assolutamente vere come quella che non so, fuori dalla mia finestra c'è il sole e le cose completamente inventate come, non lo so, esistono i tirannosauri, cioè diciamo oggi, sono esistiti ma oggi non più, c'è una scala molto lunga di sfumature, di maggiore o minore verità, di quanto una notizia viene messa nel contesto corretto, quanto invece a volte ad esempio una notizia perfino satirica può essere presa sul serio.
Insomma, c'è una grandissima diversità di cose che poi alla fine producono il fenomeno che noi chiamiamo disinformazione.
Quindi, secondo me, una delle cose più importanti è non approcciarsi a questo problema come se si trattasse di un bianco e di un nero in cui c'è qualcuno che dice tutta la verità, qualcuno che dice solo balle e invece in mezzo non ci sono quelli in mezzo.
Come per molte cose, diciamo, il grosso si gioca al centro.
Quindi anche il nostro lavoro, soprattutto per esempio per pagina politica o per quanto riguarda le dichiarazioni politiche, le dichiarazioni politiche hanno sempre, magari partono da dei numeri corretti, ma poi hanno bisogno di contesto, hanno bisogno di essere precisate meglio, mentre invece poi un sacco di informazioni che girano magari nelle chat di gruppo, magari una foto o un video sono anche veri, cioè non sono stati creati ad arte, ma sono stati ad esempio scattati o ripresi in un altro momento, in un altro luogo, in un altro anno.
E poi per venire alla tua ultima domanda, cos'è che le fa così di successo? Anzitutto, le fake news seguono, la disinformazione segue la informazione ufficiale.
Quindi quando l'informazione mainstream o corretta, insomma come si vuole chiamare, ha cominciato a parlare di pandemia, poi tutta la disinformazione si è anche concentrata sul tema lì.
Quindi un'altra cosa che si può dire è che non è detto che sia aumentata la disinformazione durante la pandemia, semplicemente si è concentrata tutta su uno stesso tema e quindi l'abbiamo vista di più.
E poi ovviamente la disinformazione, essendo stata creata in qualche modo spesso da qualcuno, fa leva su dei meccanismi che la rendono per forza di cose più interessante.
Quindi ad esempio va a riempire un vuoto informativo, classico esempio.
Da dove viene il virus? proprio negli ultimi giorni stiamo parlando del fatto che è possibile che il virus che causa la Covid sia un virus creato in laboratorio, Facebook ha detto che non rimuoverà più chi dice, chi afferma questa cosa.
Ecco, chi lo dice da un anno semplicemente dava per sicure cose che non c'erano.
Quindi un anno fa la risposta più onesta alla domanda il virus è artificiale era non lo sappiamo, non si può sapere, non ci sono abbastanza prove.
Un contenuto disinformativo aveva gioco facile in quella incertezza, in quella mancanza di sicurezza intorno a un tema che interessava così tanto nel dire sì certo è stato creato qui qui e qui vi facciamo vedere e poi prendevano magari qualcosa fuori contesto e così via.
Quindi insomma è un po questo il meccanismo cercare di sfruttare qualcosa di cui il pubblico ha bisogno o cerca.
Sì quindi hai fatto questo esempio della scala dei grigi, la fake news è difficile da scovare soprattutto quando si trova nel mezzo, cioè quando è magari supportata da immagini o dati che sono reali ma che vengono decontestualizzati.
E a proposito di questo allora come si fa a riconoscere una fake news da una notizia vera e poi però c'è anche un altro tema che è quello della satira come si fa a riconoscere una fake news da una notizia invece che è che in realtà è un pezzo satirico.
Sì dunque secondo me aiuta moltissimo a chiarire queste ambivalenze soprattutto con la satira se si risale se si fa questo esercizio a volte un po difficile e a volte non banale di risalire alla fonte primaria dell'informazione cioè l'informazione che è scritta su un articolo online o su o riportato in un video su YouTube o qualunque detto in un podcast da dove arriva chi l'ha detta per primo e in questo modo ad esempio la satira si scopre quasi sempre che in realtà è satira perché se il primo luogo online in cui
quella notizia è comparsa è appunto un sito o satirico o assolutamente amatoriale e possibilmente satirico perché poi ci sono anche parecchi siti che si muovono diciamo un po in mezzo in un modo un po ambiguo e dicono quando poi una cosa diventa virale dicono è ma era satira comunque diciamo al di là di questi casi un po in mala fede quelli in buona fede è chiaro andando a vedere sul sito se si tratta di un sito ad esempio è successo in passato che notizie di Lercio che tutti noi conosciamo siano state prese per vero da testate anche più o meno rispettabili, c'era un titolo di parecchi anni fa che era stato ripreso da alcune testate online, non il Corriere della Sera
per intenderci però comunque da alcune testate online che diceva che radio Maria per errore aveva mandato una canzone dei Death, dei Megadeth e dei Cannigald Valkorps, una roba del genere che sono due vabbè gruppi metal violentissimi e quello lì all'inizio era una notizia di Lercio che qualcuno ha preso per vera, oppure è successo con una finta prima pagina di Repubblica un paio
di anni fa dopo il rogo dell'autobus a San Donato, c'era una finta prima pagina di Repubblica che prendeva in giro diciamo l'atteggiamento buonista nei confronti dell'immigrazione per semplificare e quella era stata presa per vera tanto che la stessa Repubblica aveva dovuto smentire quella notizia lì.
Quindi la ricerca della fonte secondo me è un'operazione non banale che è soprattutto online ma che risolve moltissimi dei dubbi.
Ci fai un esempio di come anche chi non è del vostro settore può cercare di risalire a come è nata una notizia.
Beh dunque nel caso di un articolo online di un articolo testuale su una testata o su un blog la cosa più semplice è cercare di capire nel testo se la fonte è esplicitata o meno.
cioè spesso ad esempio in articoli di giornale è riportata un'informazione e si dice secondo e poi il nome di chi l'ha e allora anche lì spesso si scoprono delle cose interessanti.
Ad esempio facciamo un esempio inventato un articolo che parla del boom delle crociere e poi vediamo che c'è scritto secondo una ricerca di una cosa che non abbiamo mai sentito commissionata da nome di una nota a compagnia di crociere.
Ecco in quel momento lì la fonte è esplicitata ma dovremmo renderci conto subito che non è una fonte molto affidabile.
Quindi diciamo è una lettura critica dei testi che aiuta molto spesso a capire.
Poi molto spesso invece la fonte non è esplicitata e allora lì bisogna cercare su google e è come dire è un caso in cui entrare in contatto con l'informazione è solo il primo passo per essere informati.
Ecco. E poi invece quando ci sono dei video o delle immagini di nuovo una ricerca inversa sui motori di ricerca che permettono di farlo ad esempio lo stesso google immagini oppure su TinEye basta che uno carica la foto su TinEye o su google immagini per cercare vedere dove è comparsa prima questa immagine e in molti casi si scopre quando le immagini sono state usate fuori contesto che è una cosa che succede spessissimo ed è uno degli strumenti principali della disinformazione non politica diciamo.
Purtroppo ci sono anche degli strumenti online come foto forensics ad esempio che permettono di vedere se un'immagine è stata manipolata quindi purtroppo non è un lavoro difficile ma un lavoro che richiede tempo e visto che molto spesso la disinformazione noi la condividiamo in due secondi perché leggiamo un titolo che ci fa ridere o vediamo un'immagine che ci colpisce è proprio questo fatto di fermarsi dedicare un attimo di più che poi è quello che ci espone di più ai rischi ecco.
E proprio collegandomi a questo tuo ultimo ragionamento e nonostante debbano essere principalmente i cittadini e imparare a riconoscere la veridicità o meno delle affermazioni che che trovano che leggono online una grande responsabilità possono avercela anche i giornali cioè come dovrebbero provare le grandi testate giornalistiche a tutelare i loro lettori da questo fenomeno.
Questo è una domanda molto molto spinosa perché dunque diciamo due cose la prima è che gran parte della disinformazione che viene spinta dalle testate è spinta nelle versioni online e poi non nelle versioni cartacee e poi è molto spesso in qualche modo limitata o comunque molto più diffusa nelle famose "colonnine destre" diciamo nel in quell'area del sito in cui si mettono le folle gli "strani ma veri" le cose buffe la foto strana e i siti dei quotidiani spesso hanno questa sezione e lì diciamo è anche la sezione in cui il controllo della qualità
editoriale un po si abbassa quindi una cosa importante da dire è che noi tendiamo a pensare ai siti di informazione come a dei luoghi in cui si trova molta disinformazione in realtà diciamo i casi più estremi si trovano solo in sezioni molto limitate dei siti.
L'altra cosa molto importante da dire è che il giornalismo e le informazioni online è un tipo di informazione che da un lato è molto a un certo grado di tecnica cioè bisogna essere in grado di usare alcuni strumenti, alcuni siti, bisogna sapere molto bene l'inglese, bisogna sapere dove cercare le informazioni ad esempio quando si tratta di eventi internazionali, quindi ha un livello di tecnicismo elevato di per sé ma è anche un grado di tecnicismo che è molto diverso dal
giornalismo tradizionale quindi purtroppo nelle redazioni dei quotidiani spesso succede che le competenze che servono per lavorare online ce le hanno solo i giovani, ce le hanno solo quelle che lavorano nell'online e non vengono molto considerati per cui poi si lascia che in alcuni settori rimango un certo livello di approssimazione e di sciatteria che non sarebbe magari consentito o permesso scrivendo un articolo per il cartaceo.
Quindi insomma il punto principale è che è vero che i media tradizionali hanno una responsabilità in questo tipo di cose ma è anche vero che è una conseguenza del fatto che nel nostro panorama informativo sono anche molto meno centrali.
cioè noi stessi ci informiamo in molti luoghi e magari solo una percentuale relativa di questi luoghi sono le grandi estate.
Noi abbiamo informazioni magari perché ce le andiamo a prendere su Twitter o su Instagram o ce le andiamo a cercare sui siti esteri che preferiamo.
Quindi come dire è se vogliamo uno dei tanti effetti un po della crisi che sta attraversando in questi anni il settore dei media tradizionali.
E siccome abbiamo parlato all'inizio di appunto Pagella Politica e Facta mi ricollego per farti una domanda sempre sul tema.
Siccome finora abbiamo parlato in generale di giornalismo qual è il ruolo in relazione alle fake news dei media tradizionali e della politica?
Dunque diciamo che il ruolo dei politici e dei media è un ruolo molto peculiare perché non è un ruolo in prima battuta di produttori.
cioè il giornale, la trasmissione televisiva o anche il politico tendenzialmente non ha un ruolo di produrre notizie inventate però nella diffusione della disinformazione ha un ruolo cruciale nella diffusione.
cioè un bello studio del Reuter Institute dell'università di Oxford che ha proprio messo l'accento su questi super diffusori.
Cosa sono? La notizia falsa o decontestualizzata o la leggenda metropolitana nasce da qualche altra parte.
Mettiamo in un oscuro blog o su un sito che è controllato da qualche altro stato o da insomma un luogo in cui è chiara la malafede ed è chiara un po perché quella notizia è nata e che cosa vuole dire.
Poi un politico, una trasmissione televisiva di prima serata, un grande sito di informazione, in qualche modo trovano questa notizia falsa o decontestualizzata e così via e la ripropongono.
Magari la ripropongono anche in modo neutro.
La ripropongono dicendo guardate cosa è successo lì o guardate cosa si dice sul web che pure è una roba, una formula assurda che viene usata tantissimo nei media tradizionali ma che non vuol dire niente ovviamente perché come dire cosa si dice per strada si ma che strada cioè cos'è un pettegolezzo comunque al di là di questo e in quel momento improvvisamente per il fatto di riproporlo e per il fatto di avere ancora un grande pubblico raggiungono milioni di persone.
Ti faccio un esempio molto concreto.
Tutta la storia della disinformazione sui vaccini in Italia che ha radici molto vecchie perché viene dall'estero in realtà nelle ultime tipologie nascono in Inghilterra o negli Stati Uniti come contenuto più o meno una ventina di anni fa.
Ma in Italia perché è diventata famosa ad esempio la disinformazione sui vaccini e quando è che è diventato famoso una persona come Roberto Burioni che è il più famoso diciamo anti anti vaccinista della prima ora molti anni fa già prima della pandemia? Beh c'è stato un momento molto chiaro, c'è stato un si potrebbe trovare il giorno e l'ora, c'è stata una trasmissione televisiva di prima serata che ha invitato un noto un noto cantante che ha esso posizioni diciamo un po bizzarre per quanto riguarda i vaccini e la scienza e mi riferisco a Red Ronnie il quale ha fatto una tirata dicendo che dei vaccini non ci si doveva fidare.
Burioni che era allora uno sconosciuto medico del San Raffaele ha risposto il giorno dopo con un lungo post su Facebook in cui diceva che era una vergogna che una televisione di prima serata mandasse quelle cose lì.
Quello è stato il momento in cui da un lato è diventato molto famoso Roberto Burioni da quel giorno lì in poi perché il post è diventato virale ma dall'altro c'è stato un altro momento di super diffusione di contenuti di disinformazione e quindi quello al ruolo dei media tradizionali per tornare alla tua domanda e anche dei politici pensiamo tutte le volte in cui un politico riprende
un contenuto virale sui vaccini sulle cose perché magari c'è del marcio ecco appena lo fa quel contenuto raggiunge milioni di persone e magari altrimenti senza di lui o di lei sarebbe rimasto limitato a poche centinaia o poche migliaia di persone perché ci sono ogni giorno tantissimi contenuti di disinformazione che vengono prodotti ma la disinformazione è un po come un iceberg.
C'è una piccola punta che affiora perché raggiunge migliaia e migliaia di persone, mentre invece ci sono tantissimi piccoli contenuti disinformativi che raggiungono decine o centinaia di persone.
Ecco questo noi lo vediamo tutti i giorni nel nostro lavoro su Fatta.
E qual è il senso l'opportunità di diffondere una notizia falsa? Quali possono essere le motivazioni?
Beh dunque ci sono motivazioni strumentali come la disinformazione diffusa ad esempio per danneggiare una campagna politica di un paese, cosa che si è vista negli Stati Uniti, soprattutto al giro prima, non tanto le ultime lezioni ma quelle del 2016 molto di più.
Oppure ci sono quelli che lo fanno per fare soldi, perché se tu riesci a portare milioni di persone su un sito, o centinaia di persone su un sito, o migliaia su un blog di WordPress, se lo riempi di Google Ads, di pubblicità, ti fai due due lire.
Eppure qui ci sono un sacco di questi casi.
Ci sono infine casi evidenti di truffe.
Noi vediamo molto frequentemente messaggi virali che dicono il tal supermercato sta regalando buoni da 100 euro, clicca qui per averlo e arriva un via sms, ci vengono segnalati dai lettori e poi quelle sono vere e proprie truffe.
Ma questo secondo me, se noi mettiamo insieme tutte queste cose tra virgolette "strumentali", forse non raggiungiamo neanche la maggioranza della disinformazione, perché in realtà la gran parte delle motivazioni per cui viene prodotta è perché noi ci informiamo e diffondiamo informazioni non tanto con il mero obiettivo di informarci su una cosa, come se fossimo dei fogli excel, ma perché vogliamo costruire uno un'immagine del mondo e due un'immagine di noi stessi fuori.
Quindi se noi troviamo un contenuto disinformativo che però sostiene quello che noi pensiamo, perché ci aiuta a fare il nostro punto politico, tipo siamo contrari a troppo interesse, troppa attenzione al politicamente corretto, come lo si vuole chiamare, nei cartoni animati, leggiamo la notizia di Biancaneve che potrebbe essere tolta dai cataloghi perché viene baciata, il bacio non è consenziente, no, la bella addormentata nel bosco.
Allora noi non ce ne frega niente se è vera o meno in quel momento, ci interessa che fa un punto che vorremmo fare, è come se lo usassimo per sostenere delle nostre argomentazioni nel continuo discorso che noi facciamo sul mondo attraverso i social e quindi la postiamo e in quel momento stiamo contribuendo a diffondere magari notizie inesatte eccetera, ma il punto essenziale qui è che i motori principali proprio psicologici dell'uomo nell'informarsi e nel diffondere informazioni quasi mai sono quelli di effettivamente conoscere i fatti, ma molto più spesso sono di far capire chi sono, far capire come la penso, cercare di portare a casa una discussione.
Sì diciamo che tra notizie vere e notizie false ce ne sono per tutti i gusti e penso allo stesso tempo che faccia molto comodo rafforzare una propria idea con un pezzo, con una notizia, con un articolo che che appare appunto apparentemente come vero.
Per concludere però noi cittadini possiamo fare altro, c'è qualcos'altro oltre a quello che ci hai detto finora che possiamo fare per tutelarci, tutelare poi anche la nostra società e a proposito di società si può fare anche qualcosa da un punto di vista legislativo per ridurre questo fenomeno?
Dunque come cittadini diciamo che la cosa principale da fare a parte quelle cose tecniche che citavamo prima, controllarsi una foto è stata pubblicata veramente quel giorno lì eccetera eccetera, la cosa principale sembra una contraddizione ma forse informarsi meno, informarsi meglio, in senso di scegliere un po più accuratamente i luoghi da cui accettiamo
che ci arrivi le informazioni sui fatti d'attualità, perché se noi semplicemente ci mettiamo su Instagram o su Twitter così senza filtro ci piovono addosso tonnellate di informazioni e ci sono è stato anche riconosciuto che questa situazione porta un sovraccarico di informazioni che rende più difficile anche districarsi.
Per quanto riguarda invece l'aspetto legislativo, io sono fermamente convinto che tutte le autorità dovrebbero restare fuori da questa sfera per il semplice fatto che tutte le volte in cui dire la bugia non è un reato e dire una falsità se non diffama nessuno non dovrebbe essere la legge a stabilire se un'informazione è corretta o meno, ma dovrebbe essere diciamo la libera discussione tra i cittadini delle idee, quindi qui bisogna avere la fiducia che l'informazione buona scacci quella cattiva, parafrasando il detto economico sulla moneta che invece è il contrario, ma in cui bisogna sperare che
l'informazione buona scacci quella cattiva, bisogna tenere secondo me l'autorità fuori legislativa, fuori da questo processo perché in tutti i casi dire che cosa si può non si può dire è una limitazione della libertà di espressione ed è una censura e questa cosa per fortuna noi nella nostra società non la vogliamo e non la dovremmo accettare.
Va bene Giovanni, grazie per questo tuo interessantissimo intervento su un tema che ci è molto a cuore, a presto.
Grazie mille a voi e a soliti a tutti, alla prossima.
E così si conclude questa puntata di INSiDER - Dentro la Tecnologia.
Io ringrazio come sempre la redazione e in special modo Matteo Gallo e Luca Martinelli che ogni sabato mattina ci permettono di pubblicare un nuovo episodio.
Per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione@dentrolatecnologia.it , seguiteci su Instagram a @dentrolatecnologia, dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti in qualsiasi caso nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social se trovate interessante il podcast condividetelo che per noi è un ottimo modo per crescere e non dimenticate di
farci pubblicità. Noi ci sentiamo la settimana prossima.