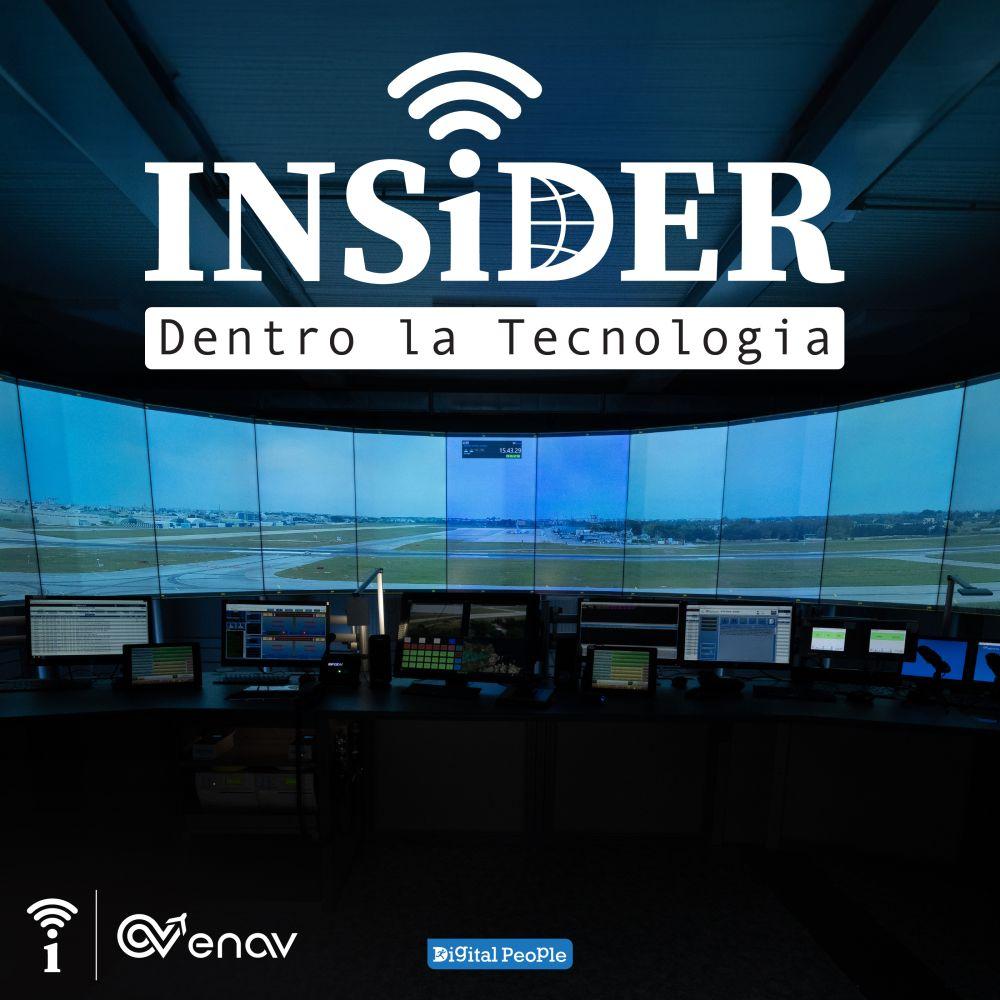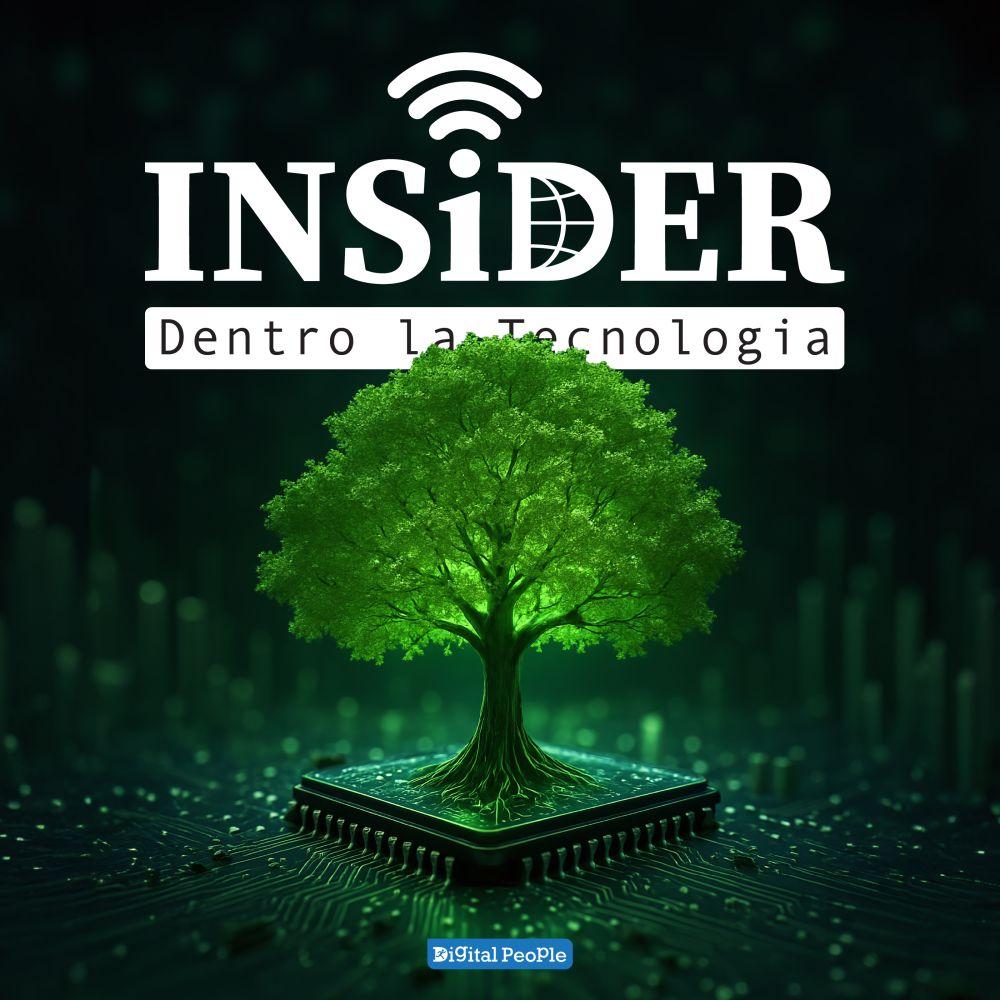In un'epoca in cui la connettività e la geolocalizzazione sono diventate elementi imprescindibili della quotidianità, i Sistemi di Navigazione Satellitare Globale, o più semplicemente GNSS, rappresentano un'infrastruttura tecnologica strategica senza la quale molti servizi non potrebbero esistere e aiutarci nelle attività di tutti i giorni. Ci basti pensare che dietro il semplice gesto di consultare un’app di navigazione o di ricevere un pacco acquistato online si nasconde una vastissima rete di satelliti in perfetta sinergia tra di loro che fornisce istantaneamente dati di posizionamento estremamente precisi. Ma che cosa sono i GNSS e qual è la differenza con il GPS di cui sentiamo parlare tutti i giorni? In questa puntata proviamo a capirlo.
Nella sezione delle notizie parliamo dei nuovi Tutor 3.0 autostradali, dello studio del CNR per trasformare la luce in un solido e infine della missione delle sonde spaziali Voyager e di come la NASA stia cercando di allungare il più possibile la sua durata.




Immagini
• Foto copertina: ESA - P. Carril
Brani
• Ecstasy by Rabbit Theft
• Not Enough by Near x Far
Salve a tutti, siete all'ascolto di INSiDER - Dentro la Tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host, Davide Fasoli.
Oggi parleremo dei principali Sistemi di Navigazione Satellitare Globali, i GNSS, per capire come funzionano e perché sono così cruciali in ambito civile e militare.
Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a @dentrolatecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina, su Spotify, Apple Podcast, YouTube Music oppure direttamente sul nostro sito.
Sono entrati in funzione i nuovi Tutor 3.0 su 26 tratte autostradali italiane, portando il monitoraggio della velocità a un livello superiore grazie a tecnologie più avanzate e precise.
Basato sulla piattaforma Navigard, questo sistema non si limita a calcolare la velocità media dei veicoli, ma è anche in grado di individuare sorpassi pericolosi, il mancato rispetto della corretta posizione nelle corsie e la presenza di veicoli contromano.
L'installazione dei Tutor ha dimostrato negli anni un impatto significativo sulla sicurezza stradale.
Dopo l'introduzione, il tasso di mortalità sulle tratte coperte si è ridotto del 56% e oggi si registra un calo dell'81% su tutta la rete autostradale.
Con questa nuova espansione, la copertura complessiva raggiunge circa 1800 km, garantendo un controllo più efficace della sicurezza stradale.
Dotato di sensori e algoritmi sofisticati, il nuovo Tutor 3.0 opera anche in condizioni di scarsa visibilità e si adatta automaticamente ai limiti di velocità variabili in caso di maltempo.
Un'innovazione che segna un ulteriore passo avanti nella digitalizzazione del controllo autostradale, con l'obiettivo di ridurre il numero di incidenti e migliorare la sicurezza per tutti gli automobilisti.
Dei ricercatori del CNR, il Consiglio Nazionale della Ricerca italiano, sono riusciti per la prima volta a, tra virgolette "solidificare" la luce.
In particolare, lo studio si è basato sul precedente lavoro del ricercatore Danielle Sanvitto, che ha già 10 anni fa dimostrato come la luce potesse comportarsi come un fluido.
E partendo da questo studio, il team del CNR è riuscito a creare quello che viene definito un "supersolido quantistico", ossia un particolare materiale con viscosità zero, caratteristica peculiare dei superfluidi, e al contempo una struttura cristallina, osservabile nei materiali solidi.
Per raggiungere questo risultato è stato utilizzato un laser che, interagendo con un semiconduttore formato da tante creste strette, ha dato origine a delle particelle chiamate "polaritoni", formando così il nuovo materiale.
Da questo momento i ricercatori si impegneranno quindi a studiare meglio le caratteristiche e le proprietà del supersolido basato sui fotoni, per comprendere a fondo le potenzialità di questo materiale, approfondire le nostre conoscenze sugli stati della materia e trovare nuove applicazioni nella tecnologia quantistica.
Le sonde Voyager sono le esploratrici del sistema solare esterno che più hanno viaggiato lontano dalla Terra, e dopo 47 anni di attività prolungata, la NASA sta continuando a cercare soluzioni per mantenerle operative il più a lungo possibile.
La scorsa settimana i tecnici del Jet Propulsion Laboratory hanno annunciato lo spegnimento del Cosmic Ray Subsystem Experiment a bordo di Voyager 1, mentre il prossimo 24 marzo verrà disabilitato il Low-Energy Charged Particle Instrument di Voyager 2.
Con lo spegnimento di questi tre sistemi, entrambe le sonde rimarranno con solo tre strumenti scientifici attivi.
Tuttavia, ciò dovrebbe garantire un'estensione delle due missioni per almeno un altro anno, prima di dover disabilitare altre funzioni.
In realtà, lo strumento disabilitato su Voyager 1 rimarrà ancora operativo su Voyager 2 e viceversa, e ciò garantirà un risparmio energetico senza compromettere la perdita totale di entrambe le funzionalità.
Il problema delle Voyager è che la potenza iniziale disponibile, di 470 Watt, si è ridotta drasticamente negli ultimi anni, con un tasso di 4 Watt all'anno, ma dal momento che si tratta degli unici due veicoli ad aver mai raggiunto lo spazio
interstellare, al di fuori del Sistema Solare, la NASA punta ad aumentarne la longevità per ottenere altre informazioni.
I tecnici della NASA hanno previsto che, lasciando le due sonde con un solo strumento operativo, nel prossimo futuro sarà possibile estendere il programma di esplorazione spaziale delle Voyager anche oltre il 2030.
In un'epoca in cui la connettività e la geolocalizzazione sono diventati elementi imprescindibili della quotidianità, i Sistemi di Navigazione Satellitare Globale, Global Navigation Satellite System, o più semplicemente GNSS, rappresentano oggi
un'infrastruttura tecnologica strategica senza la quale molti servizi non potrebbero esistere e aiutarci nelle attività di tutti i giorni.
Ci basti pensare che dietro il semplice gesto di consultare un'app di navigazione o di ricevere un pacco acquistato online, si nasconde una vastissima rete di satelliti in perfetta sinergia tra loro che fornisce istantaneamente dati di posizionamento estremamente precisi.
Ma cosa sono i GNSS e qual è la differenza con il GPS di cui sentiamo parlare tutti i giorni?
Per definizione un GNSS è un sistema di geo-radiolocalizzazione e navigazione terrestre, marittima o aerea, che utilizza una rete di satelliti artificiali in orbita e trasmettitori specifici chiamati pseudoliti, utilizzati in questo caso per incrementare la copertura in ambienti ostili o indoor.
Questi sistemi forniscono dunque un servizio di posizionamento geo-spaziale, a copertura globale, che attraverso l'elaborazione di segnali a radiofrequenza emessi da satelliti consentono a dei ricevitori, come i nostri smartphone, di determinare le
coordinate geografiche su un qualunque punto della superficie terrestre, con un errore di pochi metri.
Il principio fondamentale su cui si basano questi sistemi è relativamente semplice ma altrettanto ingegnoso.
Attraverso la misurazione del tempo impiegato dai segnali radio per viaggiare dai satelliti al ricevitore, quest'ultimo può calcolare con precisione la propria posizione tridimensionalmente in forma di latitudine, longitudine e altitudine sulla superficie terrestre.
Tuttavia, per determinare con accuratezza la posizione di un ricevitore, sono necessari almeno 4 satelliti visibili contemporaneamente, di cui tre per le coordinate spaziali e un quarto per la sincronizzazione temporale.
Quest'ultimo aspetto è infatti garantito dalla presenza di orologi atomici estremamente precisi, di cui avevamo parlato nell'approfondimento estivo: "Scandire il tempo con gli orologi atomici", che risultano perciò essenziali per garantire l'accuratezza delle misurazioni temporali nell'ordine dei nanosecondi.
I segnali GNSS, infatti, viaggiano alla velocità della luce a 300.000 km al secondo e contengono informazioni cruciali come l'identità del satellite emittente, la sua posizione orbitale e il timestamp di trasmissione.
Il ricevitore, perciò, elaborando questi dati provenienti da più satelliti, può triangolare la propria posizione con un margine di errore che nei sistemi più avanzati può ridursi persino a pochi centimetri.
Per la loro duttilità, i GNSS non sono solo un motore di innovazione tecnologica su molteplici settori economici, ma costituiscono una colonna portante anche nel settore dell'economia spaziale globale, tant'è che nel 2023 i GNSS hanno rappresentato
circa il 56,3% del mercato globale della Space Economy, con un valore stimato di 260 miliardi di dollari.
Ma si prevede che entro il 2033 i ricavi globali raggiungeranno persino i 580 miliardi di euro, con una crescita trainata principalmente dai servizi "downstream" relativi alla fruizione di informazioni derivanti dai dati ottenuti dallo spazio.
Ritornando alla domanda iniziale, relativa alla differenza tra GNSS e GPS, possiamo definire i primi con un termine più ampio, che incapsula diversi tipi di sistemi di navigazione satellitare mentre il GPS come uno specifico GNSS, sviluppato in questo caso dagli Stati Uniti.
Attualmente esistono quattro principali sistemi GNSS pienamente operativi, ciascuno sviluppato e gestito da diverse potenze globali.
Questi sistemi, pur condividendo principi di funzionamento simili, presentano caratteristiche distintive in termini di copertura, precisione e applicazioni specifiche.
Il primo sistema contrapposto a quello degli Stati Uniti è il GLONASS della Russia, avviato durante l'era sovietica negli anni '70, il quale ha raggiunto la piena operatività nel 1995, per poi subire un declino significativo a causa delle difficoltà economiche del periodo post-sovietico.
Nel 2012, grazie a ingenti investimenti governativi, GLONASS è tornato pienamente operativo, con una costellazione di 24 satelliti operativi distribuiti su tre piani orbitali a circa 19.100 km di altitudine.
La precisione di GLONASS raggiunge i 3-7 metri per gli utenti civili, che risulta leggermente inferiore al GPS nelle condizioni standard, ma offre prestazioni superiori alle alte latitudini, rendendolo particolarmente utile nelle regioni artiche e sub-artiche.
A livello intermedio - geograficamente parlando - si colloca invece il sistema europeo GALILEO, che rappresenta uno tra i GNSS più recenti nonché tra i più tecnologicamente avanzati.
Sviluppato dall'Unione Europea in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea, GALILEO, a differenza di GPS e GLONASS, che hanno origini militari, è stato concepito fin dall'inizio come un sistema per un utilizzo esclusivamente civile.
La sua concezione deriva infatti da una serie di conseguenze scaturite durante il periodo della Guerra Fredda, con lo sviluppo dei primi sistemi di posizionamento satellitari, delle due principali superpotenze per applicazioni militari.
Come accennato poco fa, però, in seguito alla caduta dell'Unione Sovietica, il sistema GLONASS non è stato più mantenuto in perfetta efficienza, rendendo così il GPS l'unico sistema di posizionamento satellitare disponibile praticamente in tutto il mondo.
Con l'obiettivo di staccarsi dal monopolio statunitense, l'Europa ha perciò deciso di investire sul progetto GALILEO, avviato ufficialmente il 26 maggio 2003.
A differenza del GPS, che potenzialmente potrebbe essere limitato o perfino sospeso nei confronti delle altre nazioni, GALILEO, come dicevamo, è rivolto soprattutto al servizio civile e commerciale, e per questo sempre disponibile gratuitamente, sia per i civili che per i militari.
L'entrata in servizio dal 2019 è stata anticipata al 2016, e attualmente il sistema europeo vanta una costellazione di 30 satelliti, di cui 24 operativi e sei di scorta, ed è capace di fornire un grado di accuratezza molto elevato nelle tre direzioni.
GALILEO è stato inoltre progettato per essere interoperabile con il GPS, caratteristica che di fatto consente una maggior precisione rispetto a quest'ultimo, poiché i satelliti complessivi a disposizione sono quasi il doppio.
Grazie a questa elevata disponibilità di satelliti, viene garantito un servizio di geolocalizzazione più costante e capillare, anche in ambienti a copertura limitata, come nei centri abitati, dove è più comune il fenomeno del "canyon urbano",
ovvero l'oscuramento parziale dei segnali GNSS da parte degli edifici, soprattutto quelli più alti e ravvicinati.
Infine, essendo di fatto un servizio europeo, la copertura di GALILEO risulta migliore del GPS in alcune aree geografiche, soprattutto nella regione del Nord Europa.
Il pioniere del GNSS, però, è proprio il GPS, ovvero il sistema di posizionamento globale più conosciuto e utilizzato al mondo.
Sviluppato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti a partire dagli anni '70, il Global Positioning System è diventato pienamente operativo nel 1994.
La costellazione Standard prevede 24 satelliti, più alcuni di riserva, disponibili su sei piani orbitali a circa 20.200 chilometri di altitudine, con un periodo orbitale di 12 ore.
I servizi offerti dal GPS sono di due tipologie, i Servizi di Posizionamento Standard, o SPS, disponibile gratuitamente per uso civile con una precisione che raggiunge oggi i 3-5 metri in condizioni ottimali, e il Servizio di Posizionamento Avanzato,
o PPS, riservato agli utenti autorizzati, principalmente militari, con una precisione superiore e caratteristiche anti-jamming avanzate.
In termini di funzionamento, il sistema si compone di 3 segmenti principali.
Il segmento spaziale comprende una costellazione satellitare distribuita su diversi piani orbitali, in modo tale che ogni utilizzatore possa acquisire il segnale di almeno 5 satelliti.
Il segmento di controllo racchiude invece diversi elementi a terra, tra cui una stazione principale, un'alternativa, 4 antenne terrestri dedicate, più 6 stazioni di controllo, ognuna delle quali possiede un ruolo essenziale nel garantire il monitoraggio e la gestione dell'intera costellazione.
Il segmento dell'utenza infine è rappresentato dai ricevitori militari che usano il PPS, e i milioni di ricevitori, come gli smartphone, utilizzati a scopo civile, commerciale o scientifico e che fanno uso dell'SPS.
Il quarto sistema di navigazione satellitare degno di nota è il recente BeiDou, di origine cinese, che ha completato il suo dispiegamento globale nel 2020.
La configurazione attuale comprende 35 satelliti distribuiti su tre orbite.
Tre satelliti sono collocati in orbita geostazionaria, a 35.000 km, altri tre in orbita geosincrona, mentre i restanti 29 in quella media, a circa 21.000 km.
Questa configurazione unica consente a BeiDou di offrire sia servizi globali che servizi regionali potenziati, con una precisione di posizionamento di circa 2,5 metri a livello globale e 1 metro nella regione Asia-Pacifico.
Una caratteristica distintiva di BeiDou è anche la capacità di messaggistica bidirezionale, che permette agli utenti non solo di ricevere informazioni di posizionamento, ma anche di inviare brevi messaggi, con fino 1.200 caratteri cinesi, attraverso il sistema satellitare.
Una domanda che potrebbe sorgere spontanea a questo punto della puntata è: quale GNSS utilizza il mio smartphone quando utilizzo la navigazione sulle mappe satellitari?
Attualmente, grazie agli accordi di interoperabilità citati prima nel caso di GALILEO, i nostri smartphone sfruttano più di una costellazione GNSS contemporaneamente.
Infatti, gli smartphone sono equipaggiati con ricevitori multi-GNSS, che possono ricevere e processare segnali da diverse costellazioni, così da migliorare l'accuratezza e l'affidabilità del posizionamento.
Nonostante però l'utilizzo di più costellazioni per migliorare il servizio, ad oggi esistono diversi metodi, utilizzati soprattutto a livello militare, per interferire con la triangolazione della posizione.
Uno dei più diffusi è il jamming, che abbiamo citato prima, e che consiste nel disturbare tramite interferenze i segnali elettromagnetici che arrivano a Terra da parte dei satelliti.
Esistono però altre tecniche particolarmente avanzate, definite di spoofing, che consentono persino di generare falsi segnali GNSS per ingannare i ricevitori e facendo loro credere di trovarsi in una posizione diversa da quella reale.
A livello orbitale, invece, i satelliti GNSS possono essere bersaglio di attacchi fisici ed elettronici, oppure da eventi spaziali come tempeste solari o detriti che possono degradare significativamente la qualità dei segnali satellitari.
In ogni caso, il futuro dei sistemi di navigazione satellitare si prospetta ricco di innovazioni tecnologiche, che saranno orientate sia al miglioramento e all'estensione dell'infrastruttura, ma anche alla protezione della stessa contro le minacce citate poco fa.
Se i segnali più potenti e resistenti alle interferenze consentiranno di ridurre i fenomeni di jamming, l'aumento del grado di interoperabilità tra i diversi sistemi assumerà un ruolo chiave nel garantire ai civili un servizio più efficiente e ottimizzato, soprattutto nelle aree difficilmente coperte da una singola costellazione.
Per concludere, i Sistemi di Navigazione Satellitare Globali rappresentano uno degli esempi più emblematici di infrastrutture tecnologiche che sono diventate indispensabili per il funzionamento della società contemporanea, soprattutto in un periodo di forte instabilità geopolitica come quello attuale.
Anche se è praticamente impossibile prevedere quale sarà il contesto futuro, una delle criticità che potrebbe minare l'efficienza dell'attuale infrastruttura potrebbe essere una crescente frammentazione dell'ecosistema GNSS da parte delle
principali superpotenze, ognuna delle quali dotate di un proprio sistema di posizionamento potenzialmente autonomo e autosufficiente.
Grazie anche al loro ruolo strategico, soprattutto a livello militare, i GNSS diventeranno sempre più oggetto di competizione tecnologica e militare.
Già oggi assistiamo infatti a episodi di jamming e spoofing in zone di conflitto come l'Ucraina o il Mar Nero, dimostrando come il controllo del posizionamento satellitare sia diventato parte integrante della guerra ibrida moderna.
La cosa certa è che la loro continua evoluzione plasmerà significativamente il futuro tecnologico dell'umanità, influenzando settori che spaziano dai trasporti, all'agricoltura, alle telecomunicazioni oltre che all'ambito militare.
Comprendere perciò il funzionamento e le implicazioni di questi sistemi è essenziale per apprezzare a pieno la complessità dell'ecosistema tecnologico in cui viviamo e per affrontare consapevolmente le sfide di un futuro tutt'altro che prevedibile.
E così si conclude questa puntata di INSiDER - Dentro la Tecnologia, io ringrazio come sempre la redazione e in special modo Matteo Gallo e Luca Martinelli che ogni sabato mattina ci permettono di pubblicare un nuovo episodio.
Per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione@dentrolatecnologia.it, seguiteci su Instagram a @dentrolatecnologia dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti.
In qualsiasi caso nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social.
Se trovate interessante il podcast condividetelo che per noi è un ottimo modo per crescere e non dimenticate di farci pubblicità.
Noi ci sentiamo la settimana prossima.