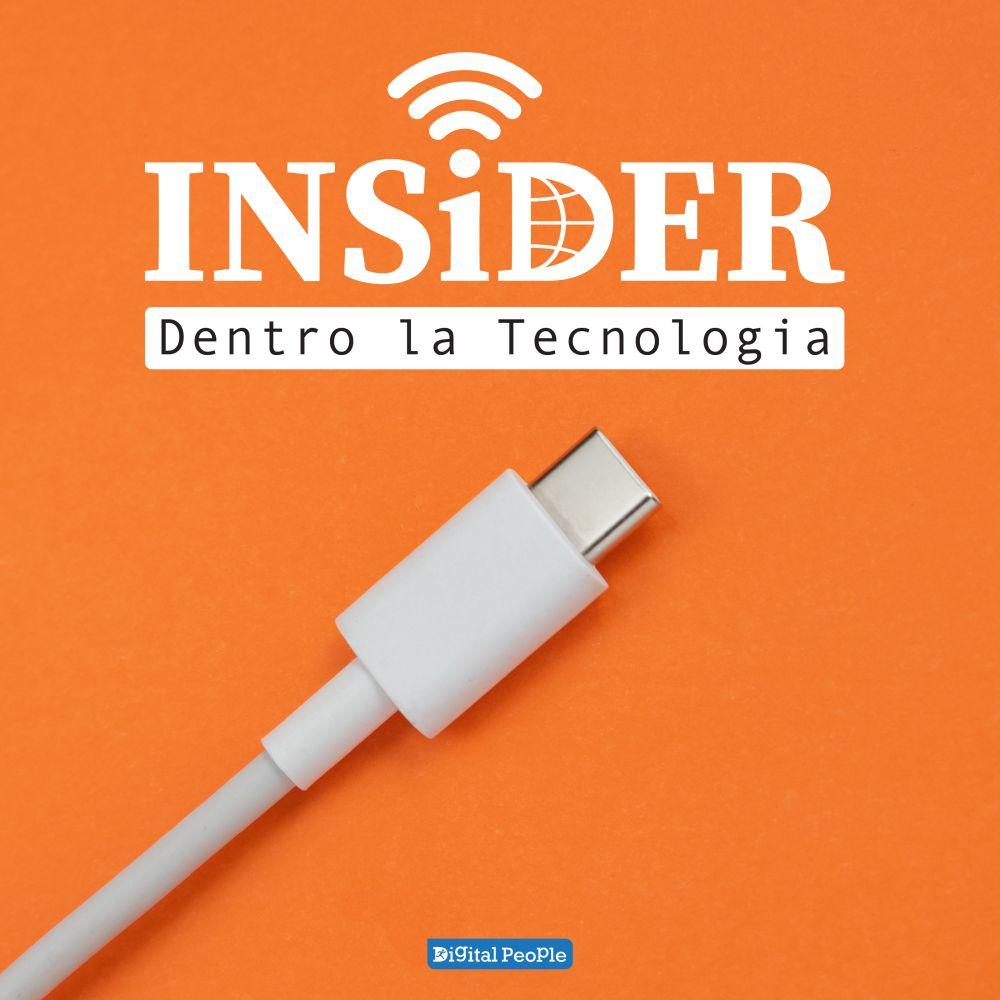Il ciclo di consumo della tecnologia "usa e getta" sta sollevando crescenti preoccupazioni economiche, ambientali e sociali. Mentre in passato si tendeva a conservare e riparare gli oggetti, oggi siamo immersi in una cultura che spinge verso la sostituzione rapida dei dispositivi, spesso resa necessaria da design che privilegiano l'estetica a discapito della riparabilità. In questa puntata esploriamo il movimento per il diritto alla riparazione, le recenti normative europee come la direttiva UE 2024/1799 e come le aziende tech si stiano adattando a questo cambiamento. Analizziamo anche esempi virtuosi come Fairphone, progettati fin dall'inizio per essere facilmente riparabili e vediamo come i consumatori possano contribuire a questa trasformazione culturale.
Nella sezione delle notizie parliamo del decreto attuativo firmato per disciplinare l'utilizzo dell'Alcolock, degli smartwatch che sono sempre più al centro dell'attività sportiva e infine del parere della Commissione Europea su Piracy Shield.




Immagini
• Foto copertina: Bublikhaus su Freepik
Brani
• Ecstasy by Rabbit Theft
• Royalty (Don Diablo Remix) by Egzod & Maestro Chives
Salve a tutti, siete all'ascolto di INSiDER - Dentro la Tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host, Davide Fasoli.
Oggi parleremo del diritto alla riparazione dei dispositivi elettronici di consumo, come i nostri smartphone, tablet ed elettrodomestici, esplorando quelli che sono i vantaggi ma anche gli svantaggi di un settore tecnologico aperto alla riparabilità e alla modularità.
Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a @dentrolatecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina, su Spotify, Apple Podcast, YouTube Music oppure direttamente sul nostro sito.
Nell'ultima riforma del Codice della Strada voluta dal Ministro dei Trasporti è stato introdotto l'obbligo di installazione dell'Alcolock sulle auto dei conducenti sanzionati in precedenza per aver guidato con un tasso alcolemico maggiore di 0,8 grammi per litro.
Questo dispositivo ha infatti lo scopo di bloccare l'accensione del veicolo nel caso in cui l'alcol test effettuato tramite questo strumento riporti un tasso alcolemico superiore a tale soglia.
Nonostante l'introduzione avvenuta tramite la riforma del Codice della Strada, l'installazione dell'Alcolock doveva ancora essere ufficializzata.
Ma qualche giorno fa il ministro Salvini ha firmato il decreto attuativo che ne disciplina i criteri di utilizzo.
Innanzitutto potrà essere installato su diverse categorie di veicoli adibiti al trasporto sia di persone che di merci e dovrà per questo rispettare anche la normativa sovranazionale.
Infine gli installatori autorizzati avranno un ruolo chiave nella gestione dell'intero sistema, i quali dovranno fornire le istruzioni dettagliate per l'installazione, l'uso e la manutenzione del dispositivo.
Come abbiamo più volte sottolineato nel corso degli ultimi anni, in puntate come "Smartwatch per sport estremi, un settore in continua evoluzione", gli orologi smart non hanno acquisito una centralità solo per la gestione ottimizzata delle notifiche, ma anche per il monitoraggio delle attività sportive.
L'indagine European Health Behavior Survey 2025, condotta da Ipsos, ha evidenziato che infatti più dell'80% delle persone che indossano uno smartwatch ha cambiato le proprie abitudini, incrementando l'attività fisica e prestando maggiore attenzione alla qualità del sonno.
In particolare tra gli utenti intervistati il 53% ha rivelato di controllare con regolarità la propria frequenza cardiaca, mentre il 68% di monitorare quotidianamente l'attività fisica.
Questo cambio di prospettiva si sta riflettendo positivamente anche sul mercato degli smartwatch, poiché tra l'elevata offerta e i costi sempre più accessibili, le persone risultano ancora più motivate a scegliere il modello più adatto alle
proprie esigenze, trasformando la semplice curiosità in un acquisto concreto per prendersi cura del proprio benessere.
Quello di Piracy Shield è un tema che abbiamo seguito con particolare interesse attraverso le notizie di questo podcast, raccontandone gli sviluppi ma anche gli evidenti problemi, che non poche volte hanno causato gravi disservizi ai cittadini.
E proprio su questo punto si è espressa anche la Commissione Europea attraverso una lettera indirizzata al Ministro degli Esteri.
Nella lettera, l'UE non boccia Piracy Shield, e anzi, elogia gli sforzi che l'Italia sta facendo per combattere la pirateria online e la rapidità che lo strumento utilizzato permette nel bloccare immediatamente i contenuti illeciti dagli eventi sportivi alle opere cinematografiche.
Tuttavia, dall'altra parte, la Commissione esprime anche delle critiche verso Piracy Shield, che per come è strutturato attualmente non segue i principi del Digital Service Act, in quanto non tiene conto del diritto fondamentale alla libertà di espressione e informazione.
È presente inoltre una disparità di tempistiche tra il blocco di un indirizzo IP, che deve essere immediato, e il suo sblocco, che invece prevede tempi più lunghi.
A ciò si aggiunge l'assenza di particolari controlli sulle segnalazioni, rischiando di causare blocchi eccessivi e una mancata trasparenza per i segnalatori.
Tutte problematiche che sono state spesso segnalate negli ultimi mesi e che, si spera, troveranno finalmente una soluzione dopo il parere della Commissione.
Nell'epoca contemporanea, caratterizzata da un'innovazione tecnologica che avanza a ritmi vertiginosi, i dispositivi elettronici sono diventati compagni insostituibili della nostra quotidianità.
Smartphone, computer, tablet, ma anche elettrodomestici sempre più intelligenti, permeano ogni aspetto della nostra vita, dal lavoro al tempo libero, dalla comunicazione all'intrattenimento.
Tuttavia questa onnipresenza tecnologica porta con sé una sfida cruciale, spesso sottovalutata, ma d'impatto crescente: la durabilità e la riparabilità di questi stessi dispositivi.
Mentre in passato si tendeva a conservare e riparare gli oggetti, oggi siamo immersi in una cultura del consumo che spinge verso una sostituzione sempre più rapida, alimentando un ciclo che ha profonde implicazioni economiche, ambientali e sociali.
È in questo contesto che il movimento per il diritto alla riparazione sta emergendo come una risposta necessaria e consapevole, un tentativo di riequilibrare i rapporti tra consumatori, produttori e la tecnologia che definisce la nostra era.
Per comprendere la portata di questo cambiamento è utile analizzare le dinamiche che hanno portato alla situazione attuale.
Come abbiamo discusso in precedenza, ad esempio nella puntata "Siamo arrivati al 1984?", lo smartphone è diventato un hub centrale per la nostra identità digitale.
Questa centralità, unita a strategie di marketing aggressive e a un'innovazione che seppur a volte solo incrementale viene presentata come rivoluzionaria, crea una pressione costante verso l'aggiornamento all'ultimo modello.
A ciò si aggiunge un design industriale che, privilegiando spesso l'estetica e la compattezza, ha reso i dispositivi progressivamente più difficili da aprire e riparare.
Componenti chiave come batterie, schermi e processori sono frequentemente saldati direttamente sulla scheda madre o incollati all'interno di scocche sigillate, trasformando anche la sostituzione di un singolo pezzo danneggiato in un'operazione
complessa e costosa, spesso fuori dalla portata del consumatore medio o persino del tecnico indipendente.
Ricordiamo come la crisi dei semiconduttori abbia inoltre evidenziato la complessità e la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento globali, rendendo ancora più preziosa la capacità di estendere la vita utile dei dispositivi esistenti.
Questo scenario è spesso associato al concetto di obsolescenza programmata, un termine che suggerisce una deliberata progettazione di prodotti destinati a guastarsi o a diventare superati dopo un periodo di tempo predefinito.
Sebbene sia difficile provare l'intenzionalità diretta, è innegabile che esistano pratiche industriali che favoriscono l'obsolescenza.
La limitata disponibilità di aggiornamenti software per i modelli più datati, la difficoltà nel reperire parti di ricambio originali e costi di riparazione presso i centri autorizzati che talvolta si avvicinano al prezzo di un dispositivo nuovo.
Questi fattori concorrono a creare quella che potremmo definire un'obsolescenza indotta, dove il consumatore di fronte ad un guasto o a un rallentamento delle prestazioni è spinto a considerare la sostituzione come l'unica o la più conveniente opzione.
Le conseguenze di questo modello di consumo sono allarmanti.
Ogni anno, a livello globale, vengono generate decine di milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, i cosiddetti RAEE, dove la gestione di questi rifiuti è complessa e costosa e una parte significativa finisce ancora oggi in discarica o viene
esportata in modo non conforme verso paesi in via di sviluppo, tutto questo con gravi ripercussioni ambientali e sanitarie per le comunità locali.
La continua produzione di nuovi dispositivi, inoltre, implica un prelievo massiccio di risorse naturali, incluse le terre rare, la cui estrazione è spesso associata ad impatti ambientali devastanti e a condizioni di lavoro precarie.
Allungare il ciclo di vita dei prodotti attraverso la riparazione non è quindi solo una questione di buon senso economico per il singolo, ma ha un vantaggio ambientale enorme per tutto il pianeta.
Il movimento per il diritto alla riparazione, nato dalla presa di coscienza di queste problematiche, sta guadagnando un consenso sempre più ampio.
Associazioni di consumatori, organizzazioni ambientaliste e un numero crescente di cittadini chiedono a gran voce un cambiamento e i legislatori da qualche anno stanno iniziando ad ascoltare.
Negli Stati Uniti, la scorsa amministrazione Biden aveva espresso supporto per il "Right to Repair" e diversi stati come New York e la California hanno approvato o stanno discutendo leggi che obbligano i produttori a rendere disponibili parti di
ricambio, strumenti diagnostici e manuali di riparazione ai consumatori e ai riparatori indipendenti.
In Europa, la Commissione europea ha fatto del diritto alla riparazione uno dei pilastri del Green Deal e del Piano d'Azione per l'Economia Circolare.
Già dal marzo 2021, normative sull'eco-design impongono requisiti di riparabilità per diverse categorie di elettrodomestici, come frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie e televisori, obbligando i produttori a garantire la disponibilità di pezzi di ricambio essenziali per un periodo che va dai 7 ai 10 anni.
Il 30 luglio 2024 è invece entrata in vigore la direttiva UE 2024/1799, che fornisce indicazioni specifiche per fabbricanti e venditori sull'obbligo alla riparazione, incoraggiando così i consumatori a prolungare la vita dei propri prodotti tecnologici.
Per arrivare preparati alla scadenza di adeguamento fissata per il 31 luglio 2026, le più grandi aziende produttrici di smartphone stanno iniziando a rilasciare i componenti e le guide ufficiali per la riparazione fai-da-te dei propri telefoni.
Per non farsi cogliere alla sprovvista, Apple ha introdotto la politica dell'autoriparazione molto prima degli obblighi imposti dalla direttiva, tant'è che tra tutte le aziende è quella che possiede la sezione di manualistica migliore e più completa.
Oltre alle guide in italiano, Apple ha reso disponibili diversi video e fotografie per spiegare i passaggi più complessi anche a chi non ha mai effettuato una riparazione prima d'ora.
Le parti di ricambio sono decisamente costose, tuttavia sono presenti quasi tutte le componenti dei principali dispositivi, partendo dalle singole viti fino ai dissipatori.
Benché l'accesso ai manuali e alle componenti debba essere libero, Google invece consente la riparazione dei dispositivi solo una volta inserito sulla pagina web dedicata, i seriali o codice IMEI dello smartphone.
Tra gli altri produttori principali, Honor e Xiaomi sono quelli con i prezzi di ricambio più bassi, con batterie acquistabili dai venditori esterni a 18 euro per quanto riguarda Honor.
Samsung infine fornisce sul proprio sito sia parti di ricambio per smartphone e tablet, sia di altri prodotti dell'azienda.
Nonostante la possibilità di acquistare quasi tutte le componenti, Samsung non fornisce però la possibilità di comprare gli attrezzi per la riparazione, ma li affitta all'utente dopo un versamento di 500 euro di cauzione.
Finora, però, abbiamo parlato di smartphone pensati inizialmente per non essere riparati dai consumatori.
Tra le centinaia di soluzioni proposte dal mercato, esistono però esempi virtuosi, che puntano proprio sulla modularità, ovvero sulla possibilità di sostituire facilmente le componenti del telefono più usurate.
Uno dei modelli più interessanti su questo fronte è il Fairphone 6, presentato ufficialmente la scorsa settimana come uno degli smartphone più sostenibili sul mercato.
Questa caratteristica è dovuta proprio alla facile riparabilità del telefono, garantendo al contempo prestazioni e durabilità di tutto rispetto.
Il retro del telefono è composto infatti da due parti, una superiore e una inferiore, pensate in questo modo per contenere i costi e facilitare proprio la riparazione.
Il retro risulta dunque facilmente smontabile, così da poter sostituire la batteria proprio come si faceva per i primi modelli di smartphone.
A parte questa componente, anche le altre possono essere sostituite, partendo dalla fotocamera con i relativi sensori e arrivando fino alla porta USB.
Con questo abbiamo capito che i benefici derivanti da un solido diritto alla riparazione sono molteplici e tangibili.
Per i consumatori significa maggior libertà di scelta, la possibilità di risparmiare denaro evitando sostituzioni premature e il diritto di decidere cosa fare con un prodotto di loro proprietà.
Per l'economia locale significa invece stimolare la crescita di un settore di riparatori indipendenti, creando posti di lavoro qualificati e promuovendo competenze tecniche sul territorio.
Per l'ambiente, come già sottolineato, determina una significativa riduzione dei rifiuti elettronici, con minor consumo di risorse naturali e una diminuzione dell'impronta carbonica associata alla produzione di nuovi dispositivi.
Tuttavia, prima dell'iniziativa dell'Unione Europea, l'industria tecnologica e in particolare i grandi produttori di elettronica di consumo hanno spesso opposto resistenza all'introduzione di normative stringenti sul diritto alla riparazione.
Le argomentazioni portate sono varie.
Una delle più ricorrenti riguarda la sicurezza.
Si sostiene che riparazioni effettuate da personale non qualificato o con parti di ricambio non originali potrebbero compromettere il corretto funzionamento del dispositivo e, in casi estremi, creare rischi per l'incolumità dell'utente.
Pensiamo ad esempio alla complessità e alla delicatezza delle batterie al litio presenti nello smartphone, che se danneggiate o sostituite in modo improprio possono surriscaldarsi o incendiarsi.
Un'altra preoccupazione frequentemente citata è la protezione della proprietà intellettuale.
I produttori temono che la divulgazione di manuali di riparazione dettagliati e schemi circuitali possa facilitare la contraffazione dei loro prodotti o la copia non autorizzata di tecnologie e design proprietari.
Infine, alcune aziende argomentano che l'obbligo di rendere i prodotti più facilmente riparabili potrebbe limitare la propria libertà di design, portando a dispositivi più ingombranti o meno performanti.
Se alcune di queste preoccupazioni, come quelle relative alla sicurezza, meritano un'attenta considerazione e possono essere affrontate attraverso meccanismi di certificazione per i riparatori o standard di qualità per le parti di ricambio, altre
appaiono più come tentativi di difendere modelli di business consolidati, basati su cicli di sostituzione rapidi e su un controllo dell'assistenza post vendita.
La sfida per i legislatori è quindi quella di trovare un equilibrio che tuteli i diritti dei consumatori e l'ambiente, senza soffocare l'innovazione o creare rischi ingiustificati.
Fortunatamente, la pressione crescente da parte dell'opinione pubblica e dei regolatori sta spingendo anche i produttori più resti a riconsiderare le proprie strategie.
Apple, ad esempio, che per anni ha rappresentato l'emblema delle politiche di riparazione chiuse, ha introdotto, come detto poco fa, il programma "Self Service Repair", che permette agli utenti di acquistare parti di ricambio originali per riparare autonomamente alcuni modelli di iPhone, iPad e Mac.
Anche Samsung e Google stanno ampliando la disponibilità di parti di ricambio, collaborando anche con piattaforme come iFixit, nota per le sue guide dettagliate alla riparazione.
Questi sono passi importanti, ma rappresentano ancora solo l'inizio di un percorso.
Affinché il diritto alla riparazione diventi una pratica consolidata e non un'eccezione, è necessario un impegno più profondo e sistematico.
I produttori dovrebbero integrare i principi del "Design for Repair" fin dalle prime fasi dello sviluppo di un prodotto, privilegiando la modularità, la facilità di smontaggio e l'utilizzo di componenti standardizzati.
I legislatori devono invece continuare a rafforzare il quadro normativo, estendendo i requisiti di riparabilità ad un numero sempre maggiore di categorie di prodotti e garantendo un'applicazione efficace delle regole.
E noi consumatori, infine, abbiamo un ruolo attivo da svolgere, informarci sulla riparabilità dei prodotti prima dell'acquisto, supportando i marchi che dimostrino un impegno concreto per la sostenibilità e, quando possibile, scegliendo la riparazione invece della sostituzione.
E così si conclude questa puntata di INSiDER - Dentro la Tecnologia, io ringrazio come sempre la redazione e in special modo Matteo Gallo e Luca Martinelli che ogni sabato mattina ci permettono di pubblicare un nuovo episodio.
Per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione@dentrolatecnologia.it, seguiteci su Instagram a @dentrolatecnologia dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti.
In qualsiasi caso nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social.
Se trovate interessante il podcast condividetelo che per noi è un ottimo modo per crescere e non dimenticate di farci pubblicità.
Noi ci sentiamo la settimana prossima.