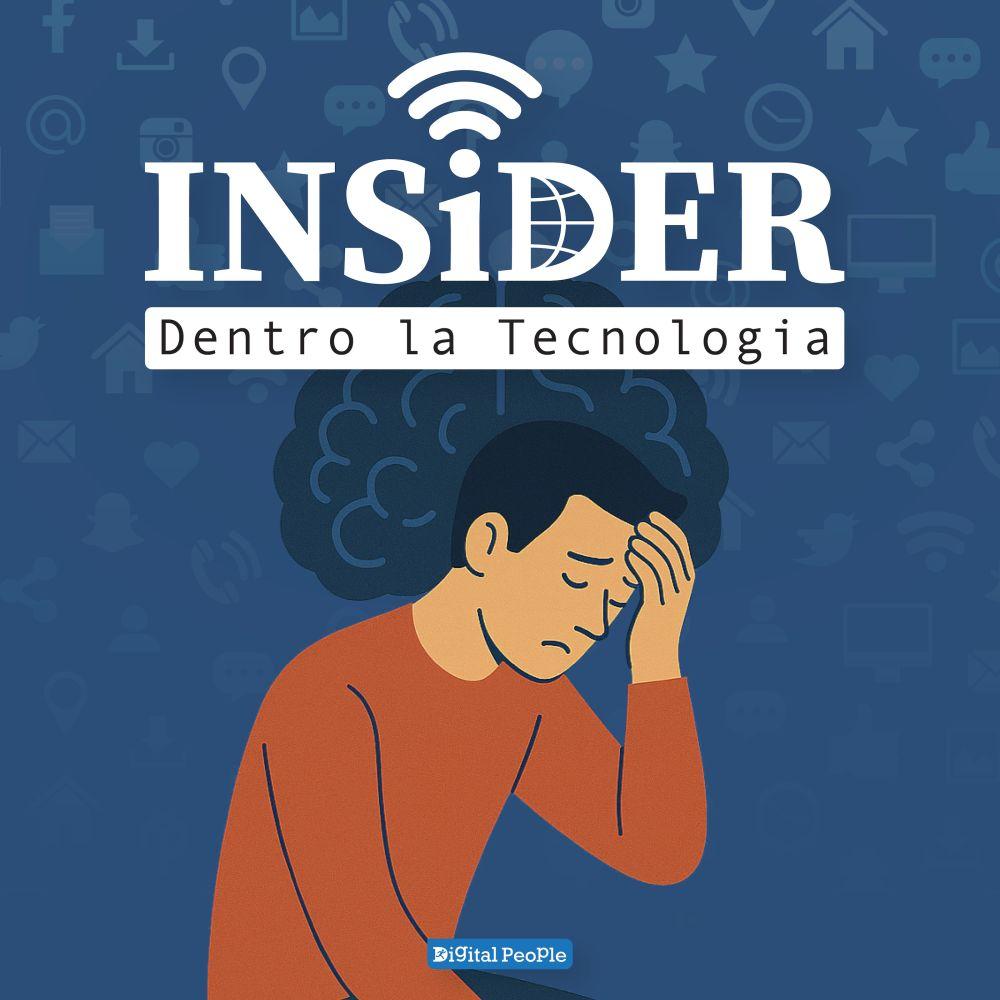L'Intelligenza Artificiale è stata celebrata come l'ultima grande innovazione umana, promettendo di liberarci da compiti ripetitivi e ottimizzare i processi per sbloccare nuovi spazi di creatività e produttività. Eppure, emerge un paradosso sorprendente: in un'epoca ricca di strumenti che dovrebbero farci risparmiare tempo, la sensazione di essere sempre più a corto di tempo libero è una realtà diffusa. Questa puntata non si propone di dibattere se l'IA sia in grado di far risparmiare tempo, ma esplora una domanda più complessa e cruciale: a cosa viene effettivamente destinato il tempo "liberato" e come l'automazione sta trasformando il nostro rapporto con il lavoro e la nostra stessa identità personale?
Nella sezione delle notizie parliamo dell'acquisizione di Arduino da parte di Qualcomm, dello SPID che resterà gratuito fino al 2027 e infine di Sora, il social di OpenAI, che introduce la monetizzazione dei "cameo".




Immagini
• Foto copertina: Freepik
Brani
• Ecstasy by Rabbit Theft
• One Taste by More Plastic & URBANO
Salve a tutti, siete all'ascolto di INSiDER - Dentro la Tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host, Davide Fasoli.
Oggi parleremo di "Free Time, No Time", ovvero di come l'intelligenza artificiale può liberarci del tempo dalle nostre attività lavorative, ma allo stesso tempo rischi di trasformarlo in produttività ulteriore o in momenti persi sui social.
Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a @dentrolatecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina, su Spotify, Apple Podcast, YouTube Music oppure direttamente sul nostro sito.
Arduino, che abbiamo intervistato questa primavera, è l'azienda leader italiana nell'hardware e software opensource, grazie alle sue schede programmabili che hanno conquistato hobbisti, insegnanti e, negli ultimi anni, anche gli ambienti professionali.
La potenzialità di quest'azienda è stata riconosciuta anche da Qualcomm, che ne ha annunciato l'acquisizione proprio questa settimana.
Gli accordi economici non sono ancora noti, ma Qualcomm ha garantito che Arduino potrà continuare a operare come marchio indipendente, mantenendo la filosofia opensource e il suo supporto a diversi microcontrollori a prezzi abbordabili.
Contemporaneamente, l'acquisizione ha portato a un'interessante novità: ossia lo sviluppo di una nuova scheda, la Arduino UNO Q, diventando molto più simile nell'approccio a Raspberry.
La nuova UNO Q, infatti, avrà un doppio processore Qualcomm e la possibilità di eseguire un sistema operativo Linux per far girare software complessi o piccoli server.
Inoltre viene affiancata anche una GPU Adreno, pensata per lo sviluppo di software basati su IA e processamento di immagini.
Il tutto al prezzo di 39€, dunque in piena linea con la filosofia Arduino.
La speranza è che anche in futuro si proceda con questa linea, con Arduino che potrà continuare ad agire indipendentemente con la sua solita e apprezzata filosofia, ma con alle spalle un colosso dei microprocessori in grado di garantire lo sviluppo di schede sempre più potenti in linea con le nuove richieste di mercato.
Dopo che si è parlato molto della possibilità che lo SPID diventasse a pagamento, è stato raggiunto un nuovo accordo tra l'Agenzia per l'Italia Digitale, AgID, e i provider dello speed, che assicura la gratuità del servizio almeno fino al 2027.
Le convenzioni firmate hanno una durata di 24 mesi, con la possibilità di proroga fino a 36, per garantire la continuità operativa del sistema di identità digitale che ha rivoluzionato l'accesso ai servizi pubblici.
L'intesa smentisce quindi le recenti indiscrezioni su un possibile contributo economico richiesto agli utenti da parte di Poste Italiane, e offre stabilità anche agli altri gestori come InfoCert e Register, chiamati ora a valutare eventuali adeguamenti.
Secondo il sottosegretario Alessio Butti, l'accordo segna un passo decisivo nel percorso di consolidamento dell'identità digitale nazionale, con l'obiettivo di integrare SPID e carta di identità elettronica in un unico sistema interoperabile: l'IT-Wallet.
Al momento sono oltre 41 milioni gli italiani in possesso di SPID, con 630 milioni di accessi nel solo primo trimestre 2025, un risultato che testimonia l'importanza di mantenere gratuito uno strumento ormai essenziale per cittadini e pubbliche amministrazioni.
OpenAI ha lanciato recentemente Sora 2, ovvero l'evoluzione del suo modello di intelligenza artificiale per la generazione di video, ora dotato anche di audio.
Parallelamente l'azienda ha introdotto anche Sora, un social costruito esclusivamente attorno a contenuti generati dall'IA, disponibile attualmente solo negli USA e in Canada.
Essa ospita infatti solo video e la caratteristica distintiva dell'app è rappresentata dai "cameo", che corrispondono a dei brevi video che gli utenti registrano per permettere al sistema di riprodurre fedelmente la loro immagine e voce in altri contesti non reali.
Con il consenso dell'interessato, altri possono inserire questi cameo nella propria creazione - pur rimanendo il soggetto originale coproprietario del contenuto e mantenendo il diritto di revoca.
Questo approccio basato sul consenso impedisce infatti l'utilizzo non autorizzato di volti, anche di personaggi pubblici.
Sam Altman, CEO di OpenAI però, ha annunciato l'introduzione di due novità significative riguardanti i cameo.
La prima prevede controlli più specifici per i detentori dei diritti, permettendo loro di stabilire limiti precisi su come i propri personaggi possono essere rappresentati.
La seconda più controversa riguarda la monetizzazione.
OpenAI sta sviluppando infatti un modello per redistribuire parte dei ricavi ai proprietari dei cameo che autorizzano l'utilizzo della propria immagine.
Questa scelta, meramente economica, pur comprensibile data all'elevata richiesta di risorse computazionali, rischia però di snaturare la filosofia iniziale della piattaforma, concepita per condivisioni tra persone che si conoscono, trasformandola
potenzialmente in un mercato in cui molti condivideranno il proprio cameo nella speranza di guadagno.
L'intelligenza artificiale è stata celebrata come l'ultima e più potente innovazione che l'umanità ha creato, in linea con strumenti rivoluzionari come la macchina vapore, Internet e lo smartphone.
La sua promessa principale, tanto per i lavoratori quanto per le aziende, è la liberazione del tempo libero, l'automatizzazione dei compiti ripetitivi e l'ottimizzazione dei processi, per sbloccare nuovi momenti per la creatività e la produttività.
Eppure, nonostante la sua evidente capacità di generare efficienza, emerge un paradosso profondo e controintuitivo: in un periodo pieno di strumenti che dovrebbero farci risparmiare tempo, la sensazione di essere sempre più a corto di tempo libero è una realtà diffusa.
L'introduzione di queste tecnologie, infatti, non ha semplicemente aumentato la nostra disponibilità di tempo, ma ha ridefinito il nostro rapporto con il lavoro, il tempo libero e la nostra stessa identità personale.
Questa puntata, però, non si propone di dibattere se l'IA sia in grado di far risparmiare tempo, ma si prefigge, invece, di esplorare una domanda più complessa e cruciale: a cosa viene effettivamente destinato il tempo "liberato"?
L'impatto principale dell'intelligenza artificiale si manifesta attraverso l'automazione dei compiti a basso valore, noiosi e ripetitivi, che storicamente hanno assorbito una parte significativa della giornata lavorativa di ogni professionista.
Nel settore dei servizi l'impatto è particolarmente evidente.
Ad esempio, l'implementazione di bot per il servizio clienti, in grado di gestire le domande più comuni, libera i team di supporto, permettendo loro di concentrarsi su questioni più complesse e di maggior valore aggiunto.
Allo stesso modo, l'automazione dei follow-up via email, basata sul comportamento dell'utente, o la gestione automatica di report e promemoria interni, rappresentano esempi concreti di come l'IA elimini il tempo sprecato in attività amministrative.
In sintesi, l'obiettivo non è la sostituzione completa dei lavoratori, ma un potenziamento delle loro capacità, offrendo strumenti avanzati per risolvere problemi e fornire spunti per migliorare i prodotti e i servizi.
Diversi studi dimostrano che i benefici dell'automazione si traducono in un risparmio di tempo diretto e misurabile per i lavoratori.
Ad esempio, la ricerca "Global Workforce of the Future 2024", di The Adecco Group, evidenzia un miglioramento della produttività che si traduce in un risparmio medio di 48 minuti al giorno per il lavoratore medio.
In modo simile, un'analisi condotta dal Politecnico di Milano ha calcolato un risparmio di tempo ancora più cospicuo, grazie all'utilizzo di strumenti di IA nel contesto lavorativo.
L'entità del risparmio, poi, può essere ancora maggiore in settori specifici, come la programmazione informatica.
I minuti liberati, perciò, vengono immediatamente reindirizzati verso nuove attività, accelerando un ciclo di produttività che non lascia spazio al riposo.
Sembra dunque che l'IA non si limiti a farci fare le stesse cose più velocemente, ma anche a farne di più e a un livello di rendimento costantemente crescente.
Infatti, un aspetto cruciale del paradosso è che la maggior parte del tempo risparmiato non viene utilizzato per attività non lavorative.
Un altro studio del Politecnico di Milano ha mostrato che circa il 60% delle persone che utilizzano l'IA sul lavoro reinvestono questo tempo per lavorare di più, aumentando la loro produttività complessiva.
Solo il 40% si dedica ad attività extralavorative, come socializzare con i colleghi o acquisire nuove competenze.
Questo dato rivela che, nella mentalità lavorativa moderna, l'efficienza non è un mezzo per la libertà, ma un mezzo per una maggior produzione.
Questa tendenza è in parte alimentata dalla crescente riduzione dei confini tra lavoro e vita privata, un fenomeno accentuato dall'avvento del lavoro da remoto e dell'iperconnettività, temi di cui abbiamo ampiamente parlato nella puntata dello scorso 7 giugno.
In ogni caso, se una parte del tempo risparmiato viene reinvestita nel lavoro, un'altra parte, altrettanto significativa, viene assorbita dal consumo digitale.
I dati più recenti sul consumo mediatico mostrano che l'utente medio trascorre 2 ore e 23 minuti al giorno sui social, e sebbene questa cifra rappresenti una leggera diminuzione rispetto al 2023, il totale cumulativo passato sui social per il 2024 raggiunge un valore esorbitante: pari a 500 milioni di anni, considerando l'intera umanità.
Questi dati suggeriscono che il tempo liberato dall'automazione lavorativa non si traduce in un ritorno a passatempi o attività ricreative tradizionali, ma viene piuttosto assorbito dal mondo digitale con le piattaforme di streaming e social network
che innestano la paura di perdersi qualcosa, la cosiddetta "FOMO", acronimo di "Fear of Missing Out", ovvero il continuo monitoraggio di eventi e conversazioni online e la pressione sociale di apparire costantemente impegnati e connessi, un tema di cui abbiamo già parlato nella puntata: "Gli effetti dell'iperconnettività sulla salute mentale".
Per comprendere appieno il paradosso del tempo libero è necessario esplorare i fattori psicologici e sociologici che lo guidano.
Non si tratta solo di una questione di gestione del tempo, ma di valori culturali, pressioni sociali e meccanismi psicologici profondamente eradicati.
Un altro fattore cruciale è il peso mentale del vivere in un'area di innovazione accelerata.
L'introduzione di nuove tecnologie e il flusso costante di informazioni, notifiche e richieste digitali generano uno stato di tensione e disagio psicologico, noto come "tecno-stress", questo fenomeno legato alla teoria del carico cognitivo, che
spiega come la nostra memoria di lavoro abbia una capacità limitata nel gestire ed elaborare nuove informazioni.
L'IA in questo senso è progettata per ridurre il carico cognitivo estraneo, automatizzando i compiti noiosi.
Tuttavia il tempo e le risorse mentali liberati non vengono instradati verso il riposo, ma vengono invece reindirizzati verso l'apprendimento di nuove competenze, la gestione di strumenti di IA più complessi e la risoluzione di problemi di livello superiore.
La continua esposizione a mutamenti e innovazioni, unita alla paura di vedere le proprie competenze rese obsolete, aumenta perciò l'insicurezza e il disagio psicologico.
Dunque, invece di alleggerire il nostro carico mentale, l'IA crea un ciclo di feedback negativo in cui la pressione per rimanere rilevanti e competitivi ci spinge a lavorare di più, aumentando lo stress e riducendo ulteriormente la nostra capacità di disconnetterci.
Sul fronte del tempo libero, l'IA viene invece presentata come uno strumento che può arricchire la nostra vita personale.
Per questo è adoperata per personalizzare l'intrattenimento, suggerire nuovi hobby, ottimizzare la pianificazione delle vacanze e persino promuovere la salute mentale e fisica.
Le piattaforme di streaming come Netflix, ad esempio, utilizzano l'IA per personalizzare consigli sui contenuti, facendo risparmiare del tempo agli utenti nella ricerca di nuovi film o serie TV da vedere.
L'IA di Netflix, inoltre, non si limita a consigliare film o serie, ma analizza le abitudini di visione per creare suggerimenti altamente personalizzati.
Questo sistema è così preciso che il 75% di ciò che gli utenti guardano proviene proprio da questi consigli, dimostrando l'enorme influenza che l'algoritmo ha sul comportamento umano.
Questo fa sì che l'utente che trova sempre qualcosa di interessante da guardare, ha meno probabilità di disdire l'abbonamento.
Dunque l'IA rende l'esperienza più coinvolgente su misura, aiuta a mantenere alta la fedeltà dei clienti e bassa la possibilità che gli abbonamenti vengano disdetti.
Ma a questo punto, dando per scontato che l'intelligenza artificiale è uno strumento utile ed estremamente efficace nel farci risparmiare tempo, come possiamo riottenere il controllo sui minuti che guadagniamo grazie a questa tecnologia?
Chiaramente a questa domanda non esiste una risposta univoca e da manuale.
Tuttavia il primo passo per muoversi in questa nuova realtà è sicuramente tracciare il confine che contraddistingue l'uomo dalla macchina.
L'obiettivo non deve essere quello di delegare tutto all'IA, ma di imparare a utilizzarla come un copilota, cercando di porre un'attenzione maggiore nello sviluppo delle competenze umane che le macchine non possono al momento replicare, come il pensiero critico, l'intelligenza emotiva, la creatività e il giudizio etico.
I lavoratori perciò devono imparare a gestire il tempo in modo più intelligente e non semplicemente lavorando di più.
Questo include la capacità di delegare, stabilire priorità e soprattutto imparare a dire di no senza sensi di colpa sia alle richieste di lavoro che alla costante pressione di essere iperproduttivi.
Il riposo infatti non deve essere visto come una perdita di tempo, bensì come una parte essenziale e produttiva del ciclo di lavoro.
Per concludere, l'idea che l'intelligenza artificiale porti ad una liberazione del nostro tempo si è scontrata alla fine con una realtà più complessa.
Il tempo non è semplicemente stato risparmiato e regalato alle persone, ma è stato reindirizzato in un ciclo di iperproduttività e consumo digitale che ci tiene più occupati e con meno agio di prima.
Il paradosso del "Free Time, No Time", però, non è un fallimento della tecnologia, ma una conseguenza dei nostri valori culturali e delle nostre abitudini comportamentali.
In questo nuovo panorama, perciò, il vero prodotto finale non sarà un'ora in più alla fine della giornata, ma la capacità di scegliere in modo intenzionale come spendere ogni minuto.
Si tratta in pratica di riprendere il controllo sul nostro tempo, di stabilire confini chiari e di valorizzare le qualità intrinsecamente umane, come la creatività e l'empatia, che l'intelligenza artificiale può supportare ma non replicare.
E così si conclude questa puntata di INSiDER - Dentro la Tecnologia, io ringrazio come sempre la redazione e in special modo Matteo Gallo e Luca Martinelli che ogni sabato mattina ci permettono di pubblicare un nuovo episodio.
Per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione@dentrolatecnologia.it, seguiteci su Instagram a @dentrolatecnologia dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti.
In qualsiasi caso nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social.
Se trovate interessante il podcast condividetelo che per noi è un ottimo modo per crescere e non dimenticate di farci pubblicità.
Noi ci sentiamo la settimana prossima.