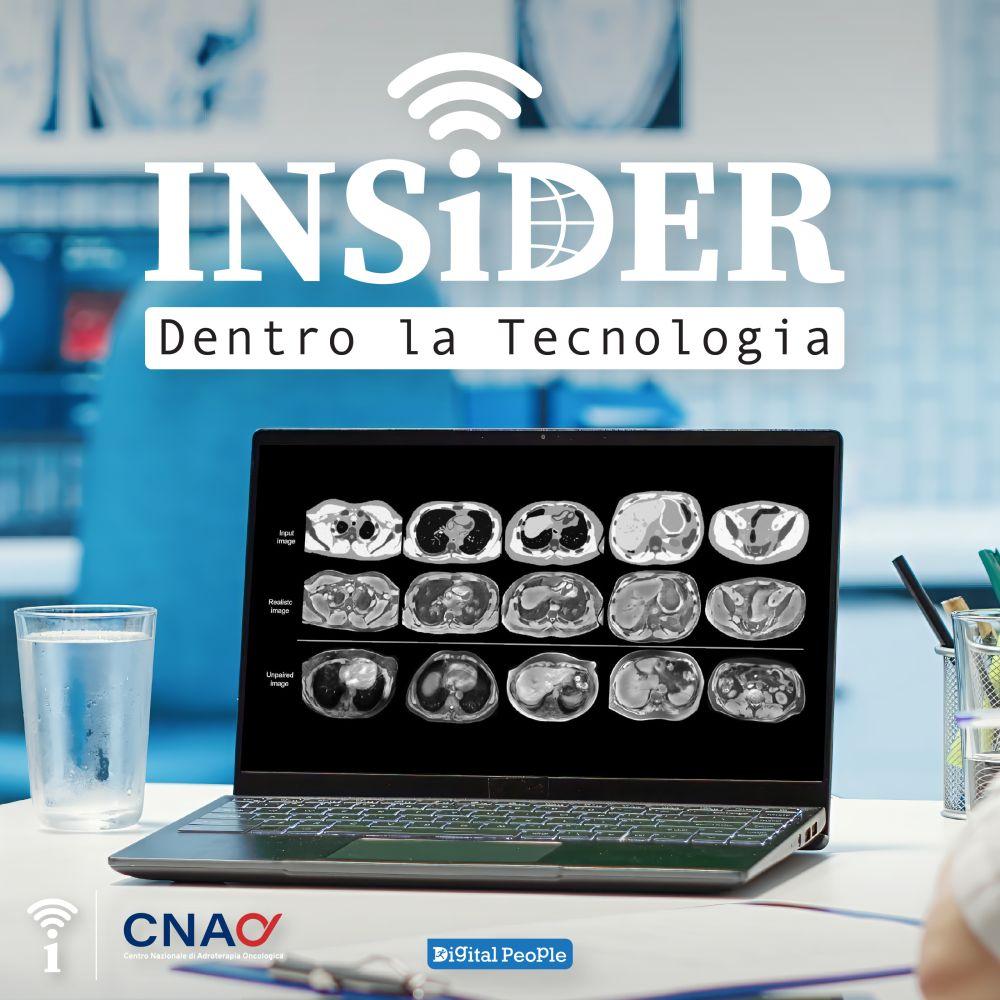L’introduzione e l’applicazione delle più recenti tecnologie nell’ambito della ricerca biomedica, sia di base, che applicata, hanno consentito il raggiungimento di traguardi prima impensabili. Sono numerosissimi gli esempi della portata innovativa di un simile approccio come quello del Genome Sequencing. Per anni l’obiettivo dei ricercatori è stato quello di sviluppare un modo facile, veloce e diretto per avere accesso ai programmi genetici dei vari organismi viventi, incluso l’uomo, e questo è stato possibile solo grazie all’avvento del Sequencing. Ne parleremo con Elisabetta Pianezzola, studentessa di medicina e chirurgia.
Nella prima parte della puntata invece parleremo del mercato del cinema che si è “spostato” in salotto e di 2 funzionalità dell’app Google Arts & Culture.



Brani
• Ecstasy by Rabbit Theft
• Never Get Old by Steve Hartz
Salve a tutti, siete all'ascolto di INSiDER - Dentro la Tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host Davide Fasoli.
Nella puntata di oggi parleremo dell'applicazione delle più recenti tecnologie nell'ambito della ricerca biomedica con una studentessa di medicina e chirurgia, ma prima lasceremo il consueto spazio per le notizie della settimana.
Prima di cominciare vi ricordo che potete ascoltarci in un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito.
Dopo aver rinunciato all'idea di aumentare il prezzo del pacchetto sport per i suoi abbonati, Sky questa volta ha deciso di supportare la chiusura forzata dei cinema, debuttando con Sky Prima Fila Premier.
Con questo nuovo servizio gli utenti Sky potranno godere della visione di alcune pellicole che sarebbero dovute uscire nel periodo di aprile.
Si è partiti venerdì 10 aprile con l'attesissimo Trolls World Tour di casa Dreamworks, proseguendo poi nei giorni successivi con pellicole come un figlio di nome Erasmus con Luca Bizzarri, Emma, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo della Austin e l'uomo invisibile.
Fortunatamente a questa iniziativa si sono accodate oltre a Sky piattaforme streaming tra cui Apple TV, Chili, Google Play, Ten Vision e Infinity, le quali andranno a promuovere il noleggio delle pellicole più recenti ad un prezzo che si dovrebbe aggirare intorno ai 16 euro.
Google ha ormai da tempo rilasciato un'applicazione completamente dedicata all'arte e alla cultura, chiamata Google Arts & Culture.
Grazie a questa applicazione è possibile navigare nella storia dell'arte per conoscere dettagli e curiosità sulle opere che hanno caratterizzato le epoche storiche fino ai giorni d'oggi.
Recentemente però Google ha rilasciato diverse nuove funzioni che sfruttano fotocamera e intelligenza artificiale per rendere l'utente parte integrante dell'arte.
Le funzioni in questione sono Art Selfie e soprattutto Art Transfer.
La prima funzione permette dopo essersi scattati una foto di cercare nella galleria d'arte di Google un ritratto che ci assomigli.
Certo non aspettatevi dei risultati sorprendenti anzi è più facile che rimaniate abbastanza delusi dai vostri sosia del passato.
La seconda funzione invece è molto più interessante e permette di trasformare una semplice foto in un'opera d'arte.
Dopo aver caricato una qualsiasi immagine dalla fotocamera o dalla galleria l'applicazione permette di applicare a scelta uno fra gli stili artistici che hanno caratterizzato le epoche passate e hanno reso subito riconoscibili i loro autori.
Si passa dalla Gioconda di Da Vinci, all'Urlo di Munch, all'autoritratto di Van Gogh fino alle più recenti correnti artistiche.
L'intelligenza artificiale farà il resto e cercherà di realizzare un'opera d'arte unendo l'immagine e lo stile scelto.
Si può scegliere anche di realizzare una gif che mostri la transizione fra la foto originale e quella modificata.
Purtroppo la risoluzione non è ottima, si parla di 600 pixel per 600 e anche la realtà utilità della funzione è abbastanza dubbiosa.
Sarà però un ottimo modo per occupare il tempo e condividere con gli amici o sui social le nostre opere d'arte.
L'introduzione e l'applicazione delle più recenti tecnologie nell'ambito della ricerca biomedica, sia di base che applicata, ha consentito il raggiungimento di traguardi prima impensabili.
Sono numerosissimi gli esempi della portata innovativa di un simile approccio e oggi siamo qui con Elisabetta Pianezzola, studentessa di medicina e chirurgia all'Università di Verona, per parlare di uno di questi, il genome sequencing.
Benvenuta Elisabetta.
Ciao a tutti, esatto Davide, è proprio così.
Come dicevi bene tu, sempre più traguardi nella ricerca biomedica vengono raggiunti grazie alle nuove tecnologie.
Particolarmente interessanti sono le applicazioni a quelli che riguardano il mondo dell'infinitamente piccolo, delle singole entità biologiche, quindi dotate di un programma genetico.
Ed è proprio questo il punto, perché ogni organismo vivente contiene al proprio interno un patrimonio genetico che non è altro che l'insieme delle informazioni che lo caratterizzano nella sua totalità.
Per anni l'obiettivo di ricercatore è stato quello di sviluppare un modo facile, veloce, diretto e anche economico diciamo per avere accesso ai programmi genetici dei vari organismi viventi, incluso l'uomo e questo è stato possibile solo grazie all'avvento del sequencing.
Ma partendo dalle basi, ci spieghi che cos'è il sequenziamento e come funziona?
Certo, allora il sequenziamento di base è un processo attraverso cui si va a determinare l'esatta sequenza di nucleotidi che costituiscono l'intero genoma di un dato organismo vivente.
All'interno di questa sequenza riconosciamo i geni, che sono delle porzioni codificanti per molecole, generalmente proteine o RNA, e delle porzioni non codificanti, che hanno invece una mera funzione regolatoria.
Quando si sequenzia un gene, dunque, non si fa altro che determinare l'ordine preciso di tutte le coppie di basi che esso contiene, questo perché conoscendo la sequenza sarà poi possibile determinare la funzione del gene stesso.
I primi risultati di sequenziamento genico risalgono agli anni 70 e coincidono con la pubblicazione sulla prestigiosa rivista Nature di un articolo di Fredrik Sanger, un articolo nel quale si andava a riportare per esteso la sequenza di un particolare batteriofago e il metodo rivoluzionare con cui sostanzialmente si era arrivati ad individuarla, metodo che è passato poi alla storia come metodo Sanger.
Questo studio riscosse notevole successi di entusiasmo all'interno della comunità scientifica e aprì sostanzialmente la strada ad una grandissima rivoluzione nel campo della biologia molecolare.
Da un punto di vista puramente teorico, qual è il principio di funzionamento del metodo Sanger? Perché fu così rivoluzionario?
Dunque, c'è da considerare che negli anni precedenti alle pubblicazioni di Sanger già altri scienziati si erano cimentati nel tentativo di sequenziamento di frammenti di DNA e avevano ottenuto risultati tutto sommato discreti diciamo, ma ci furono tutta una serie di fattori a renderlo così rivoluzionario tra cui le tempistiche, l'elevato numero di paia di basi analizzate e soprattutto l'utilizzo di nucleotidi modificati, anche chiamati nucleotidi terminatori di catena.
E che cosa sono?
Allora bisogna fare una premessa, nel senso che siamo di fronte ad una classica reazione di sintesi di DNA e la reazione di sintesi consiste nell'assemblaggio di nucleotidi.
Generalmente questi sono strutturati in modo tale che l'ultimo nucleotide inserito possa andare a formare un legame con quello successivo e quello successivo con quello precedente e così via.
Quindi la sintesi procede in questo modo.
I nucleotidi terminatori di catena sono invece modificati in modo tale che non si possono formare ulteriori legami e questo comporta il blocco della sintesi.
Il metodo Sanger sfrutta proprio questa cosa qui nel senso che al termine della reazione andiamo ad ottenere una miscela di filamenti con lunghezza diversa a seconda di dove è avvenuto l'inserimento del nucleotide terminatore di catena.
I diversi frammenti vengono poi ordinate in base alla loro lunghezza e la disposizione dei frammenti andrà infine a svelare di fatto quella che è la sequenza complessiva dei nucleotidi e quindi la stringa del DNA stampo che si voleva sequenziare in primis.
Negli anni il metodo Sanger è stato ottimizzato soprattutto grazie all'impiego di sequenziatori automatici, molecole fluorescenti e strumentazioni in grado di captare ed elaborare i vari segnali luminosi rendendo l'intero processo molto più veloce.
Nonostante i contributi notevoli che ha portato, che ha garantito questo metodo nel campo della ricerca genomica, basti pensare al progetto Genoma umano del 2001 e solleva dei grossi limiti tecnici, limiti che sono di fatto stati agevolmente superati solo con l'introduzione di nuove tecnologie.
Prima e tra tutti abbiamo il Next Generation Sequencing anche detto NGS.
E di che cosa si tratta?
Allora, senza entrare nel dettaglio della procedura, le metodiche NGS si basano sulla lettura multiple parallela di brevissimi frammenti genomici precedentemente amplificati in modo clonale.
Si parla quindi in questo senso di sequenziamento massivo parallelo.
Questi frammenti poi vengono virtualmente riassemblati e resi leggibili tramite software informatici.
A seconda della tecnologia utilizzata, le piattaforme possono poi sequenziare da centinaia di milioni di paia di basi fino a centinaia di miliardi di paia di basi di DNA per analisi che permette sostanzialmente di ottenere una mole di data immensa sul patrimonio genetico individuale.
E quali sono stati i risultati dell'introduzione di queste tecnologie nei laboratori di ricerca?
Dunque in termini di risultati si può dire che il sequenziamento del genoma dato a via ad una vera e propria rivoluzione nel campo della biologia e della medicina.
Rivoluzione guidata non solo dalle tradizionali suite di strumenti per ricercatori ma anche da elaborazione allevate prestazioni, intelligenza artificiale e sistemi di apprendimento automatico di fatto.
d'altronde la ricerca genetica come la conosciamo noi oggi si serve proprio di tutti questi potenti strumenti computazionali per andare ad interpretare ed elaborare i dati acquisiti e giungere infine a nuove conoscenze.
E se potessimo trarre una conclusione, qual è stato il traguardo più importante raggiunto grazie al sequencing?
Il traguardo più importante è stato senza dubbio il completamento del sequenziamento dell'intero genoma umano con il progetto del 2001.
Nella storia della ricerca genetica tale evento infatti rappresenta una vera e propria pietra miliare in termini di risultati ottenuti.
Non solo, ha dato infatti una spinta anche alla ricerca bioinformatica portando allo sviluppo di tutta una serie di software open source in grado di gestire immense quantità di dati e favorire la creazione di banche dati e software di confronto delle sequenze come blast.
E le cose come sono cambiate dal 2001 ad oggi? Il sequenziamento genico è una tecnologia per così dire alla portata di tutti o rimane un importante strumento proprio di una ristretta categoria di persone in ambito puramente biomedico?
Sicuramente l'abbattimento dei costi e dei tempi ne ha contribuito alla sua ampia diffusione e nonostante se siano diffuse anche delle compagnie che permettono il sequenziamento genico ai privati che lo vogliono richiedere, i risultati sicuramente più validi e interessanti rimangono quelli nel campo prettamente biomedico clinico dove le nuove informazioni acquisibili possono avere rilevanza in termini diagnostici prognostici e predittivi come per esempio nell'insorgenza dei tumori o ancora per quel che riguarda le reazioni al trattamento di farmaci.
E tutto ciò porta a un'evoluzione della medicina giusto? Cioè una medicina più personalizzata per ogni singolo paziente?
Esatto la direzione è proprio quella lì.
Ad oggi per esempio sono numerosi farmaci anticoagulanti o antitumorali che vengono prescritti solo sulla base dei risultati di specifici test genetici, questo in modo tale che ne siano ottimizzati i dosaggi e che si vadano eventualmente a prevenire tutti quegli effetti collaterali indesiderabili.
La sfida sarà poi quella di andare ad utilizzarlo universalmente anche per le patologie più comuni.
Tornando invece alle applicazioni del sequencing, quali sono gli ambiti ad averne beneficiato maggiormente o comunque gli ambiti in cui sta prendendo piede maggiormente mi viene mi verrebbe da dire.
Contrariamente a quanto si può pensare ci sono diversi ambiti in cui si può applicare con successo.
Il sequenziamento del DNA può infatti essere utilizzato da archeologi e genetisti per andare a ricostruire il passato evolutivo dei nostri antenati e tracciare i loro flussi migratori nel tempo.
E un esempio la mummia Otzi che è stata sequenziata nel 2012.
Interessanti sono anche le applicazioni allo studio dei vari esseri viventi in primis i batteri che potrebbero aiutarci a scoprire nuovi antibiotici e meccanismi di antibiotico resistenza, altra questione critica, calda comunque ai giorni nostri.
Il più rilevante rimane sicuramente quello biomedico dove si spazia dalla tipizzazione genica delle neoplasie agli studi di variabilità genetica all'interno di una popolazione.
Sono numerosi progetti di ricerca avviati nel corso degli anni che hanno l'obiettivo di andare ad ampliare le conoscenze circa uno specifico settore.
E un esempio il Global Virome Project volto ad identificare i principali virus trasmissibili all'uomo che possono rappresentare una potenziale minaccia per la popolazione.
Il Global Virome Project è un progetto sicuramente ambizioso e costoso ma che ci permetterebbe in futuro di essere pronti in anticipo a rispondere ad inaspettata epidemie o pandemie di malattie prima sconosciute.
Che purtroppo è quello che stiamo affrontando in questo periodo emergenziale.
A tale proposito, in che modo il sequencing ci può venire in aiuto? Non essendo stati in grado di predire una simile emergenza, che utilità può avere a posteriori il sequenziamento del nuovo coronavirus?
considerando che questa tecnologia ha tante più potenzialità, quanto più sviluppati e accurati sono i software che permettono di analizzare e interpretare i dati ricavati, possiamo fare diverse considerazioni.
Sequenziare il SARS-CoV-2 ci permette in primis di conoscere per intero il suo codice genetico, inteso proprio come sequenza di paia di basi.
Utilizzando poi software come Blast, si può vedere sempre in dettaglio eventuali omologie, espressi in percentuali con genomi di altri virus presenti nel database.
Virus che non necessariamente sono propri dell'uomo, ma che sono magari caratteristici di altri esseri viventi.
Questo ci permette di trarre da un lato considerazioni di circa origine, eventuali salti di specie o ancora ricombinazioni avvenute e possibili.
Dall'altro, osservare un'elevatissima omologia tra due sequenze significa generalmente comprendere il ruolo funzionale di quella stessa sequenza.
comprendere proprio in termini di prodotto genico e quindi RNA e proteine, perché verosimilmente già studiate in altre specie.
Quindi possiamo analizzare e comprendere fattori e meccanismi di virulenza, capire in che modo il virus infetta le cellule umane, i recettori di cui si serve e così via, per poi cercare di elaborare dei farmaci in grado di prevenire l'infezione o di bloccarla, o ancora possiamo capire in che modo inattivare il virus manipolando il suo genoma per mettere appunto un vaccino insomma.
Ah, molto interessante!
Sì, attraverso poi software come Nextstrain possiamo tracciare la sua trasmissione e fare una vera e propria mappa dei contagi.
Nonostante non sia possibile prevenire la successiva direzione del virus, si può conoscere da dove provengono i nuovi casi e capire poi come agire di conseguenza per contenerne la diffusione.
Durante un'epidemia il codice genetico di un virus subirà mutazioni costantemente, mentre si diffonda attraverso una popolazione.
Le mutazioni sono generalmente lievi, spesse e volentieri nel codice cambia infatti solo una lettera e forniscono una specie di marcatura temporale e geografica.
Mettendo a confronto poi codici genetici di campioni virali prelevati a livello globale, sarà possibile costruire una mappa delle mutazioni mentre il virus si muove intorno al mondo, ed è ciò che fa Nextstrain.
Esso infatti va a tracciare il virus come un albero genealogico, o meglio una linea temporale evolutiva.
Per il coronavirus, quell'albero genealogico ha origine nella città cinese di Wuhan e si dirà madali.
Quando compaiono nuovi casi, il codice genetico di quei campioni virali può essere confrontato con quelli nel database per determinare quindi la sua regione di origine.
Queste sono informazioni cruciali per i funzionali sanitari di tutto il mondo che stanno cercando di determinare se nuovi casi arriveranno o meno nei loro paesi attraverso viaggi internazionali o se ancora vengono trasmessi localmente.
Citando le parole di uno scienziato che lavora su Nextstrain, prima si invertono questi dati, migliore sarà la risposta della salute pubblica.
Va bene, grazie Elisabetta per il tuo intervento, è stato molto interessante e ci sentiamo presto.
Ciao e alla prossima!
E così si conclude questa puntata di INSiDER - Dentro la Tecnologia.
Vi invito a dare un'occhiata al sito di Nextstrain di cui Elisabetta ha parlato e in particolare alla sezione Narratives dove si può trovare un report interattivo anche in italiano sulla situazione Covid-19 in costante aggiornamento.
Il report è comprensibile anche dai neofiti, è spiegato in modo chiaro e semplice e soprattutto si tratta di dati e fonti ufficiali.
L'obiettivo è di combattere la disinformazione e rendere le persone più consapevoli di ciò che la comunità scientifica conosce e non conosce ad oggi di questo nuovo virus.
Io ringrazio come sempre la redazione che ogni sabato mattina ci permette di pubblicare un nuovo episodio.
Per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione@dentrolatecnologia.it, oppure inviateci un messaggio vocale sulla nostra chat di Telegram, tutti i contatti sono su dentrolatecnologia.it.
Se trovate interessante il podcast condividetelo che per noi è un ottimo modo per crescere