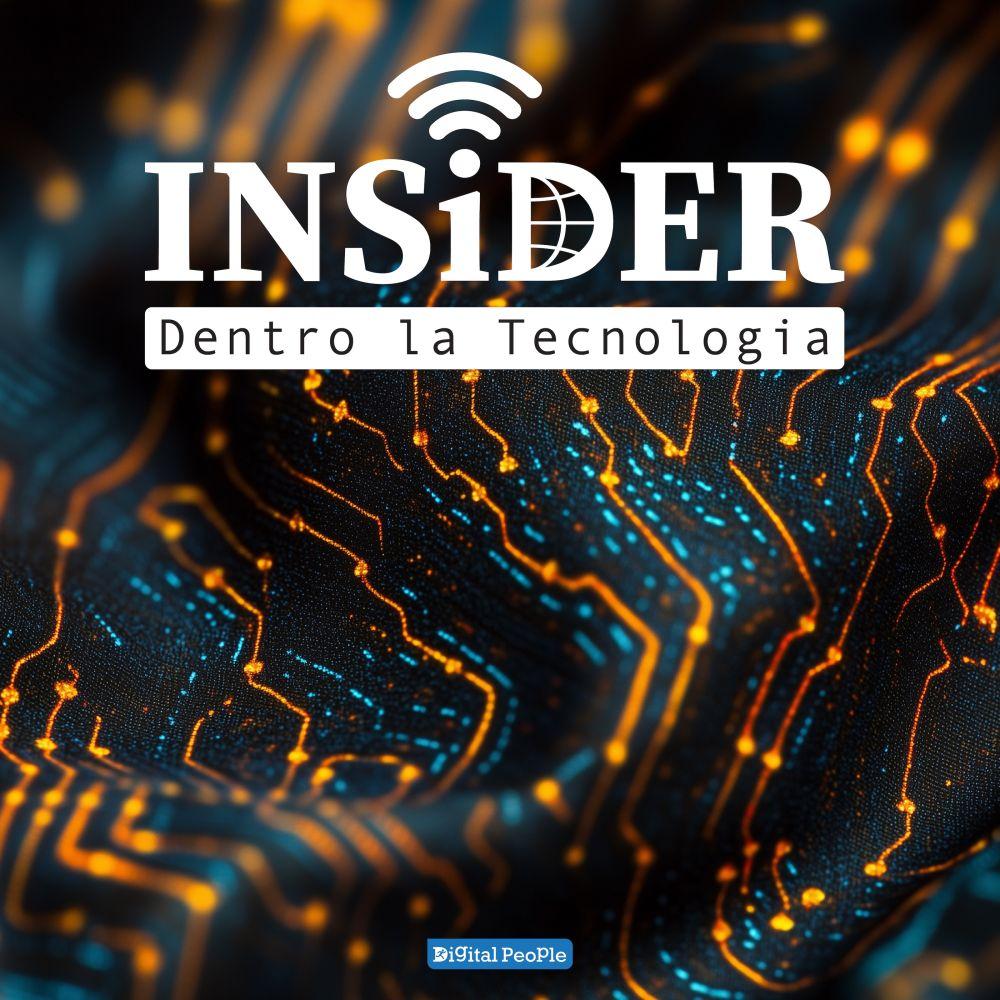La ricerca del vantaggio competitivo e la sicurezza negli sport di alto livello spinge continuamente verso nuove frontiere, dove materiali e tecnologie applicati alle tute di piloti e atleti rappresentano investimenti significativi nel miglioramento delle prestazioni agonistiche. Ma ciò che rende particolarmente interessante questo processo è la successiva democratizzazione di queste tecnologie, perché se inizialmente vengono concepite per prevenire incidenti e situazioni di pericolo in ambito sportivo, oggi questi dispositivi trovano applicazione in ambienti di lavoro ostili come i cantieri o come strumenti indispensabili a supporto degli anziani. Per capire quali sono le migliori soluzioni in grado di valorizzare la sicurezza individuale siamo stati a Vicenza nei laboratori di D-Air Lab e abbiamo incontrato Marcello Bencini, direttore esecutivo di D-Air Lab.
Nella sezione delle notizie parliamo del grave blackout che ha interessato la Penisola Iberica il 28 aprile scorso e dell'integrazione delle carte d'identità nei wallet digitali che verrà supportata nativamente da Android.



Brani
• Ecstasy by Rabbit Theft
• Fire by Brook Xiao (feat. Rachel Horter)
Ringraziamenti
• Matteo Filippi
Per poter sviluppare airbag indossabili serve tutto un ventaglio di competenze molto ampio, molto specialistico.
Infatti nella nostra ricerca e sviluppo abbiamo un grande open space con figure che vanno da design, come dicevamo che è molto importante per far sì che i prodotti siano accettati, agli ingegneri elettronici, del firmware, del software, a tutta una
parte di sartorialità, quindi di modelleria, la capacità di prendere questi oggetti che spesso sono rigidi e metterli intorno a un corpo umano in un modo che siano comodi e che non diano fastidio, che poi si traduce anche veramente nella capacità manuale del cucire questi materiali insieme nella maniera più efficace possibile.
Salve a tutti, siete all'ascolto di INSiDER - Dentro la Tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host, Davide Fasoli.
Oggi parleremo con D-Air Lab, uno spin-off della società Dainese, che si occupa primariamente di portare la tecnologia degli airbag indossabili dal settore sportivo a quello della vita quotidiana, sia per tutelare i lavoratori in quota, sia gli anziani.
Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a @dentrolatecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina, su Spotify, Apple Podcast, YouTube Music oppure direttamente sul nostro sito.
Il 28 aprile alle 12.33 si è verificato un grave blackout che ha interessato l'intera penisola iberica, causato dalla scomparsa improvvisa di circa 15 GW di potenza dal sistema elettrico.
L'area geografica interessata è stata identificata nel sud-est della Spagna, un territorio caratterizzato da un'alta concentrazione di impianti fotovoltaici, suggerendo una possibile correlazione del blackout con la generazione solare.
La gravità dell'evento è stata accentuata dalla rapidità con cui è calata la frequenza della rete.
La rete elettrica europea, infatti, opera normalmente a 50 Hz, ma durante l'incidente si è registrato un cambio di frequenza stimato di circa -0,3 Hz al secondo.
In soli 5 secondi, dunque, la frequenza è precipitata da 50 a 48,5 Hz, entrando in una pericolosa "zona rossa".
Questa caduta rapida potrebbe essere collegata alla composizione del mix energetico spagnolo, caratterizzato da un'alta percentuale di fonti rinnovabili che forniscono minore inerzia rispetto ai generatori tradizionali.
Questo evento mette in luce la profonda vulnerabilità della società contemporanea, ormai totalmente dipendente dall'energia elettrica.
L'obiettivo per il prossimo futuro sarà perciò indagare più a fondo sulle cause che hanno generato un blackout di tale portata, e successivamente andare a potenziare e colmare le lacune dei sistemi che attualmente gestiscono la rete elettrica, per evitare che eventi di questo tipo capitino ancora.
Sempre più stati, soprattutto negli USA, stanno integrando documenti personali come carte d'identità e passaporto nelle varie app "wallet" degli smartphone, come Wallet di iOS, Google Wallet o Samsung Wallet.
Vista la crescente necessità di avere un portafoglio digitale completo, quindi, Google sta integrando il supporto nativo per le credenziali digitali direttamente nel sistema operativo Android.
Questo significa che Android riceverà delle nuove API, supportando gli standard OpenID4VP e OpenID4VCI, rispettivamente per la presentazione e l'emissione di credenziali verificabili e quindi riconoscibili come sistema di identificazione.
Queste modifiche aprono a diversi scenari: primo, fra tutti, la possibilità di scegliere più facilmente la propria applicazione wallet, in secondo luogo, forse ancora più importante, le applicazioni e i siti web potranno sfruttare le API messe a
disposizione per ricevere in modo sicuro le credenziali o i documenti digitali, senza la necessità di implementare verifiche ulteriori.
La speranza, poi, è che questi sistemi possano essere supportati da portafogli digitali istituzionali già esistenti, come App IO e il prossimo EU Digital Wallet.
La ricerca del vantaggio competitivo e la sicurezza negli sport di alto livello spinge continuamente verso nuove frontiere, dove i materiali e le tecnologie applicate alle tute di piloti atleti rappresentano investimenti significativi nel miglioramento delle prestazioni agonistiche.
Ma ciò che rende particolarmente interessante questo processo è la successiva democratizzazione di queste tecnologie, perché se inizialmente vengono concepite per prevenire incidenti e situazioni di pericolo in ambito sportivo, oggi questi
dispositivi trovano applicazione in ambienti di lavoro ostili come i cantieri o come strumenti indispensabili a supporto degli anziani.
Per capire quali sono le migliori soluzioni in grado di valorizzare la sicurezza individuale, siamo quindi venuti a Vicenza da D-Air Lab e siamo in compagnia di Marcello Bencini, direttore esecutivo di D-Air Lab.
Benvenuto Marcello.
Buongiorno, grazie.
Innanzitutto chi è D-Air Lab e qual è la missione... la vostra missione principale?
Sì, D-Air Lab nasce come spin-off di Dainese, Dainese S.P.A., l'azienda che è famosa per le tute di Valentino Rossi, diciamo, per semplificare.
Ed è nata in particolare da un'idea di Lino Dainese, che è il fondatore di Dainese S.P.A., che ha voluto fondare D-Air Lab per portare le tecnologie che erano state originariamente pensate per il mondo degli sport nella vita quotidiana.
Di che tecnologia parliamo?
In particolare della tecnologia D-Air, che è l'airbag indossabile che ha inventato Dainese e che ha commercializzato più o meno agli inizi del 2010-2011 e che da allora è diventato obbligatorio in tutte le gare di MotoGP, è stato trasportato
anche nel mondo del motociclismo stradale, nel mondo dello sci, per cui diciamo che è una tecnologia ormai consolidata nel mondo sportivo.
Qui in D-Air Lab prendiamo quella tecnologia, quindi tecnologie di airbag indossabili, e le portiamo nella vita di tutti i giorni.
Cos'è che vuol dire vita di tutti i giorni?
Diciamo che il modo in cui mi piace raccontarla è che in Dainese...
Dainese protegge in un certo senso chi se la cerca, nel senso che chi decide deliberatamente di esporsi a un rischio, che può essere il rischio di andare a 300 km all'ora in circuito o in moto, o può essere il rischio di sciare a più di 100 km all'ora in una pista da sci.
Qui diciamo che sia il lavoratore, quindi nell'ambito dei lavoratori in quota, o che sia l'anziano che rischia di cadere e fratturarsi l'anca, proteggiamo persone che hanno bisogno di protezione tutto il giorno, e soprattutto a prescindere dal loro desiderio, quindi persone che ancora di più hanno bisogno di essere protette.
Si e questo secondo me è interessante perché dimostra... da una chiave di lettura di quelli che sono gli sport come ad esempio penso al MotoGP - che uno potrebbe chiedersi perché esistono se sono così pericolosi - però in realtà da quegli sport
possono nascere tante tecnologie che poi come dicevi possono essere utili nella vita di tutti i giorni delle persone che lavorano, degli anziani che quindi vanno maggiormente tutelati in questo senso.
Certo.
Diciamo che l'estremo è sempre stato un'ottima palestra, nel senso anche rimanendo in ambito motociclistico il percorso è sempre stato sviluppare le tecnologie per i piloti quindi per l'applicazione più estrema possibile in ambito motociclistico e
da lì poi portare quanto più possibile quelle tecnologie nella vita quotidiana, diciamo, nel motociclismo di tutti i giorni.
Diciamo che nella storia di Dainese praticamente tutte le tecnologie sono nate in pista e poi dopo sono state portate anche per gli scooteristi che banalmente vanno in ufficio tutti i giorni.
Ne è un esempio il paraschiena adesso che è diventato ormai un oggetto praticamente imprescindibile per qualsiasi motociclista e anche la storia dell'airbag ha fatto un percorso simile, nel senso che ormai... stavo facendo proprio i conti stamattina, secondo me più o meno sono una milionata di airbag indossabili in giro per il mondo.
Quindi è diventata ormai una tecnologia che è partita in MotoGP ed è poi entrata nella quotidianità di tutti noi.
Ancora di più nel momento in cui questa tecnologia deve appunto essere utilizzata magari non soltanto nei 30-40 giri di pista, ma dalla mattina alla sera, a quel punto la sfida diventa ancora più grande per chi progetta questi dispositivi perché
bisogna progettare oggetti che siano sì protettivi e quindi efficaci in caso di necessità, ma anche e soprattutto che non diano fastidio.
Che non diano fastidio vuol dire che siano confortevoli, quindi che si possano indossare senza sentirsi ingombrati, senza aver caldo, senza che siano pesanti eccetera ma anche che siano esteticamente compatibili con quello che uno si aspetta dal proprio...
Anche perché se no rischio che non venga indossato e che quindi non fa la sua funzione perché se è scomodo non viene utilizzato ecco.
E questo penso ancora di più nel dicevo all'inizio anche ciò che riguarda gli anziani o i lavoratori che magari in quel caso sono anche meno disposti ad accettare un compromesso rispetto a un motociclista su strada che in quel senso rischia maggiormente la vita.
Quindi quali sono state le sfide nella progettazione o comunque di trasporre quella tecnologia anche in un contesto più comune?
Ti direi tutte legate all'accettabilità della protezione, come dicevi giustamente... diciamo che una protezione efficace si base sempre su un triangolo, un triangolo che ha come vertici l'efficacia protettiva, il comfort e lo stile.
Diciamo che se io dovessi sviluppare soltanto la protezione più efficace in senso assoluto sarebbe un mestiere abbastanza semplice, nel senso che basta aggiungere strati e a quel punto sei automaticamente protetto.
Il problema è che se poi dopo questa efficacia qui viene col fatto che le persone, come dicevi giustamente, non lo utilizzano, a questo punto tutta quell'efficacia è improvvisamente crollata a zero, perché semplicemente il protettore non c'è.
Devo dire che il comfort ha anche un aspetto di innocuità molto importante.
Cioè immaginiamoci di dover sviluppare un guanto da moto, e sviluppiamo un guanto da moto che è protettivissimo, quindi se anche caldo a 300 km all'ora sulla mano e ci striscio solo per 20 secondi non mi succede niente.
Ma è così spesso che a quel punto io non riesco più a manovrare la leva del freno col tempismo necessario, a quel punto magari mi ritrovo a fare incidenti che non avrei fatto se non avessi avuto quel guanto.
E quindi è fondamentale che tutto quello che facciamo prima di tutto non impedisca i movimenti, nel senso non aumenti il rischio di infortunio.
Il terzo vertice è lo stile.
Lo stile che può sembrare una banalità, ma molto spesso è la vera sfida da superare.
Parlavamo prima di persone anziane... una persona anziana è anche quella che è molto consapevole del rischio a cui è esposto, quindi prendiamo una 75enne con l'osteoporosi, con un po' di decadimento cognitivo, tale per cui magari è anche già
caduta quindi conosce perfettamente il problema, è perfettamente consapevole di quello attraverso cui passa, se si frattura l'anca, comunque non metterà mai un dispositivo protettivo se questo non non riesce a integrarsi nel modo in cui lei vuole guardarsi allo specchio e vedersi la mattina.
Assolutamente.
Approfondiamo quindi questi settori, partiamo visto che l'hai citato per ultimo quello degli anziani e quindi qual è il prodotto che può diciamo così sopperire... garantire maggiore sicurezza però come hai detto tu favorire l'indossabilità perché non è un ingombro e anche esteticamente non è impegnativo da avere, non crea fastidio.
Sì, il prodotto che abbiamo sviluppato si chiama FutureAge ed è una cintura airbag indossabile che, diciamo, protegge l'anca e protegge l'anca in particolare di chi è particolarmente esposto al rischio di frattura dell'anca, quindi tipicamente gli anziani.
Perché gli anziani?
Perché sono quelli che contemporaneamente hanno una maggiore probabilità di cadere, probabilità di cadere che è particolarmente aggravata da casistiche particolari come il parkinson, l'atassia o alzheimer o altre malattie di questo tipo e rischio
di fratturarsi in caso di caduta che tipicamente viene assieme al degrado della struttura ossea come nel caso dell'osteoporosi.
FutureAge è pensato per proteggere l'anca di queste persone con l'idea che grazie a una protezione attiva di questo tipo la persona possa riprendere lo stile di vita attivo o continuare ad avere uno stile di vita attiva e quindi una vita autonoma e
quindi al di là della protezione in sé anche un incremento la qualità della vita molto importante.
Dicevo FutureAge come funziona?
È una cintura molto leggera, molto molto sottile, molto comoda, parliamo di 350 grammi, quindi poco più di un telefono diciamo, dimensionalmente simile a una cintura, lo spessore massimo è un paio di centimetri, che però ha al suo interno una bella dosi di tecnologia, mettiamola così.
Funziona grazie a una piattaforma inerziale, quindi a dei sensori accelerometri e giroscopi nella parte posteriore che rilevano il movimento del corpo nello spazio e un algoritmo in grado di identificare la caduta, in particolare di distinguere la
caduta dalle attività normali che uno può avere nella sua quotidianità, come sedersi o allacciarsi le scarpe o cose di questo tipo.
Quando l'algoritmo identifica una caduta è in grado di gonfiare un airbag destro o sinistro a seconda del lato della caduta in 60 millisecondi quindi riesce a far sì che prima che io tocchi terra si sia gonfiato l'airbag abbia raggiunto la pressione che doveva avere e la copertura della zona dell'anca e quindi prevenire la frattura.
Oltre all'aspetto di protezione in sé, quindi assorbimento di energia d'impatto, molto importante è anche una protezione aggiuntiva data dall'app che fa sì che in caso di attivazione ci sia anche una chiamata all'emergenza che viene inviata a tutta una serie di contatti che vengono scelti dalla persona e un SMS con la geolocalizzazione.
Quindi diciamo che ti protegge ma fa anche sì che, ove fosse necessario, abbiamo l'aiuto nel minore tempo possibile.
Molto interessante fra l'altro ho visto questa cintura - come dici - e il fatto che è così discreta si può nascondere sotto a una maglietta penso e quindi questo risponde a quello che dicevamo prima cioè dei dispositivi che non mi mettono neanche
in imbarazzo perché magari anche quello è un aspetto, come un anziano che deve indossare una protezione di questo tipo.
C'è quindi se cado sono protetto però non si vede.
Esatto, questa cosa di poterla indossare sotto un maglione è molto importante proprio perché permette di nascondere, nascondere la cintura, però devo dire che anche il tema del comfort è fondamentale nel senso che un oggetto che è scomodo, soprattutto in questo caso, sarebbe del tutto inaccettabile da parte degli utenti.
Pensa che il primissimo prototipo che abbiamo fatto, mai dieci anni fa, non era una cintura, ma era un gilet.
Ed era un gilet con una protezione del torace, della testa, quindi una protezione che, diciamo... mettiamola così, una protezione ideale, un po' tornata a quello che dicevamo prima, no?
Il problema è che per poter proteggere tutte quelle parti del corpo, a quel punto veniva fuori, un gilet che pesava quasi 2 kg con tutta una serie di sacchi ripiegati al suo interno, quindi... per dire d'estate, che facevano un caldo bestia un
prodotto che deve essere a quel punto necessariamente indossato e, nel caso di un gilet, va indossato dove e come?
Cioè, poniamo a... parliamo di compatibilità, dell'oggetto protettivo con l'abbigliamento delle persone.
Se io indosso un gilet, devo decidere se metterlo sopra o sotto la giacca, per dire.
Nel momento in cui lo metto, a quel punto è difficile nasconderlo, nel senso che devo necessariamente averlo come ultimo strato per far sì che si sviluppi la protezione della testa.
Dicevamo che l'estate può fare molto caldo, per cui abbiamo, ci siamo resi conto che, è vero, stavamo puntando al massimo dal punto di vista della protezione, ma stavamo progettando un prodotto che era, mettiamolo così, per cui probabilmente le
persone non sarebbero state ancora pronte e per cui il percorso che abbiamo fatto è stato proprio andare a sviluppare un prodotto che invece fosse quanto più accettabile possibile.
Mettiamo così, non ci sono scuse, ecco, con FutureAge come è pensato oggi.
Nulla ci vieta, anzi, in realtà già sappiamo che vorremmo tornare lì.
Quello che sappiamo per esperienza è che il mercato, inteso come insieme, anzi, come universo degli utenti, ha bisogno di essere abituato alle cose.
Su questo faccio un parallelismo col mondo motociclistico.
Il primissimo airbag, il primissimo prototipo di Dainese di airbag indossabile, è anche in quel caso un gilet, e un gilet con un gigantesco airbag di stampa automotive che si gonfiava andando a coprire praticamente tutte le parti del corpo e questo era nei primi, nel 2000 se non sbaglio, 2000-2001.
Il primo airbag che è stato effettivamente commercializzato era quello per la MotoGP e proteggeva soltanto la spalla.
Perché?
Proprio per questo discorso stiamo facendo sull'accettabilità.
Diciamo che siamo andati a cercare... dico siamo scusa perché io lavoravo in Dainese al tempo... siamo andati a cercare quella protezione che fosse necessaria, diciamo che nel caso dei piloti professionisti la frattura della clavicola è
tendenzialmente l'infortunio contemporaneamente grave e frequente abbastanza da richiedere un'attenzione specifica in particolare la dinamica è quella dell'highside in cui il pilota viene proiettato a 2-3 metri d'altezza e quando cade tipicamente per un effetto di rotazione cade sulla spalla.
Proteggere da quell'energia come una protezione tradizionale vorrebbe di indossare un materasso praticamente.
Ovviamente che a quel punto materasso non è più compatibile con il fare una gara di MotoGP.
Allora lì il percorso è stato sviluppare un airbag per quella specifica casistica che non era possibile risolvere con le protezioni tradizionali.
Poi da lì il mercato, come dicevamo prima, si è riaperto, a quel punto sono ritornati i gilet, quindi una protezione che diventa sempre più ampia.
Però, per poter entrare nella quotidianità e nella mente, diciamo, nella sfera di accettabilità degli utenti, il primo airbag è dovuto essere molto piccolo e quindi molto specifico.
Con le persone anziane stiamo facendo un percorso simile.
Il primo prototipo è un grande gilet, il primo prodotto sul mercato è un prodotto molto specifico per l'anca e un giorno torneremo a proteggere anche altre parti del corpo.
Un aspetto interessante di cui hai parlato, che hai accennato, è quello della caduta.
Quindi il dispositivo è in grado di riconoscere, di distinguere un movimento da una vera e propria caduta.
Come avviene questo?
Vengono fatti dei calcoli?
C'è un algoritmo che calcola questo?
Si, c'è un algoritmo che è stato sviluppato specificamente per questa applicazione.
Perché i movimenti sono diversi rispetto a quelli di una caduta motociclistica.
Esattamente, è ti dirò è anche il più difficile, nel senso che... torno a fare il parallelismo col mondo della moto perché è da dove veniamo e perché è dove in questo momento la tecnologia è diffusa.
Fare un algoritmo per il motociclista su pista, adesso passami l'estremizzazione, "è quasi facile", nel senso che è un algoritmo che deve riconoscere una casistica di possibili movimenti abbastanza limitata, nel senso che un pilota di MotoGP piega a destra, piega a sinistra, piega a destra, piega a sinistra, accelera e frena.
Qualsiasi cosa accada abbastanza al di fuori da questo insieme di possibili movimenti, è facile che sia una caduta.
Già la versione stradale ovviamente ha richiesto tutta una serie di elementi in più contro cui essere robusti.
In strada io posso salire su un marciapiede, posso avere un dosso, posso scendere dalla moto e andare a bermi un caffè tenendo la giacca addosso, posso scendere dalla moto, togliermi la giacca e buttarla su un divanetto.
Per cui sono tutte... già lì è diventata più difficile la sfida.
Diciamo che la moto ha il vantaggio che quantomeno sei di base seduto su un oggetto che vibra e quindi l'algoritmo, per dire, già può fare una prima scrematura sapendo che se non c'è un oggetto... se non c'è una vibrazione di fondo è facile che io non sia sulla moto e quindi non devo attivare.
Nel caso di un airbag che deve essere utilizzato tutto il giorno, a quel punto la casistica diventa praticamente infinita.
Cioè stiamo parlando di persone che possono sedersi e se pensi proprio concentriamoci sul sedersi.
Immaginati l'algoritmo, l'algoritmo non ha occhi e quindi non sa cosa sta succedendo, semplicemente misura il movimento del corpo nello spazio e vede che sto andando verso basso.
Lui non sa che c'è sotto una sedia e quindi lo sviluppo di questo algoritmo è stato dovuto essere così sofisticato da far sì che si potesse intercettare quelle minime differenze tra una persona che si sta sedendo su una sedia o magari si sta lasciando andare su un divano.
Tutti noi magari sul divano tendiamo a lanciarsi un po'.
Se sei un ottantenne col parkinson a quel punto ti lascia andare ancora di più che un po'.
Saper distinguere in questo caso che non ci deve essere un cosiddetto falso positivo è stata una sfida enorme e devo dire che da questo punto di vista c'è stato un lavoro straordinario da parte di tecnici di ricerca e sviluppo che sono riusciti a intercettare veramente tutte queste dinamiche.
E prima di arrivare al prodotto finito avete dovuto raccogliere molti dati per capire quali erano i dati associati a una caduta rispetto al sedersi?
Esatto, sì, diciamo che per la parte di raccolta dei dati abbiamo fatto anche una collaborazione molto interessante, molto importante con l'Università di Bologna, che ha accesso a una buona mole di dati, in particolare di videoregistrazioni di cadute di anziani, da cui abbiamo potuto evincere quelle dinamiche più comuni e quindi...
Simularle.
Esatto, simularle e trainare gli algoritmi su quelle cadute e poi dopo validare questi algoritmi su sia cadute di persone vere, sia anche cadute di manichini.
Il risultato è questo algoritmo di cui parlavamo, che al di là dei test interni che abbiamo fatto noi, poi ovviamente, diciamo, come tutto il prodotto è stato testato e certificato da un organismo notificato indipendente che ha definito tutto un
protocollo di prova che garantisse il fatto che quello che diciamo noi, che poi si può tradurre in: se cadi sei protetto, spacchettandolo in tutte le componenti di questa affermazione, quindi questo organismo notificato ha stirato un protocollo che
dice: prima di tutto che se cado l'algoritmo riconosce la caduta e se non cado riconosce che non sto cadendo, che è altrettanto importante.
Diciamo, se cade o riconosce la caduta, è in grado di attivare l'airbag prima che io tocchi terra e in particolare far sì che prima che io tocchi terra l'airbag abbia raggiunto una pressione sufficiente per assorbire quell'energia che è compatibile con la prevenzione di una fattura di anca.
Qui c'è l'elemento dell'attivazione, l'elemento del tempo di attivazione, l'assorbimento d'impatto e poi tutta una serie di, diciamo, di altre cose che però sono comunque fondamentali per garantire la protezione.
Ti faccio un esempio: le taglie.
Il fatto che se io ho una circonferenza di 100 cm e compro una L, la protezione sarà effettivamente nella posizione corretta.
Quindi sarà... i due sacchi saranno a protezione della zona dell'anca, anche quello fa parte del processo di certificazione di tutte quelle cose che garantiscono che quando una persona acquista questo prodotto e lo indossa se ha fatto tutto bene, nel senso se ha scelto la taglia giusta eccetera eccetera eccetera se cada è protetto.
E questo è molto importante sia per l'utente che anche per noi giustamente che poi abbiamo una rassicurazione alla nostra volta del fatto che stiamo facendo protezioni serie e non giocattoli.
E sono dispositivi riutilizzabili nel senso che se un anziano cade dopo può riutilizzarlo deve comprare un prodotto nuovo?
Puoi riutilizzarlo e anche da questo punto di vista è stato fatto un enorme lavoro per rendere l'oggetto il più facile possibile.
Diciamo che la facilità la vediamo in due cose.
Torno un attimo alla cintura, però un elemento importante è il fatto che è completamente automatica.
Nel senso che io devo soltanto chiuderla, quindi la indosso, e ha dei sensori magnetici che automaticamente quando io chiudo la fibbia accendono la cintura.
E quindi questo è molto importante perché se pensiamo a una persona di 80 anni difficile pensare che possa ricordarsi di fare particolari operazioni.
Per quanto riguarda anche la sostituzione della cartuccia anche lì abbiamo fatto un grosso lavoro per rendere il più semplice possibile, quindi oggi se una persona cade e si apre l'airbag a quel punto la cintura può essere rimessa in funzione
semplicemente sostituendo la bomboletta, bomboletta che ovviamente ha una componente, che è la bomboletta CO2 classica delle bici o delle pistole ad aria compressa a cui si aggiunge tutta una componente elettromeccanica molto sofisticata che è quella che fa sì che poi sia in grado di sparare nel momento in cui la caduta avviene.
Bene abbiamo approfittato di questo esempio per quanto riguarda gli anziani per fare un approfondimento più di dettaglio su come funziona in generale.
Però anche l'altro settore che citavamo prima è quello dei lavoratori.
Lì quali sono le peculiarità di quel settore anche per una protezione efficace?
Lì, se vogliamo, è simile nel senso che stiamo parlando di persone che sono esposte a rischi molto concreti, che sono esposti a questi rischi per tempi molto prolungati, quindi l'elemento dell'accettabilità diventa fondamentale.
E l'altra cosa buffa che si parla di...
Anzi ci sono a volte degli obblighi se pensiamo a dei dispositivi di protezione individuale quindi potenzialmente lì un lavoratore potrebbe essere obbligato a indossare un dispositivo.
Ecco, purtroppo non i nostri, nel senso che ancora ovviamente si tratta di nuove tecnologie, quindi non sono ancora obbligatori, detto che sono dei percorsi che stiamo ovviamente valutando, quindi in questo caso stiamo parlando di oggetti che devono
essere indossati volontariamente e dove per volontariamente intendo ovviamente tutta la catena organizzativa dell'azienda, cioè ci deve essere una dirigenza che...
Sì, non il singolo lavoratore, ma...
No, però diciamo che poniamo che l'amministratore delegato si innamora del progetto, poniamo che l'RSPP fa la sua valutazione dei rischi e decide che è fondamentale che l'azienda adotti questo prodotto, comunque alla fine della giornata, dovrei sempre far sì che le persone l'utilizzino.
Quindi ci sarà sempre comunque un utente, un lavoratore, che ha tutti i suoi problemi, giustamente della sua quotidianità, che deve effettivamente poter utilizzare un oggetto di questo tipo.
E quindi anche lì, diciamo, che il lavoro che è stato fatto a livello di comfort, di accettabilità, è stato molto importante.
E questi dispositivi come sono fatti?
Cioè, che cose proteggono?
Allora, in questo caso stiamo parlando di protezione principalmente per il busto.
Diciamo che WorkAir in questo momento è declinato in tre prodotti.
Uno che si chiama WorkAir Original, che è il primo che è nato, che protegge il busto e la schiena.
Uno che è WorkAir Light, che è una versione ancora più leggera del WorkAir Original, grazie a una tecnologia di piegatura dei sacchi, tale per cui è praticamente un imbrago, quando serve si gonfia e quindi va a coprire la parte del torace e la parte della schiena.
E un altro prodotto che è il WorkAir Back che invece si concentra sulla parte posteriore quindi con un minor peso e un minor ingombro nella parte anteriore, però ha una protezione per la schiena e un cuscino che si apre anche per attutire il colpo della testa.
Il terzo in particolare è pensato soprattutto per quelle applicazioni di altezze più basse.
Scale.
Esatto.
Facciamo un passo indietro.
WorkAir è pensato per i lavoratori in quota tipicamente con due casi applicativi: uno sono tutti coloro che sono già assicurati quindi chi lavora al di sopra di due metri quindi che deve obbligatoriamente avere un'imbracatura e quindi in quel caso
diciamo che è un airbag che offre una funzione protettiva compensativa quindi io già sono assicurato quindi se cado non ve lo giuro al sesto piano ma rimango appeso all'imbracatura...
Mi posso fare male, però.
Non so se hai mai arrampicato in vita tua, ogni arrampicatore sa che anche se sei assicurato, se si cade da cercando di mettere lo spit successivo tipicamente sfatare più tre metri, sei, e l'impatto contro la roccia può far molto male.
In questo caso il caso applicativo è simile, cioè immaginiamo persone che lavorano magari nel campo dell'edilizia, se io cado magari mi faccio un volo di qualche metro, se colpisco la struttura a cui sono assicurato, comunque mi faccio male.
Quindi questo è il primo caso.
L'altro caso, che è anche, devo dire, quello su cui stiamo vedendo che c'è un bisogno ancora più importante, sono tutti quelli che invece lavorano magari sulle scale o su un trabattello o sul pianale di carico, nell'ambito dei trasporti.
Quindi cadute al di sotto di 2 metri, quindi cadute, chiamiamole, da altezze basse, che però possono essere fatali.
Pensiamo anche al banale cambiare la lampadina, no?
Adesso a me non è mai capitato, ma è capitato a mio padre e cadere dalla scala, una roba per cui, insomma, porti a casa lesioni molto importanti.
Per cui, diciamo, in questo secondo caso applicativo, i mercati principali sono il mercato delle manutenzioni, il mercato dei trasporti, della logistica, diciamo, oppure casi specifici come, non so, la manutenzione nel mondo dell'aeronautica, quelli
che fanno manutenzione sulle ali o sui motori degli aerei, in cui sei ad un'altezza di qualche metro e in quel caso tipicamente non hai niente a cui assicurarti e quindi sei esposto a un rischio concreto e in quel caso è molto utile avere una protezione aggiuntiva come WorkAir.
Se ho visto anche qualche video di WorkAir in azione di questa versione diciamo per le altezze più basse e protegge la testa però non è fastidioso perché è una sorta di cappuccio ribassato quando non è attivo e dopodiché nel momento in cui
dovessi cadere si alza questa sorta di protezione quindi per il resto del tempo che non è attivo non è un particolare ingombro, è come uno zainetto.
Esatto, sì sì, come lo stesso discorso facevamo per il WorkAir Light, diciamo che lì è stato fatto un lavoro veramente intelligente di piegatura dei sacchi e di creazione di... controllo dello sviluppo dei sacchi una volta che vengono gonfiati
come su FutureAge, il sacco è arrotolato in una cintura ma nel momento in cui si attiva si srotola andando a coprire la zona dell'anca anche in questo caso, diciamo nel caso del WorkAir Back come dicevamo c'è un zainetto che poi crea un cuscino
anche per la testa nel caso del WorkAir Lite sono degli spallacci di uno zaino che all'occorrenza si trasforma in una protezione completa.
E la tecnologia come dispositivo indossabile per la sicurezza si limita agli airbag oppure sviluppate anche altre tecnologie per altri settori o comunque con altra utilità?
Come si può utilizzare la tecnologia addosso all'uomo?
Allora, diciamo che fino ad adesso abbiamo parlato del motivo principale per cui esiste D-Air Lab che, dicevamo, è portare la tecnologia D-Air, tant'è anche nel nome dell'azienda, nella quotidianità.
Detto questo, poi come azienda sviluppiamo un sacco di applicazioni anche diverse, nel senso che per poter sviluppare airbag indossabili serve tutto un ventaglio di competenze molto ampio e molto specialistico.
Infatti, diciamo, nella nostra ricerca e sviluppo abbiamo un grande open space con figure che vanno da design, come dicevamo che è molto importante per far sì che i prodotti siano accettati, agli ingegneri elettronici, del firmware, del software, a
tutta una parte di sartorialità, quindi di modelleria, la capacità di prendere questi oggetti che spesso sono rigidi e metterli attorno a un corpo umano in un modo che siano comodi e che non diano fastidio, che poi si traduce anche veramente nella capacità manuale del cucire questi materiali insieme nella maniera più efficace possibile.
Tutte queste competenze qui, ovviamente, sono molto utili nello sviluppo di protezioni airbag, in particolare con anche tutta una competenza molto approfondita nel movimento dell'aria, quindi nella meccanica della fluidodinamica dell'aria all'interno di questi sacchi.
A parte questo ovviamente sono competenze che sono trasversalissime, per cui di fianco allo sviluppo degli airbag in D-Air Lab abbiamo anche tutta una serie di altri progetti che vanno dai gilet sensorizzati pensati in particolare per le donne che
corrono sole la sera o il mattino, quindi diciamo dispositivi che possono in quel caso permettere una chiamata d'emergenza in tempo reale oppure altri progetti che magari non hanno più niente a che vedere con la tecnologia indossabile, ma ne sono
il frutto ad esempio il progetto Antarctica, progetto per cui per l'ENEA abbiamo sviluppato delle tute per i ricercatori che lavorano in Antartide in una stazione Concordia in inverno, quindi stiamo parlando di condizioni di utilizzo estreme,
persone che devono lavorare all'aria aperta con meno 90 gradi di temperatura atmosferica, dicevamo devono però lavorare, quindi hanno bisogno di essere contemporaneamente protette dal freddo, ma anche di poter avere una libertà di movimento e una regolazione termica efficace.
In quel caso abbiamo fatto un progetto molto ampio e molto bello che è partito dallo studio del bisogno, quindi dallo studio del comportamento del corpo umano a temperature estreme, e tutto quello studio è stato fatto con le tecnologie indossabili
di cui parlavamo, quindi con una tuta sensorizzata, contemporaneamente sensorizzata e attuata, quindi una tuta che da un lato misurasse i parametri vitali e la temperatura del corpo in diversi punti, dall'altro anche una parte di attuazione, quindi
di riscaldamento attivo delle diverse parti del corpo, e dalla combinazione di queste due siamo stati in grado di sviluppare una stratificazione per la tuta, per questi ricercatori, che fosse il più efficace possibile.
Ok e anche lì mi dicevi prima che da questo prodotto per condizioni estreme come abbiamo detto anche per sport estremi siete poi arrivati a una versione semplificata però per il mondo diciamo più consumer?
Esatto, diciamo che il progetto Antarctica ha preso due strade che vanno avanti entrambe parallele.
Uno è proprio la fornitura di tute per lavoratori, quindi una fornitura professionale, stiamo continuando a fornire, adesso forniremo un altro numero importante di tute per i ricercatori alla stazione Concordia e in parallelo stiamo anche lavorando con altre spedizioni invece che lavorano nel circolo polare artico.
Quindi se vuoi ambito professionale e ambito estremo, ma stiamo raggiungendo l'altra parte del mondo per cui quel progetto segue il suo binario.
Parallelamente abbiamo preso il cuore di quelle tecnologie che avevamo sviluppato per le applicazioni estreme e le abbiamo tradotte in una linea d'abbigliamento, abbigliamento invernale per le "persone normali", quindi come potremmo essere io e te.
È una collezione che si chiama 75°06', dove 75°06' è la latitudine della stazione Concordia dove tutto il progetto è nato, ed è un brand, una linea d'abbigliamento che, ripeto, prende tutte quelle tecnologie e le traduce adattandole ovviamente
è un clima diciamo alpino, ecco, per cui adattandole non più alla necessità di resistere a 90 gradi sotto zero, ma magari resistere a meno 5, meno 10.
E da lì sono nate tutta una serie anche di reinterpretazioni di questa tecnologia in chiave più quotidiana molto interessanti, adesso cito ad esempio il DomeAir, che è una tecnologia che abbiamo anche brevettato e che è un'imbottitura basata su
un principio abbastanza semplice, ossia di avere uno strato di ovatta che viene forato e rigirato, quindi creando una stratificazione tridimensionale, partendo da un foglio bidimensionale che permette di raggiungere livelli di coibentazione termica altissimi ma con una ventilazione mai vista prima.
Come fosse la piuma del futuro, diciamo, è un'imbottitura che per la prima volta permette di essere contemporaneamente caldi ma non sudare.
Questa tecnologia è applicata all'interno della linea 75°06' ma la stiamo anche adesso cominciando a diffondere come tecnologia per marchi terzi.
E anche su questo devo dire stiamo avendo un riscontro molto interessante.
Anche prima dicevi che è un po' controintuitivo questo perché per stare bene in temperature dove c'è molto freddo non per forza la soluzione migliore è coprirsi sempre di più.
Oltre al fatto che non è non è agile non è facile muoverci con troppi strati, però appunto si può sfruttare veramente tanto la tecnologia dei materiali soprattutto per capire qual è la miglior condizione per sviluppare prodotti di questo tipo.
Eh sì, assolutamente, perché diciamo che anche a 90 gradi sotto zero, nel momento in cui la stratificazione che io ho creato è sufficiente a proteggermi dall'ambiente esterno, a quel punto il problema torna ad essere quello di qualsiasi operazione in cui io utilizzo energia, utilizzo il fisico e quindi cosa succede?
Sudo.
E quindi paradossalmente una volta risolto il problema del freddo, il problema diventa il caldo e quindi riuscire a far sì che questa stratificazione contemporaneamente possa proteggere dall'esterno ma anche gestire internamente la temperatura, di
modo che ad esempio il sudore si allontani del corpo, di modo che non si crei una distinzione netta tra molto caldo e molto freddo, ma si crei una gradazione continua tale per cui, mettiamola così, io abbia una temperatura corporea che mi permette di lavorare senza ritrovarmi che caldo, ecco, mettiamola così.
Perfetto.
Allora grazie mille Marcello perché ci hai permesso di portare a luce anche su un fenomeno di cui non si sente spesso parlare cioè la tecnologia applicata al nostro corpo indossata ai fini della nostra protezione la nostra sicurezza.
Alla prossima.
Grazie.
Grazie alla prossima.
E così si conclude questa puntata di INSiDER - Dentro la Tecnologia, io ringrazio come sempre la redazione e in special modo Matteo Gallo e Luca Martinelli che ogni sabato mattina ci permettono di pubblicare un nuovo episodio.
Per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione@dentrolatecnologia.it, seguiteci su Instagram a @dentrolatecnologia dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti.
In qualsiasi caso nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social.
Se trovate interessante il podcast condividetelo che per noi è un ottimo modo per crescere e non dimenticate di farci pubblicità.
Noi ci sentiamo la settimana prossima.