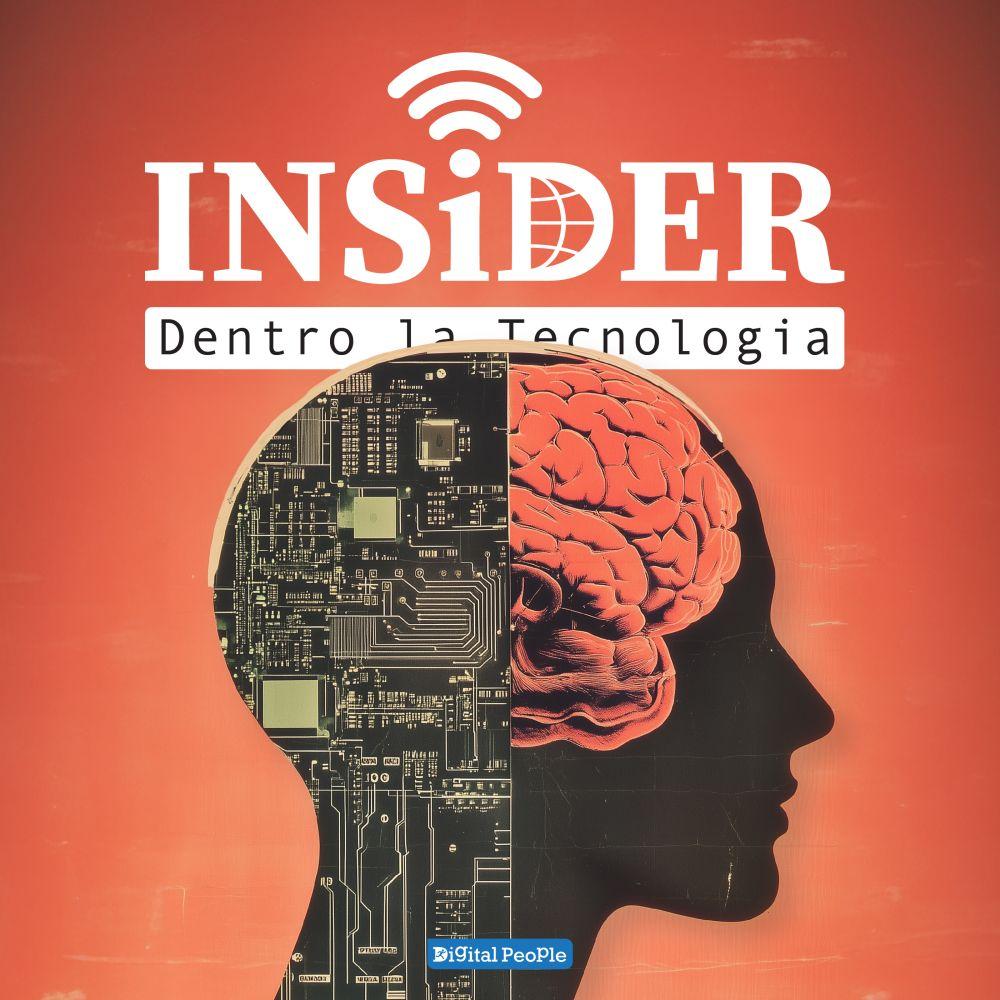La ricerca archeologica e i musei hanno subito una grandissima evoluzione, in cui proprio la tecnologia ha dato la maggiore spinta. Oggi proveremo ad immaginare di entrare all’interno di un museo cercando di concentrarci su ciò che c’è attorno alle opere d’arte: i sistemi di sicurezza, i metodi di conservazione e di restaurazione dei reperti, lo studio delle testimonianze e dei documenti del passato.
Nella sezione delle notizie invece parleremo delle nuove classi energetiche per gli elettrodomestici secondo i nuovi standard dettati dalla Commissione Europea, della multa di 733 milioni di euro per alcune app di food-delivery e infine dei 500 satelliti che Geely lancerà per agevolare la guida autonoma.




Brani
• Ecstasy by Rabbit Theft
• Feel Good by Syn Cole
• Waltz of the Flowers by Tchaikovsky
Salve a tutti, siete all'ascolto di INSiDER - Dentro la Tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host, Davide Fasoli.
Oggi parleremo del ruolo che gioca la tecnologia nel decifrare ma anche preservare e proteggere le testimonianze del nostro passato.
Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a @dentrolatecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito.
al 1 marzo entreranno in vigore le nuove etichette per la classe energetica degli elettrodomestici secondo i nuovi standard dettati dalla commissione europea.
Spariranno le classi energetiche A+, A++ e A+++, e rimarranno solo quelle da A a G, con nuovi criteri più ferrei.
Inizialmente, infatti, solo pochi elettrodomestici potranno vantare una classe energetica di tipo A, mentre saranno più diffusi quelli di tipo B e C.
Una decisione che apre la strada a nuove serie di elettrodomestici molto più performanti ed efficienti dal punto di vista del consumo di corrente elettrica, e così anche i produttori dovranno sforzarsi maggiormente per realizzare prodotti di classi migliori e più attenti all'ambiente.
Ovviamente per gli elettrodomestici prodotti prima di marzo rimarrà la vecchia etichetta, mentre la nuova sarà caratterizzata dalla presenza di un QR code che fornirà maggiori dettagli sul prodotto.
I criteri che definiscono le valutazioni degli elettrodomestici infine verranno aggiornati periodicamente ogni 10 anni, o quando abbastanza prodotti si saranno adeguati agli standard più elevati, affinché le classi energetiche siano allineate con le nuove tecnologie disponibili.
Il settore del food delivery è cresciuto esponenzialmente negli ultimi due anni.
Se infatti nel 2019 il valore di questo mercato si aggirava intorno ai 560 milioni di euro, nel 2020 complici anche i recenti avvenimenti che hanno ridotto drasticamente le vendite delle principali attività di ristorazione tradizionale, i servizi di consegna sono cresciuti di un ulteriore 20%.
Ad ogni modo, se nel 2021 è possibile ordinare un pasto comodamente dal proprio smartphone e riceverlo direttamente alla propria abitazione, non dipende solamente da chi gestisce l'enorme flusso di dati in entrata relativo alle ordinazioni, ma anche da chi consegna fisicamente i pasti negli orari prestabiliti, i Rider, che in Italia ammontano a 60.000 lavoratori.
Le condizioni di lavoro a cui sono sottoposte queste persone tuttavia non sono delle migliori, dato che per rispettare puntualmente gli orari di consegna i Rider devono percorrere diversi chilometri di strada, spesso guidando biciclette e motorini in condizioni in meteo poco favorevoli.
La Procura di Milano, sia per queste ragioni ma anche per la tipologia di contratto poco continuativa e priva di molte tutele, a cui i fattorini sono obbligati a sottostare, ha portato all'apertura di un'indagine che si è conclusa giusto qualche giorno fa con una serie di sanzioni per i servizi di food delivery come just Eat, Deliveroo, Glovo e Uber Eats, per un totale di 733 milioni di euro, e con un obbligo formale per la regolarizzazione degli oltre 60.000 Rider.
Sentiamo molto spesso del nuovo servizio Starlink, targato Elon Musk, che avrà il compito di portare internet a banda larga tramite connessioni satellitari in tutte le zone del mondo, ma non ci siamo mai chiesti se effettivamente questa tecnologia può essere adoperata non solo per colmare le lacune legate alla mancanza di connessione a internet, ma anche ad altre tipologie di servizi.
E per rispondere a questa domanda è entrata in gioco Geely, il colosso dell'automotive proprietario di marchi come Volvo e Lotus, che recentemente ha presentato un progetto per la realizzazione di una costellazione di 500 satelliti in orbita bassa, che avrà il compito di fornire un servizio non tanto legato alla copertura della rete internet quanto alla consolidazione di un sistema di guida autonomo basato su una rete che tracci il posizionamento delle vetture sul globo con una precisione all'ordine del centimetro.
Conoscere il passato, e soprattutto il proprio passato, è forse il modo migliore che abbiamo per comprendere meglio il mondo che ci circonda, per prevedere o immaginare come saremo fra decine o centinaia di anni, ma anche per evitare di ripeterne gli errori.
E forse è anche per questo che l'uomo ha da sempre cercato di lasciare delle tracce del proprio passaggio, in ogni luogo e in ogni epoca, per poter in un certo senso comunicare con il sé del futuro attraverso strumenti, costruzioni architettoniche, opere d'arte o documenti di ogni tipo.
E da qui è nata la necessità e la voglia di cercare, preservare e proteggere queste testimonianze che insieme formano la storia del mondo e la nostra storia.
Pensate, ad esempio, che il primo museo, quello annesso alla biblioteca di Alessandria, che poi fu distrutta e con essa gran parte dei reperti lì conservati, risale al III secolo a.C., più di 2200 anni fa.
Ma cosa c'entra tutto questo con la tecnologia? Beh, con il tempo l'archeologia e i musei hanno subito, soprattutto negli ultimi decenni, una grandissima evoluzione, in cui, come avrete già intuito, proprio la tecnologia ha dato la maggior spinta.
In questa puntata, dunque, immagineremo di entrare all'interno di un museo e di stogliere momentaneamente lo sguardo dalla bellezza delle opere sposte, per concentrarci su ciò che c'è attorno.
I sistemi di sicurezza, i metodi di conservazione e di restaurazione dei reperti, lo studio delle testimonianze e dei documenti del passato, tutti ambiti in cui, appunto, la tecnologia si è resa indispensabile e che sono la forza trainante dei musei e dall'archeologia in generale.
Senza dilungarsi oltre, quindi possiamo iniziare questo piccolo viaggio dietro le quinte della storia.
Siamo al Museo del Louvre, uno dei più importanti al mondo, tralasciando i sistemi di sicurezza che, sì, hanno come base tecnologie, come telecamere di sorveglianza o metal detector, ma non è su questo che si concentrerà la puntata.
In questo museo è conservato quello che forse è il simbolo dell'arte e della bellezza, una delle opere più iconiche della storia, la Gioconda di Leonardo Da Vinci.
Una, tutto sommato, piccola tavola di legno che attira a sé circa 6 milioni di visitatori, come noi, ogni anno.
Visitatori che, da una parte, hanno la necessità di ammirare l'opera nelle migliori condizioni possibili, senza filtri o separatori, ma che, d'altro canto, sono anche una minaccia per lo stesso quadro.
I beni artistici, anche archeologici, infatti sono molto delicati ed è fondamentale che siano rispettate delle condizioni per evitare che questi si rovinino.
Tornando all'esempio della Monnalisa, quindi sarebbe impossibile sporre il quadro all'aria aperta, davanti a visitatori che modificano in continuazione la temperatura e l'umidità della stanza.
Per far fronte a ciò, dunque, la Gioconda, così come molte altre opere sposte nei musei di tutto il mondo, è conservata in una teca di vetro, un vetro particolare, antiriflesso e il più trasparente possibile, per evitare in alcun modo di rovinare la vista dall'esterno.
Ma non basta, all'interno della teca, infatti grazie a una serie di sensori, vi è un sistema di filtraggio dell'aria, che genera un vero e proprio microclima, con le condizioni di temperature e umidità ideali che garantiscono al meglio la conservazione di questo capolavoro.
Un piccolo gioiello di ingegneria che, tra l'altro, è stato sviluppato dal Politecnico di Milano.
Visto che l'immaginazione ce lo concede, spostiamoci ora dall'altra parte del mondo, ad Hong Kong, per la precisione, al centro commerciale di Harbour City, dove nel 2013 il Van Gogh museum di Amsterdam ha esposto cinque opere dell'artista olandese.
Certo, mettere in mostra quadri come i girasoli o campo di grano nei temporali all'interno di un centro commerciale non è forse un po troppo rischioso? Ovviamente, e infatti come forse si poteva intuire, quello che è esposto è il frutto della collezione ”Relievo” del museo di Amsterdam, che consiste in perfette copie a dimensione naturale.
Queste copie sono state realizzate grazie ad una scansione tridimensionale dei dipinti e una successiva stampa ad altissima risoluzione.
In questo modo, oltre a poter essere toccate e ammirate in ogni dettaglio, le copie hanno mantenuto colori, lucentezza, ma anche le piccole increspature superficiali delle fonti originali.
Ultimamente queste iniziative vengono proposte abbastanza spesso, un altro esempio è del 2017, dove alla World Trade Center Station di New York City sono stati esposti con il progetto UpClose dei particolari e delle scene, per così dire, rubate, dalla Cappella Sistina di Michelangelo.
Quello della scansione e della stampa 3D al servizio della storia dell'arte è tra l'altro un tema che va sicuramente approfondito, perché come abbiamo visto ha anche applicazioni pratiche molto interessanti, ma soprattutto molto utili.
Creare modelli tridimensionali, ad esempio di statue, sculture o rilievi, permette infatti di avere a disposizione molte più informazioni, che una semplice fotografia certamente non può dare.
Ma non solo, permette anche di stampare e sostituire con delle copie perfette le opere originali, ad esempio per particolari eventi o nel caso queste non fossero disponibili, e ne è stato un esempio proprio quello del museo di Van Gogh.
Addirittura per una scultura rovinata o incompleta si potrebbero ricreare i pezzi mancanti.
Un esempio? Al Naturalis Biodiversity Center nei Paesi Bassi è in mostra lo scheletro di un triceratopo di 67 milioni di anni fa.
Lo scheletro però era incompleto e grazie alla stampa 3D le ossa mancanti sono state costruite per permettere ai visitatori di ammirare il dinosauro nella sua interezza.
A livello di studi, invece, una scansione ad alta risoluzione può mostrare agli archeologi o ai paleontologi maggiori dettagli del reperto, permettendone una migliore analisi e senza dover preoccuparsi di danneggiarli.
E ancora, grazie alle tecniche di modellazione 3D forense è stato possibile, basandosi sui ritratti, sulle monete dell'epoca e sulle descrizioni dei poeti, ricostruire verosimilmente i volti di personaggi storici come Cleopatra, Enrico IV, Nerone, Gesù e molti altri.
Sempre restando sul tema della restaurazione, poi, voliamo a Roma, ad ammirare l'affresco– quello originale questa volta– di Michelangelo, nella Cappella Sistina.
Il giudizio universale.
Questo capolavoro è stato infatti oggetto di recupero negli anni passati e per farlo si è fatto uso di tecnologia all'avanguardia come la scansione Ara GX.
Questo processo, infatti, permette di osservare in maniera per niente invasiva cosa si cela al di là dell'opera, ma anche di capire quali pigmenti sono stati utilizzati dal pittore.
Informazioni di certo indispensabili nel recupero e nella pulizia dei dettagli.
In questa occasione vennero anche rimosse le censure che erano state imposte dal concilio di Trento, in seguito alla morte di Michelangelo.
Inizialmente, infatti, i corpi erano raffigurati nudi e solo in seguito vennero dipinti dei veli per coprire quello che un tempo era considerato oscenità.
Veli che, grazie al restauro, sono stati per la maggior parte rimossi.
Una notizia molto recente, sempre nell'ambito dell'utilizzo dei Raggi X per operazioni di restauro di opere d'arte, riguarda invece l'autoritratto di Antonio Canova.
Dal progetto nato inizialmente per verificare lo stato delle verniciature sono infatti emersi tracce di pitture estrane all'autoritratto e successivamente, sfruttando la radiografia, si è scoperta la presenza di un dipinto sotto il dipinto, due volti di cui si sa ancora poco.
Chi sono? Sono stati realizzati da Canova? Perché sono stati coperti dall'autoritratto dell'artista? Domande che forse troveranno risposta sullo in seguito ad ulteriori indagini.
Fino ad ora comunque abbiamo visto degli esempi di musei per lo più tradizionali in cui la tecnologia è sì fondamentale per la conservazione e lo studio delle opere e dei reperti.
Impossibile non citare poi quei musei che fanno della tecnologia il loro cavallo di battaglia attraverso esperienze interattive in grado di immergerci a 360 gradi nel mondo dell'opera.
Ma per quanto riguarda invece le tecnologie al servizio dei cittadini per poter accedere alle bellezze della storia ad esempio da casa, ultimamente se ne sente sempre più spesso parlare sul fatto che ad oggi molto spesso non serva più nemmeno andare fisicamente in un museo.
E in tempi ad esempio di pandemia è sicuramente un'opportunità non da poco.
Si tratta dei cosiddetti tour virtuali, grazie ai quali è possibile spostarsi all'interno del museo e vedere le esposizioni direttamente dal proprio PC, o per chi ne è in possesso, con un visore a realtà virtuale o realtà aumentata.
In grado di regalare un'esperienza sicuramente non paragonabile alla realtà, ma quantomeno piacevole.
La Cappella Sistina, la Galleria degli Uffizi, il Duomo di Milano, sono una minuscola parte dei musei disponibili al tour in stile straight view di Google Maps.
E a proposito di Google, anche il più famoso motore di ricerca al mondo ultimamente ha puntato molto sulla cultura e sull'arte.
E lo ha fatto con l'applicazione Arts & Culture, che permette di vedere in alta risoluzione le opere esposte in decine di musei di tutto il mondo, accompagnate da didascalie, curiosità, ma anche esperimenti per, tra virgolette, giocare con l'arte.
Arrivati a questo punto, sarebbe grave non parlare, per ultima ma non per importanza, dell'intelligenza artificiale.
Se ne sente infatti molto spesso discutere e sta letteralmente rivoluzionando innumerevoli ambiti lavorativi e sociali.
E lo studio dell'arte e della storia non sono da meno.
Partiamo subito con un esempio che possa mettere in luce le potenzialità che questa tecnologia può avere.
Nei vari musei del mondo sono custoditi i documenti storici o reperti in lingue tra loro diversissime, di cui alcune ancora inedificate.
E grazie all'apprendimento automatico potremmo finalmente riuscirci.
Il cervello elettronico, per così dire, è in parte pronto ed è già testato.
Pensate che il programma è riuscito a decifrare una variante del greco antico di 3500 anni fa, cercando nei documenti correlazioni alle lingue imparentate proprio col greco.
E questo ha permesso ai ricercatori di comprendere meglio questa lingua, in realtà già decifrata, e identificandone meglio alcune parole.
Ovviamente affinché funzioni l'intelligenza artificiale vi è la necessità di grandi quantità di dati e di testi, e la lingua da decifrare deve essere in qualche modo legata ad altri linguaggi conosciuti.
Rimanendo nell'ambito della scrittura, l'intelligenza artificiale può essere usata e viene usata per trascrivere i testi dei milioni di documenti storici conservati non solo nei musei ma anche nelle biblioteche o negli archivi cittadini.
Questo permetterà agli storici di ricercare molto più facilmente e molto più velocemente parole chiave in mezzo a un'enorme quantità di fonti.
E ancora, l'informatica può essere sfruttata ad esempio per ricostruire parti mancanti di sculture, di opere in compute o di far combaciare i pezzi e i frammenti dei vasi e degli scheletri che vengono ritrovati nei vari scavi archeologici.
Ma forse l'applicazione più interessante riguarda una sorta di creatività che i computer possono acquisire.
Già ora infatti l'intelligenza artificiale è in grado, seppur con molti errori, di creare paesaggi, immagini, volti completamente nuovi e inventati.
Ma soprattutto può essere usata per ricreare, molto più velocemente, ritratti di artisti servendosi degli scritti, di autoritratti o di testimonianze dell'epoca.
Sono già stati realizzati i volti di personaggi come Van Gogh, Alessandro Magno, Giulio Cesare, ma anche figure storiche come la Venere di Milo, che grazie a questa tecnologia ha in un certo senso preso vita.
Siamo giunti alla fine di questo breve viaggio tra storia e arte, passando per diversi musei di tutto il mondo e accorgendoci di come la tecnologia si possa ormai considerare a dir poco fondamentale sia per gli stessi musei, sia per gli studiosi e i ricercatori.
Scansione, modellazione, stampe 3D, radiografie, realtà aumentata e, come abbiamo visto, tanto altro hanno contribuito all'evoluzione enorme di un settore che, a prima vista, sembrerebbe essere molto lontano da questo mondo.
Tuttavia, la conservazione, la preservazione, la restaurazione, ma anche lo studio e la ricerca non solo di opere d'arte del passato e del presente, ma anche dei reperti storici è e deve essere un obbligo morale verso noi stessi e verso i nostri posteri.
E in questo la tecnologia è e sarà la chiave per adempire questa responsabilità, perché è solo conoscendo e tramandando il nostro passato e la nostra storia che potremo prevedere e migliorare il nostro futuro.
E così si conclude questa puntata di INSiDER - Dentro la Tecnologia.
Io ringrazio come sempre la redazione e in special modo Matteo Gallo e Luca Martinelli che ogni sabato mattina ci permettono di pubblicare un nuovo episodio.
Per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione@dentrolatecnologia.it, seguiteci su Instagram a @dentrolatecnologia dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti.
In qualsiasi caso nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social.
Se trovate interessante il podcast condividetelo che per noi è un ottimo modo per crescere e non dimenticate di farci pubblicità.
Noi ci sentiamo la settimana prossima.