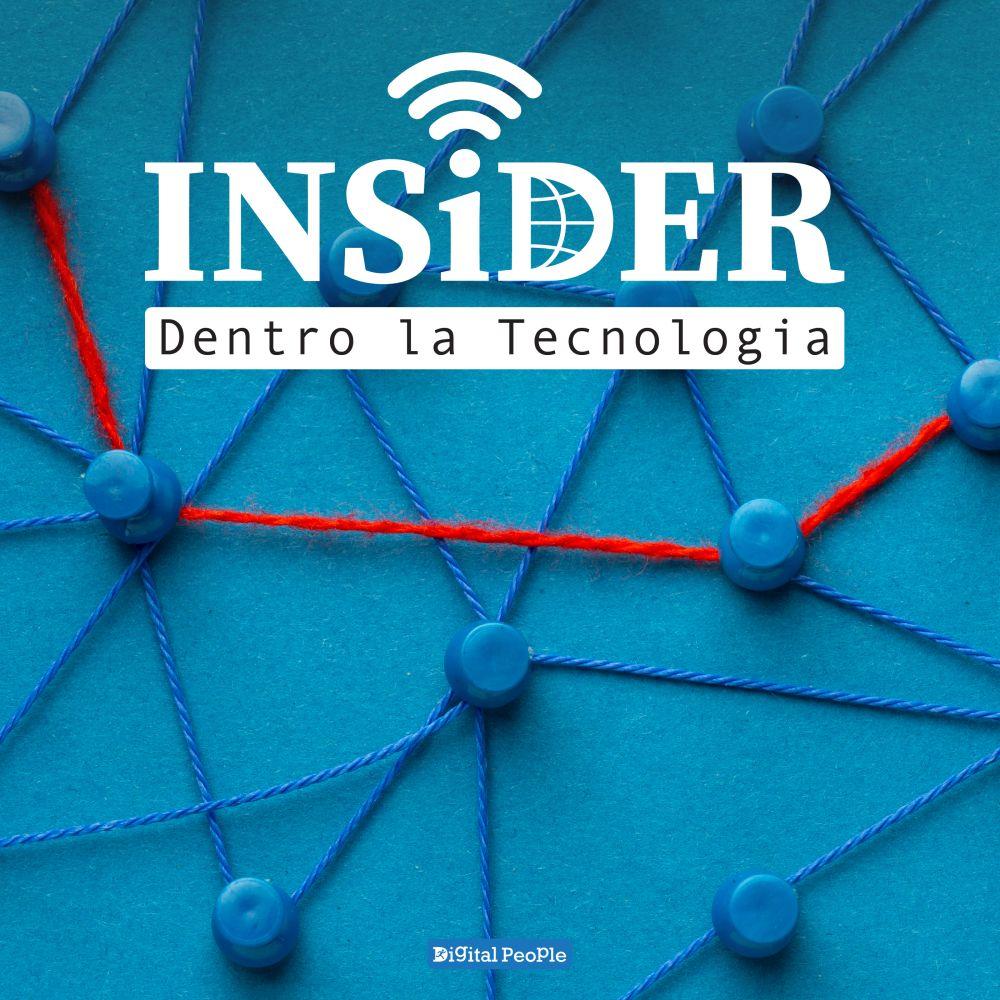Nel piano nazionale di ripresa e resilienza che disegna le misure da attuare al fine di consentire la piena ripartenza del Paese dopo lo stop causato dalla pandemia si parla anche di idrogeno. Alla seconda delle sei missioni presenti nel testo, “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, sono stati stanziati circa 18 miliardi di euro, di cui 2 miliardi solamente per la voce “idrogeno”, una particolare soluzione energetica caratterizzata da una vasta gamma di proprietà utili, sulla quale abbiamo fatto una chiacchierata con Matteo Gallo, autore di INSiDER - Dentro la Tecnologia.
Nella sezione delle notizie parliamo della pubblicazione dei dati rubati nei confronti di SIAE e ULSS 6, del Tonga senza connessione a causa dei danni riportati ad un cavo sottomarino in fibra ottica e di Microsoft che comprerà Activision Blizzard.




Brani
• Ecstasy by Rabbit Theft
• Capsized by Tollef
Salve a tutti, siete all'ascolto di INSiDER - Dentro la Tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host, Davide Fasoli.
Oggi parleremo di idrogeno nel settore della mobilità sostenibile, e cercheremo di capire in quali ambiti potrà e in quali non potrà avere un futuro.
Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a @dentrolatecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina, su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito.
Il 14-15 gennaio sono stati pubblicati, in seguito al rifiuto di pagare il riscatto, i dati rubati rispettivamente a SIAE e all'azienda ospedaliera di Padova, ULSS6.
Per quanto riguarda SIAE, in particolare, sono disponibili pubblicamente sul dark web, quasi 60 GB di file, tra cui dati personali degli artisti, dati medici, come richieste di invalidità, IBAN, ricevute e molto altro.
Discorso analogo per ULSS Euganea, con quasi 10.000 file pubblicati, contenenti file PDF, documenti Word ed Excel e molto altro.
File che contengono informazioni sulla gestione e sui pagamenti del personale, referti, medici, esiti dei tamponi, visite al pronto soccorso e così via.
Sono presenti anche file database contenenti gli storici degli esami medici svolti o informazioni sui pazienti.
Sia questo, sia quello di SIAE sono quindi episodi gravissimi, e nonostante la scelta di non pagare alcun riscatto sia stata giusta, tali furti non sarebbero mai dovuti accadere, soprattutto quando in ballo ci sono dati sensibili di centinaia se non migliaia di cittadini.
La speranza è che questi episodi siano una lezione e un punto di partenza per una campagna di informazione e sensibilizzazione sul tema della sicurezza informatica, dove nel caso di aziende sia pubbliche che private, ogni dipendente ha una possibile
porta ad accesso per i dati, ed è dunque di fondamentale importanza che ognuno abbia l'educazione e le competenze adeguate per custodire le informazioni.
L'unico cavo in fibra ottica per le telecomunicazioni che collega il regno polinesiano di Tonga al resto del mondo è stato danneggiato dalla violenta eruzione vulcanica di sabato 15 gennaio 2022 e le ridotte comunicazioni e l'assenza di internet stanno provocando seri problemi nella gestione dei soccorsi.
Inoltre, rimanere senza internet non significa solamente non poter accedere ai social network, a YouTube o alla musica in streaming, ma anche non poter effettuare pagamenti elettronici e tutto ciò crea delle ulteriori complicazioni in queste situazioni.
Per il momento l'arcipelago comunica con il resto del mondo grazie ad alcuni telefoni satellitari messi a disposizione dalle ambasciate, le riparazioni dei cavi sottomarini in fibra ottica non sono semplici e richiedono molto tempo per essere svolte, anche perché queste riparazioni sono soggette alle condizioni meteo e del mare.
La riparazione dovrebbe avvenire tramite dei sommergibili robot con i quali si agganceranno le parti danneggiate del cavo per portarle in superficie, in modo da effettuare la riparazione sulla nave e tutto questo procedimento potrebbe richiedere alcune settimane.
All'insaputa di tutti, questa settimana Microsoft ha annunciato che acquisirà Activision Blizzard, la nota azienda produttrice di videogiochi per PC e per console come World of Warcraft, Hearthstone, Call of Duty e per mobile, tra i quali spicca il celebre Candy Crush.
Per ottenere il controllo di Activision Blizzard e di tutte le sue sussidiarie, l'azienda sviluppatrice di Windows intende sborsare un capitale di 68,7 miliardi di dollari, un'operazione finanziaria nel settore videoludico che, se dovesse andare a
buon fine, scalzerebbe il record recentemente raggiunto da Take Two con l'acquisizione di Zynga per quasi 13 miliardi di dollari.
In questo caso, salvo aggiornamenti dell'ultimo minuto, l'assorbimento di Activision da parte di Microsoft deve essere approvato dalle autorità regolatorie, le quali avranno il compito di stabilire se un'operazione finanziaria di tale portata potrebbe rappresentare un rischio per la concorrenza nel settore videoludico.
Il 24 aprile 2021 è stato presentato in consiglio dei ministri il testo definitivo del Recovery Plan, ovvero il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che designe alle misure da attuare al fine di consentire la piena ripartenza del Paese dopo lo stop causato dalla pandemia da Covid-19.
Alla seconda delle sei missioni presenti nel testo, energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, sono stati istanziati circa 18 miliardi di euro, di cui 2 miliardi solamente per la voce idrogeno, una particolare soluzione energetica
caratterizzata da una vasta gamma di proprietà utili, di cui parliamo proprio oggi con Matteo Gallo, autore di questo podcast.
Bentornato Matteo.
Grazie, un saluto a tutti.
Partendo dalle basi, puoi dirci che cos'è concretamente l'idrogeno e quali sono le modalità con cui è possibile ottenerlo attualmente?
Certo, allora quando parliamo di idrogeno, normalmente facciamo riferimento al primo elemento chimico presente nella tavola periodica, e si tratta in sostanza del più leggero fra tutti, poiché l'atomo elementare di idrogeno possiede solamente un protone ed un elettrone.
La forma molecolare di questo elemento, che tra l'altro è il più diffuso in tutto l'universo– non a caso è il componente principale delle stelle– la si trova in forma di gas biatomico nel quale due atomi di idrogeno sono saldati tra loro tramite un legame covalente.
Detto ciò, ora potremmo pensare, se è effettivamente così diffuso, perché allora non lo stiamo già utilizzando?
La risposta è che sulla Terra non c'è.
Vi sono sì alcuni piccoli giacimenti in cui è possibile estrarlo, ma nella maggior parte dei casi non è così reperibile come il metano, ad esempio, che basta scavare per ottenerlo.
Se fossimo su uno dei pianeti gassosi come Giove o Saturno non avremmo problemi, ma allo stato attuale delle cose l'unica maniera per ottenere idrogeno molecolare è ricavarlo tramite processi particolari.
Chiaro, dunque l'idrogeno, mi pare di aver capito, non è propriamente una fonte di energia come la intendiamo, pensiamo ad esempio al metano, bensì un vettore energetico, quindi un composto che per definizione deve essere prodotto e raccolto a partire da una fonte di energia precedente.
Esatto, e infatti al giorno d'oggi il modo più efficace per produrre idrogeno è ricavarlo proprio dal metano.
In questo gas, la cui formula corrisponde a CH4, è presente idrogeno, H4.
Tuttavia, negli attuali processi chimici di estrazione si viene a generare come sostanza di rifiuto proprio la CO2, che per forza di cose andrà direttamente in atmosfera.
Analogamente, un altro processo termochimico consiste nell'estrazione dell'idrogeno a partire dal carbone che, come possiamo già immaginare, comporta inevitabilmente anch'esso un rilascio di energia carbonica.
Ecco, questi due processi generano il cosiddetto idrogeno grigio o marrone, che sono da evitare assolutamente in un periodo delicato dal punto di vista ambientale come quello attuale.
Sì, immagino però che ci siano delle modalità green e quindi a impatto zero per ottenere l'idrogeno.
Allora, attualmente per ricavare il cosiddetto idrogeno verde, quindi senza emissione di CO2, si utilizza un processo chimico molto conosciuto che è l'elettrolisi, il quale consiste sostanzialmente nell'elettrificare delle molecole di acqua con
formula H2O per ricavare da quest'ultima idrogeno e come prodotto di scarto al posto dell'anidride carbonica ossigeno, che andrà poi rilasciato tranquillamente e senza alcun impatto negativo nella nostra atmosfera.
Tuttavia, c'è un grosso problema relativo a questa procedura, ossia che per ottenere idrogeno tramite elettrolisi serve un grandissimo quantitativo di energia elettrica.
Per fare un esempio, per produrre un kilogrammo di idrogeno sono necessari 50 kWh di elettricità, che equivangono circa al fabbisogno energetico medio di una famiglia italiana in una settimana e di un paio di giorni per quanto riguarda il metano.
Ovviamente mi sono dimenticato di dirlo, ma per ottenere idrogeno sostenibile l'energia che si utilizza nel processo di elettrolisi deve provenire da fonti rinnovabili.
Ho capito, ora però vorrei soffermarmi un attimo sul settore dei trasporti, in particolare su quello che conosciamo molto bene, abbiamo già affrontato più volte in puntata, automobilistico, il settore automobilistico.
E prima di farti la prossima domanda, volevo citarti un'affermazione particolare del CEO di Volkswagen sul futuro delle auto ad idrogeno, ovvero che l'idrogeno verde, più che nel settore automobilistico, quindi comune, il settore civile, dovrebbe
essere impiegato in altri ambiti, poiché si tratta di un composto particolarmente costoso, inefficiente e difficile da diffondere e da trasportare.
E quindi, proprio in seguito a questa affermazione, mi sapresti spiegare perché l'idrogeno non sta avendo lo stesso successo dell'elettrico per quanto riguarda appunto il settore automobilistico?
Sì, e la risposta è abbastanza intuitiva, come potremmo vedere.
Secondo quanto detto prima, se per produrre un kg di idrogeno sono necessari circa 50 kWh di energia, per riempire un veicolo mosso da celle a combustibile in grado di contenere all'incirca 6 kg di idrogeno, saranno necessari 300 kWh per produrlo.
Un'auto elettrica, in cui non è necessario che l'energia venga generata dal veicolo, i consumi sono 4-5 volte più ridotti, dato che i pacchi batteria, come quello di una Tesla Model 3 ad esempio, hanno una capacità che si aggira intorno ai 50-70 kWh.
Ma non è tutto, perché se da una parte l'auto elettrica vanta un rendimento del 75% circa, ossia che per 100 W di potenza l'auto elettrica ne andrà a sfruttare 75, per un veicolo ad idrogeno invece il discorso cambia e in negativo, perché il
rendimento scende in questo caso addirittura al 25-30%, e questo per colpa dei diversi processi necessari per ricavare l'energia dall'idrogeno presente nelle cellule combustibile.
Infine, per poter essere correttamente immagazzinato all'interno della vettura, l'idrogeno deve essere compresso, e questo per via della sua bassissima densità.
Facciamo nuovamente un paragone con il metano.
Se in condizioni standard a un bar di pressione il metano ha una densità di 0,72 kg su metro cubo, l'idrogeno ottiene solamente un magro 0,9%.
Quindi, per poter essere utilizzato nelle auto ad idrogeno, questo gas così leggero deve essere immagazzinato in modo tale da aumentarne consideravelmente la densità, per evitare appunto di portarsi dietro ogni volta un rimorchio pieno di gas.
E per ottenere quindi 5-6 kg che può contenere la macchina, l'idrogeno deve essere compresso fino a 700 bar, ovvero 700 volte la pressione normale.
Poi un'altra soluzione può essere la liquifazione, ma anche in questo caso risulterebbe un processo eccessivamente dispendioso, perché per ottenere tale condizione si dovrebbe abbassare la temperatura a 273 gradi sotto lo 0.
Lo Space Shuttle ad esempio funzionava con idrogeno e ossigeno liquido, però stiamo parlando della NASA e di budget decisamente più elevati di un cittadino comune.
Sì, mi viene da pensare che la stessa infrastruttura di ricarica allo stato attuale delle cose non sia nemmeno paragonabile a quella realizzata appositamente per i veicoli elettrici, che sappiamo essere elemento cardine della mobilità sostenibile promossa all'interno del PNRR che citavamo prima.
Ma allo stesso tempo penso sia logico pensare che la questione della rete di ricarica per le auto a idrogeno non sia un problema di base, bensì una diretta conseguenza del fatto che il settore del fuel cell electric vehicle è attualmente poco affermato nel mercato automobilistico.
Esatto, e aggiungerei alla tua affermazione che le modalità di trasporto di questo vettore energetico al giorno d'oggi sono alquanto complicate, perché essendo appunto la più piccola molecola presente nell'universo, l'idrogeno ha una spiccata
capacità di intrufolarsi negli interstizi dei componenti metallici delle condotte, con rischi di infragilimento delle infrastrutture e conseguente fuoriuscita del materiale.
Di conseguenza a tutto ciò andrebbero sommati anche i costi per la realizzazione di una nuova rete di condotti studiati ad hoc per il trasporto dell'idrogeno, perché le attuali infrastrutture per gli altri gas non andrebbero assolutamente bene, per i motivi che ti ho citato prima.
Mi pare quindi di capire che l'idrogeno, a meno che non avvengano netti miglioramenti nei prossimi decenni, non avrà un ruolo poi così impattante nel processo di decarbonizzazione dei trasporti leggeri.
E non è infatti un caso che l'industria mondiale dell'automotive abbia già investito in modo estremamente massiccio nella tecnologia elettrica a batteria in negli ultimi decenni, anzi nello specifico nell'ultimo decennio.
Presentando sul mercato, e appunto l'abbiamo visto e lo vediamo sempre di più oggigiorno, nuovi modelli di veicoli elettrici che risultano oggi l'unica opzione economicamente percorribile sul lungo termine.
Se però spostiamo la prospettiva e facciamo riferimento al trasporto pesante, mi viene da pensare a camion per il trasporto di merci, autobus per la mobilità urbana, trasporto ferroviario, navale, anche per questi casi vale il ragionamento che
abbiamo fatto in precedenza, ovvero che l'idrogeno attualmente non è una soluzione economicamente e logisticamente realizzabile?
Allora, in realtà nel caso del trasporto merci su gomma, così come negli altri casi che hai citato valgono le stesse condizioni avanzate precedentemente in merito al trasporto leggero, ovvero che la tecnologia elettrica a batteria rimane comunque
preferibile alla tecnologia ad idrogeno, con celle combustibili, sia per motivi legati all'efficienza del motore che per la rete di ricarica, ormai capillari in gran parte dei paesi di tutto il mondo, elemento distintivo che difficilmente verrà raggiunto anche dall'idrogeno.
Dall'altra parte però, essendoci molta più capacità nel serbatoio di un camion o di una nave o di un treno, rispetto a quello di una macchina, i tempi di ricarica in questo caso pendono a favore del veicolo ad idrogeno, e questo perché caricare
un mezzo che monta un pacco batteria 10 o 20 volte più capiente di quello di un auto richiederebbe tempistiche estremamente prolungate, cosa che non avrebbe nel caso di un caricamento di un serbatoio per idrogeno.
Inoltre, altro aspetto da considerare, i mezzi pensati per il trasporto di merci o persone percorrono quasi sempre gli stessi tragitti, mentre noi comuni cittadini che utilizziamo l'auto, oltre al tragitto casa-lavoro, non sappiamo per quale motivo domani o dopodomani dovremmo spostarci, e men che meno, il tragitto preciso che andremo a fare.
Di conseguenza, produrre attraverso ad esempio impianti fotovoltaici e contemporaneamente distribuire idrogeno verde nei grandi centri dislocati nel nostro paese, diventerebbe in questo caso una soluzione ideale per tutti quei mezzi pesanti che
percorrono ogni giorno le stesse strade, i stessi binari o le stesse route, fermo restando che il problema alla base rimane sempre lo stesso, ovvero che per produrre così tanto idrogeno serve ancora più energia rinnovabile, cosa che attualmente non abbiamo.
Quindi in conclusione, per arrivare ad avere un'economia fondata sull'idrogeno, dobbiamo prima incrementare enormemente la produzione di elettricità rinnovabile, con l'obiettivo di diventare un paese energeticamente autosufficiente, e solo poi
potremmo iniziare a pensare di utilizzare quel surplus di energia che ci avanza, tra virgolette, per produrre e immagazzinare idrogeno da impiegare come vettore energetico per camion, autobus, navi o aerei.
E tutto questo temo che difficilmente avverrà tra qualche anno.
Ledo Vabbè, grazie Matteo per averci portato questo tuo approfondimento sulla mobilità legata all'idrogeno.
Alla prossima qui, qui in puntata Matteo.
Grazie per essere rimasti fin qui, alla prossima.
E così si conclude questa puntata di INSiDER - Dentro la Tecnologia, io ringrazio come sempre la redazione e in special modo Matteo Gallo e Luca Martinelli che ogni sabato mattina ci permettono di pubblicare un nuovo episodio.
Per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione@dentrolatecnologia.it, seguiteci su Instagram a @dentrolatecnologia dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti.
In qualsiasi caso nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social.
Se trovate interessante il podcast condividetelo che per noi è un ottimo modo per crescere e non dimenticate di farci pubblicità.
Noi ci sentiamo la settimana prossima.