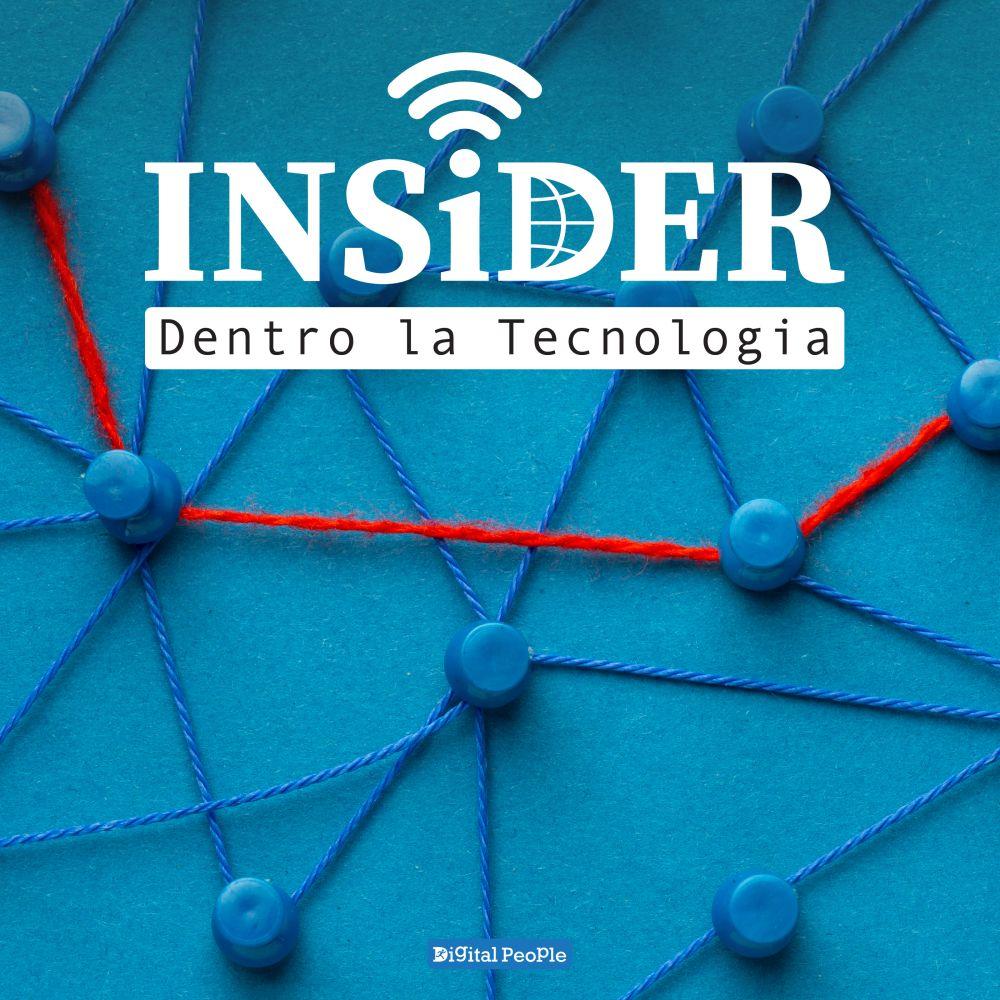Gli impianti termici per il riscaldamento degli edifici hanno infatti un’incidenza sul totale delle emissioni di CO2 in ambito urbano fino a 6 volte superiore rispetto all’incidenza del traffico veicolare. E in un paese come l’Italia, in cui ben 8 milioni di persone vivono in case con problemi strutturali, di isolamento o con scarsa efficienza energetica, non è ammissibile che la questione venga continuamente rimandata al giorno dopo; proprio per questo in questa puntata cercheremo di capire come le tecnologie sviluppate per i pannelli solari e fotovoltaici possano ridurre il nostro impatto sul pianeta.
Nella sezione delle notizie invece parliamo dei progressi compiuti dalla rete Starlink, della fine del cashback di Stato e dell’enorme furto di dati nei confronti di LinkedIn.




Brani
• Ecstasy by Rabbit Theft
• Don't Be A Stranger by Cartoon (Ft. Jason Diaz)
Salve a tutti, siete all'ascolto di INSiDER - Dentro la Tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host, Davide Fasoli.
Oggi torneremo a parlare delle nostre abitazioni e come grazie alla tecnologia sviluppata per i pannelli solari e fotovoltaici possiamo ridurre il nostro impatto sul pianeta.
Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a @dentrolatecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina, su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito.
Durante un'intervista rilasciata al Mobile World Congress di Barcellona, Elon Musk ha dichiarato che la connessione ad Internet generata dalla costellazione di Satellite Starlink coprirà tutta la Terra entro la fine di agosto.
Perché infatti la rete satellitare conti solamente 1500 unità, attualmente la potenza di oltre 5 megawatt riesce comunque a generare verso la Terra un traffico pari a 30 terabyte al secondo di dati, con una latenza compresa tra i 20 e i 40 millisecondi.
Musk ha poi proseguito con l'intervento annunciando che la compagnia è intenzionata a ridurre in futuro il costo di acquisto dei kit di connessione, portandolo da un prezzo di 500 dollari ad un valore che si dovrebbe aggirare intorno ai 200 e i 350 dollari.
I merito al servizio vero e proprio, il CEO di Starlink ha invece confermato che nonostante l'ottimo trend positivo relativo all'ingresso nel servizio dei nuovi clienti, il prezzo dell'abbonamento rimarrà di 100 dollari al mese per tutti i paesi del mondo.
Una scelta commerciale più che legittima, visto l'enorme progresso tecnologico portato nel settore delle telecomunicazioni.
Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha annunciato la sospensione del cashback di Stato, confermando che dal 1 luglio non sarà più possibile accumulare rimborsi dai pagamenti con moneta elettronica.
Secondo Draghi, la formula del rimborso non funziona ed è alla base della decisione di ripensare l'iniziativa, che era stata partorita dal secondo governo guidato da Giuseppe Conte.
Il cashback di Stato è nato come una misura per contenere l'evasione fiscale e quindi incentivare le transazioni in moneta elettronica, che sono tracciabili.
Nel momento in cui però la misura coinvolta qualsiasi categoria merceologica, la spesa per lo Stato è stata eccessiva, perché secondo l'attuale governo avrebbe avuto maggior senso concentrare gli sforzi nei settori commerciali dove i pagamenti non tracciati sono molto più frequenti.
La misura quindi, seppur sulla carta avesse un suo senso e potrebbe ancora averlo in futuro, va ripensata.
Online sono stati messi in vendita i dati personali di 700 milioni di utenti LinkedIn, dati che inoltre comprendono quelli dei 500 milioni di utenti che erano stati rubati sempre a LinkedIn nell'aprile scorso.
La società però non si dichiara colpevole, in quanto il furto non è stato causato da una falla nella loro piattaforma o nei loro server, ma semplicemente sono dati raccolti tramite la tecnica del web scrapping.
In altre parole, i dati che gli utenti rendono visibili sulla piattaforma e dunque visibili a chiunque sono stati raccolti da un programma, che andando ad analizzare automaticamente le pagine dei vari profili, come farebbe ad esempio un motore di
ricerca come Google, ha raccolto e organizzato i dati disponibili per poter poi essere rivenduti illegalmente, ad esempio ai fini di spam.
Su LinkedIn, infatti, non è strano rendere pubbliche informazioni di contatto o della propria carriera, per collaborazioni o richieste di lavoro.
E proprio per questo il social network forse dovrebbe implementare ulteriori sistemi di sicurezza per evitare che eventi simili ricapito in un futuro.
La lotta al cambiamento climatico è oggi considerata come una delle sfide più impegnative per il nostro pianeta.
Praticamente ogni giorno sentiamo parlare in televisione sui giornali di scioglimento dei ghiacciai con relativo innalzamento dei mari, condizioni meteorologiche estreme che si riflettono principalmente in tempeste, uragani e alluvioni arrivando
infine a lunghi periodi di siccità, causati da ondate di calore senza precedenti come quella che si sta verificando proprio in queste settimane.
Secondo il quinto rapporto di valutazione del Comitato intergovernativo per i cambiamenti climatici, senza un corretto intervento sulle politiche relative alle emissioni di gas serra nell'atmosfera, entro fine secolo si produrrà un riscaldamento globale, compreso fra i 2 e i 4 gradi.
Attualmente, per quanto ci riguarda, l'Unione Europea si colloca tra le potenze economiche più dinamiche nella lotta alle emissioni di sostanze clima alternanti.
Entro il 2018 è riuscita infatti a diminuire il rilascio di tali agenti del 23% rispetto al livello del 1990 e si sta impegnando a raggiungere la decarbonizzazione entro il 2050, esattamente in linea con quanto stabilito dal Green Deal del 2019.
Ma tutto ciò ancora non basta, perché se da un lato vi è un importante impegno formale da parte delle medie o grandi imprese nella realizzazione di una produzione sostenibile e sempre meno dipendente dai combustibili fossili, dall'altra parte è
necessario che anche la popolazione affronti questo problema globale, adottando uno stile di vita avvolto alla tutela ambientale, a partire dalla propria abitazione.
Nel corso degli ultimi anni, il risparmio energetico sia degli edifici che delle singole abitazioni all'interno di esse è diventato un fattore sempre più importante per quanto riguarda la riduzione del rilascio di sostanze inquinanti e degli sprechi che vi possono essere in senso generale.
In merito a ciò, nel nostro Paese, con la pubblicazione del decreto legislativo 192 del 2005, è stata disposta una catalogazione degli edifici in classi energetiche predefinite e una serie di nuovi standard progettuali per le strutture abitative.
Tutto ciò con l'obiettivo di limitare non solo i consumi energetici complessivi, ma anche le emissioni di anidride carbonica.
Attualmente, gli standard energetici nazionali attribuiti ad ogni singolo edificio sono 10 e per ognuno di essi viene inoltre identificata una fascia di valori legata all'utilizzo di energia, i cui estremi rappresentano il consumo minimo e il consumo massimo.
Il merito alle singole classi, invece, è se vengono identificate secondo una scala di lettere dell'alfabeto, la quale inizia dall'ag, equivalente allo standard meno efficiente, e arriva fino alla lettera A.
Unica classe suddivisa in altre quattro sottocategorie, in cui l'A4 rappresenta la categoria più produttiva e quindi migliore per risultati.
Per fare un esempio pratico, un edificio in classe A consuma una media tra 1 e 3 litri di combustibile per metro quadro per riscaldarsi, mentre un edificio in classe G ne consumerà circa 15 di litri.
Perciò la spesa finale andrà ad essere ben 5 volte maggiore rispetto a quella di partenza.
Per quanto riguarda invece l'attribuzione dei vari standard relativi alla valutazione finale dell'efficienza energetica dell'immobile, devono essere considerate simultaneamente tutte quelle componenti strutturali appartenenti all'ambito che possono essere classificate in sistemi passivi e sistemi attivi.
Nella prima categoria citata rientrano tutti gli elementi dell'abitazione che tendono a ridurre la domanda di energia richiesta per la struttura, come ad esempio i pavimenti, i sistemi di isolamento, le pareti, il tetto, gli infissi e così via.
Mentre i sistemi attivi, sicuramente più interessanti da un punto di vista tecnologico, corrispondono a tutte quelle strutture che completano la domanda di energia richiesta con l'uso di fonti rinnovabili come impianti eolici, fotovoltaici e solari.
Infine esistono poi altri sistemi fondamentali come i pavimenti riscaldati o le caldaie a condensazione, che se alimentati proprio da sistemi cosiddetti attivi, consentono di ridurre ulteriormente la produzione energetica proveniente da fonti non rinnovabili.
Ma proseguiamo ora analizzando i principali apparati, ritenuti fondamentali per il raggiungimento delle classi energetiche più efficienti, come può essere l'A4.
Prima di entrare nel dettaglio con l'analisi dei principali impianti per migliorare la condizione energetica di un edificio, è bene definire prima quali sono i requisiti minimi per raggiungere la classe attualmente più elevata.
Nel 2021, per essere classificato nello standard A4, un immobile deve innanzitutto possedere una solida struttura in telaio antisismico, costituita da travi e pilastri in cemento armato, capaci di sostenere eventuali carichi anche sotto lo stress di un terremoto.
Un ottimo isolamento termico, con muri e tetti edificati con materiali isolanti ad alta efficienza, e infine un buon impianto di riscaldamento e raffreddamento realizzati utilizzando le tecnologie più vantaggiose.
I merito a quest'ultima condizione, per evitare che questi sistemi vadano a prelevare l'energia dalla rete elettrica, al giorno d'oggi si cerca di installare nelle moderne abitazioni anche dei validi impianti fotovoltaici o solari, in grado di rendere le famiglie o le aziende indipendenti e autosufficenti da un punto di vista energetico.
Benché le voci fotovoltaico e solare siano ortograficamente diverse, in realtà i due termini non sono sinonimi l'uno con l'altro.
E infatti, secondo le attuali definizioni, un impianto fotovoltaico corrisponde ad un sistema in grado di convertire la luce solare in energia elettrica, mentre, nel secondo caso nell'impianto solare, la luce del sole viene sfruttata per il riscaldamento dell'acqua sanitaria domestica.
Dunque, essendo diverse, come funzionano nello specifico le due tecnologie?
La componente più importante di un impianto fotovoltaico risiede essenzialmente, appunto, nel campo fotovoltaico, che corrisponde all'insieme di tutti i pannelli, grazie ai quali è possibile convertire la luce del sole in corrente elettrica attraverso materiali sensibili come il silicio.
Nello specifico, ogni impianto possiede un numero di celle diverse, poiché la richiesta energetica di un edificio rispetto ad un altro non è sempre la stessa.
Ed infatti, proprio per queste ragioni, le potenze sviluppate dagli impianti più diffusi sono generalmente di 3, 6 e 9 kW, con prezzi di installazione che partono da circa 7.000 euro e arrivano fino a 20.000 euro.
I pannelli fotovoltaici vanno poi collegati per legge ad un sezionatore, il quale consente di scollegare l'impianto in caso di interventi sulla rete o con picchi di tensione, e successivamente ad un inverter, ossia un dispositivo essenziale che si
occupa di convertire la corrente continua prodotta dall'impianto in corrente alternata pronta per alimentare le varie apparecchiature.
Fondamentale è anche la presenza di un sistema elettronico di monitoraggio connesso a Internet per ponderare la produzione dell'impianto o eventualmente intervenire in tempo reale in caso di guasto o malfunzionamento.
Come accennato poco fa, inoltre gli impianti fotovoltaici sono composti da celle fotovoltaiche di silicio puro al 99%, ma ciò non significa che siano tutti uguali.
Le tipologie di pannelli variano infatti a seconda del grado di rendimento e di efficienza che possono garantire, e attualmente la stragrande maggioranza degli impianti fotovoltaici ad uso domestico e industriale monta pannelli in silicio monocristallino o policristallino.
Nel primo caso, con pannelli monocristallini, siano performance generalmente migliori grazie soprattutto a celle di silicio che possiedono una maggiore purezza e un alto grado di regolarità nella disposizione reticolare dei singoli cristalli,
comportando una minor quantità di spazio occupato e un rendimento mediamente maggiore rispetto all'altra tipologia.
Ed infatti i pannelli policristallini, essendo caratterizzati da un forte disallineamento dei cristalli, che costituiscono il reticolo, richiedono molta più superficie per generare la stessa potenza delle celle monocristalline, anche se il costo in proporzione risulta comunque minore rispetto alla prima tipologia.
Ma veniamo ora alla seconda tecnologia introdotta in precedenza, in grado di sfruttare la luce, o meglio il calore, proveniente dal sole.
A differenza del fotovoltaico, un impianto solare termico è un sistema in grado di trasformare le onde elettromagnetiche provenienti dal sole in energia termica, e che consente non solo di riscaldare le abitazioni durante i periodi invernali, ma anche di garantire loro acqua sanitaria a diverse temperature.
Per quanto riguarda le principali componenti, esse corrispondono ad un collettore solare, un serbatoio di accumulo, un generatore di integrazione come ad esempio una pompa di calore, e infine una centralina di controllo.
Analogamente poi ai sistemi fotovoltaici, i pannelli che possono essere sfruttati in un impianto solare termico possono essere di diverse tipologie.
Degni di nota troviamo ad esempio i classici moduli solari vetrati, attualmente impiegati per la produzione di acqua calda ad uso sanitario e più costosi pannelli a tubi sotto vuoto, installati maggiormente nei paesi più freddi, in grado di rendere fino al 20% in più con temperature minori.
Avviamoci ora verso la conclusione della puntata con qualche riflessione sul futuro della sostenibilità domestica.
Al giorno d'oggi siamo ben consapevoli che l'inquinamento generato dalle attività umane non è causato solamente dagli innumerevoli mezzi di trasporto che circolano ad ogni ora del giorno.
Le nostre abitazioni, i negozi, gli uffici, i centri commerciali e gli ospedali sono solo alcuni dei luoghi attualmente responsabili delle grandi emissioni di particolato nell'atmosfera.
Gli impianti termici per il riscaldamento degli edifici hanno infatti un'incidenza sul totale delle emissioni di CO2 in ambito urbano fino a 6 volte superiore rispetto all'incidenza del traffico veicolare.
E in un paese come l'Italia, in cui ben 8 milioni di persone vivono in case con problemi strutturali, di isolamento o con scarsa efficienza energetica, non è ammissibile che la questione venga continuamente rimandata al giorno dopo.
Tuttavia, grazie alle misure come il bonus ristrutturazioni, l'eco bonus e il super bonus 110% messi in campo dalle istituzioni, la situazione sembra destinata a cambiare in meglio, a favore di uno scenario con la casa sostenibile al centro della nostra vita.
E così si conclude questa puntata di INSiDER - Dentro la Tecnologia, io ringrazio come sempre la redazione e in special modo Matteo Gallo e Luca Martinelli che ogni sabato mattina ci permettono di pubblicare un nuovo episodio.
Per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione@dentrolatecnologia.it, seguiteci su Instagram a @dentrolatecnologia dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti.
In qualsiasi caso nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social.
Se trovate interessante il podcast condividetelo che per noi è un ottimo modo per crescere e non dimenticate di farci pubblicità.
Noi ci sentiamo la settimana prossima.