
Gli sciami sismici che stanno interessando la zona dei Campi Flegrei e i diversi terremoti in tutta Italia sono l’emblema di quanto il nostro paese sia un territorio soggetto ai movimenti della crosta terrestre e del magma nel sottosuolo. Le scosse degli ultimi mesi non hanno provocato danni particolari alle infrastrutture, ma più di una volta in Italia si sono verificati fenomeni sismici che hanno portato alla distruzione di vaste aree urbanizzate. Per capire dunque qual è il contributo della tecnologia nel monitoraggio, e nell’eventuale previsione, di terremoti ed eruzioni vulcaniche abbiamo invitato Claudio Chiarabba, Direttore del Dipartimento Terremoti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
Nella sezione delle notizie parliamo del primo volo alimentato da carburante sostenibile condotto da Virgin Atlantic e di un problema di Google Drive che ha causato la scomparsa di documenti di alcuni utenti.

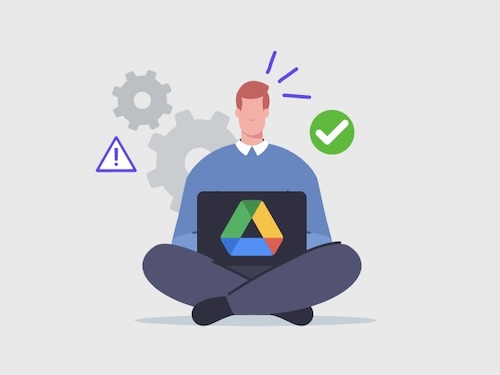

Brani
• Ecstasy by Rabbit Theft
• No Pressure by Tim Beeren & xChenda
Oggi stiamo iniziando a implementare dei sistemi che sostanzialmente usano delle fibre e degli interrogatori che si chiamano DAS e che registrano appunto questo movimento del suolo in esclusiva, ma il vero futuro sarà quello di utilizzare fibre che
contemporaneamente sono utilizzate per i loro scopi principali e quindi senza interrompere o prendere in esclusiva l'uso stesso della fibra.
Salve a tutti, siete all'ascolto di INSiDER - Dentro la Tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host, Davide Fasoli.
Oggi parleremo di terremoti e in particolare proveremo a capire insieme all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ruolo gioca la tecnologia nel misurare e magari un giorno prevedere un evento sismico.
Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a @dentrolatecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina, su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito.
Lo scorso martedì, in tarda mattinata, la compagnia aerea britannica Virgin Atlantic ha compiuto il primo volo transatlantico con un aereo alimentato al 100% da carburante sostenibile.
Il velivolo utilizzato per compiere la tratta a Londra-New York è un Boeing 787 Dreamliner, i cui motori sono stati fatti funzionare grazie a una miscela composta principalmente da olio alimentare usato e grasso animale di scarto, mescolati infine con una piccola quantità di cherosene sintetico ricavato dal mais.
La scelta di alimentare il primo volo commerciale con un carburante sintetico deriva dalla volontà delle compagnie aeree di ridurre le proprie emissioni di CO2 del 70% entro il 2050.
Il carburante sintetico utilizzato in questa occasione, però, ha aperto diversi dibattiti, legati ad un suo ipotetico utilizzo su scala più ampia.
Il problema principale nell'uso di questa miscela deriva infatti dalla sua produzione che rimane ancora particolarmente costosa, attualmente da 3 a 5 volte superiore a quella dei normali carburanti utilizzati quotidianamente dagli aerei di tutto il mondo.
In questi giorni alcuni utenti hanno segnalato comportamenti anomali da parte del servizio cloud di Google, Google Drive.
In particolare sembra che alcuni file, in modo più o meno grave, siano spariti dal proprio account.
Un utente ad esempio segnala che lo stato di Drive sia tornato alla versione di maggio 2023, mentre alcuni dicono di non vedere più file del 2013.
Da parte sua Google ha confermato il problema, che sembra essere legato a un errore di sincronizzazione delle ultime versioni dell'app per Windows e macOS.
Il consiglio di Google quindi, finché non viene risolto il problema, è quello di non disinstallare o disconnettersi dall'app e non eliminare i suoi file temporanei, che potrebbero portare alla completa perdita dei file problematici.
Questo episodio è da ricordare, perché ci dimostra che anche i grandi colossi come Google non sono esenti da bug e non è quindi una buona idea affidarsi del loro servizio ciecamente, affidando loro file, magari anche importanti.
E' sempre meglio piuttosto avere più backup dei propri dati, non solo in cloud o magari su più servizi cloud, ma anche in locale e sui propri dispositivi.
Gli sciami sismici che stanno interessando la zona dei Campi Flegrei a Napoli e i diversi terremoti in tutta Italia, sono l'emblema di quanto il nostro paese sia un territorio fortemente soggetto a fenomeni legati al movimento della crosta terrestre e del magma nel sottosuolo.
Tuttavia, benché le scosse che si sono verificate negli ultimi mesi non abbiano provocato danni particolari alle infrastrutture, più di una volta in Italia si sono verificati intensi fenomeni sismici che hanno portato alla distruzione di vaste aree urbanizzate, come quanto avvenuto all'Aquila tra il 2009 e il 2012.
Per capire dunque qual è il contributo della tecnologia nel monitoraggio e nell'eventuale previsione di terremoti ed eruzioni vulcaniche, siamo in compagnia di Claudio Chiarabba, direttore del Dipartimento Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
Benvenuto, Claudio.
Grazie, grazie.
Per cominciare ci racconti come è nato e come si è evoluto fino ad oggi il monitoraggio dei terremoti?
Il monitoraggio dei terremoti è chiaramente un fenomeno che è in continua evoluzione in termini tecnologici.
Si è partiti praticamente fino all'Ottocento con degli strumenti molto complessi, pesanti, che misuravano le oscillazioni del terreno fino ad arrivare ai più moderni sistemi, ora totalmente digitali e ad alta tecnologia.
Questo è stato un continuo evolversi e un continuo aumento sia numerico, quindi quantitativo, sia qualitativo.
Inoltre ci sono anche diversi aspetti che iniziano a essere monitorati anche attraverso tecnologie particolarmente innovative.
Ok, che poi i temi che andiamo oggi ad approfondire e a proposito di quello che hai appena detto, attualmente com'è composta la rete sismica nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per rilevare scosse e movimenti del sottosuolo e quanti sismometri e sensori sono attivi sia in Italia poi anche nel resto del mondo.
In Italia abbiamo una rete sismica nazionale che è centralizzata e l'acquisizione di tutti i segnali viene centralizzata nella sede di Roma, che è costituita da diverse centinaia di strumenti, attorno ai 400-500 strumenti, che sono di diversa
tecnologia e con anche sensori a diversa banda, che vanno da accelerometri per i movimenti più forti a velocimetri, a sensori a larga banda che registrano bande di frequenze molto estese.
Questa serie di strumenti è operata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ed è distribuita capillarmente su tutto il territorio.
Poi l'Istituto contemporaneamente è anche degli osservatori locali, ad esempio nei vulcani campani, nei vulcani siciliani dove lì ci sono altre centinaia di strumenti che sono sostanzialmente molto densi e sono principalmente devoluti all'attività
proprio sismica dei vulcani che deve essere monitorata con un dettaglio e con una vicinità maggiore.
Poi abbiamo anche degli osservatori vicino a delle zone di faglia importanti, ad esempio nell'Appennino, dove anche lì ci sono una densificazione di strumenti molto importante per andare a cogliere anche i movimenti più piccoli e avvertibili solo da strumenti sofisticati.
Ci sono anche altre reti gestite da altri istituti e università che collaborano con noi nel monitoraggio e con il quale quindi condividiamo uno scambio di dati, ad esempio nelle Alpi orientali e nelle Alpi occidentali o nella zona dell'Erpinia o della Calabria.
Ok e invece per quanto riguarda il resto del mondo, cioè avete anche per quanto riguarda gli studi che fate un interesse a raccogliere dati anche provenienti da altre parti che non siano l'Italia?
Sì certo, abbiamo tutto un sistema di localizzazione a scala mondiale, che chiaramente a scala mondiale il numero di strumenti è considerevolmente maggiore, stiamo sopra la decina di migliaia di strumenti che sono principalmente installati sulle
terre emerse e quindi principalmente nel Nord America, nel Centro America, nell'Europa e nell'Asia, chiaramente con minor copertura nella zona per esempio africana, ma chiaramente ci stanno ancora pochi strumenti che monitorano il fondale marino e oceanico e quello sarà un terreno di sviluppo futuro, speriamo dei prossimi decenni.
Questo insieme di dati confluisce in sistemi internazionali, noi abbiamo nel nostro data center, la sala analisi qui a Roma, una serie di strumenti e di dati che vengono anche da queste reti mondiali e che ci servono a fare una localizzazione a scala
mondiale di terremoti e perché siamo anche controllori degli tsunami, in particolare nella zona mediterranea, ma anche in genere, per cui se abbiamo l'occasione di terremoti che avvengono nel mare o nell'oceano come epicentro, per cui che possono
avere interagito con il fondale sottomarino e potenzialmente generato gli tsunami, noi abbiamo un sistema molto rapido di detezione per eventualmente lanciare dell'allerte, sicuramente è il nostro compito nell'area del Mediterraneo.
Ok parliamo facciamo un piccolo focus su come funzionano questi sensori è parlato di accelerometri ci spieghi a livello nazionale ad esempio ha detto che sono dislocati in diversi punti quindi ci spieghi come funziona un accelerometro o altri
sensori che utilizzate e poi essendo dislocati su un territorio così vasto come fanno a comunicare poi i dati che raccolgono?
Certo, allora noi diciamo che abbiamo... due tipi principali di sensori, uno è un sensore accelerometrico che registra l'accelerazione e il movimento del suolo, gli altri sono dei sensori velocimetrici che registrano il movimento del suolo e mentre
il primo è tarato per registrare terremoti anche grandi, ottenendo una forma d'onda non saturata perché è in grado di registrare forti movimenti, questi altri strumenti velocimetri che possono essere da corto periodo ormai tendiamo a non usarli
più ma a banda sempre più larga o a veri broadband registrano movimenti che hanno frequenze più basse e quindi ci permettono anche un'altra serie di studi ma hanno una dinamica in ampiezza differente da quella degli accelerometri.
L'insieme dei due strumenti allo stesso sito permette di registrare l'intera gamma di spostamenti sia per movimenti molto forti sia per movimenti molto piccoli.
Quello che avviene è che in una stazione sismica che nella migliore dei casi consiste in questi due strumenti, c'è un acquisitore locale, un digitalizzatore e un sistema di trasmissione del dato digitale a un centro di acquisizione che nel nostro caso è posizionato ad esempio qui a Roma.
Questa trasmissione è una trasmissione che avviene a seconda dei canali che possono essere satellitari o MTS e è uno degli aspetti importanti perché la ridondanza del tipo di trasferimento del dato dalla stazione al centro di acquisizione deve
essere tale che se uno dei sistemi per caso non funzionasse il segnale invece dovrebbe comunque essere trasmesso, per cui questo è un aspetto importante.
Chiaramente questo aspetto di trasmissione poi si ripercuote sul consumo di una stazione sismica e quindi sulla capacità di alimentare questo strumento in questa posizione remota.
Noi solitamente preferiamo installare questi strumenti lontano da zone urbane o zone dove c'è un rumore antropico che potrebbe alterare il segnale stesso e questo a volte ci pone difficoltà in quel posto di recepire una rete internet per una
trasmissione in rete direttamente oppure delle fonti di energia e a volte quindi ricorriamo a sistemi con pannelli solari per essere totalmente autonomi e indipendenti.
Sì, un aspetto interessante che hai detto, molto curioso, è che effettivamente serve ridondanza nella comunicazione perché magari se dobbiamo comunicare, se questo sensore deve comunicare un terremoto molto forte, penso ad esempio delle onde
sismiche molto forti, potrebbero aver danneggiato delle infrastrutture, ecco, quindi serve ridondanza.
Esatto, specie dopo terremoti insignificativi potrebbe essere che il sistema di trasmissione o MTS o il sistema di schede potrebbe avere delle difficoltà e per cui bisogna avere più possibili vettori per trasmettere il segnale.
A volte le stazioni hanno anche una registrazione in locale, però quello chiaramente non consente il tempo reale, ma di riprendere il segnale successivamente.
E quindi poi l'istituto ha la possibilità di visionare in tempo reale quella che è la situazione sismica di tutto il territorio nazionale, immagino.
Sì, queste forme d'onda che vengono registrate da questi strumenti che sono dislocati su tutto il territorio, vengono analizzati insieme e insieme vengono interpretati, vengono lette le fasi delle onde che si propagano e da queste si riesce a
stimare i parametri dei terremoti, la loro localizzazione ipocentrale, la magnitudo e altri parametri più sofisticati.
Passiamo a tecnologie più recenti ecco che sono state implementate forse più di recente e quindi oltre ai classici sismometri che appunto utilizzate da anni state sviluppando anche altre soluzioni per monitorare i movimenti della crosta terrestre e si è parlato in passato ad esempio si è sentito parlare di fibra ottica e tecnologia gps.
Come possono queste due tecnologie essere utilizzate anche per quanto riguarda la rilevazione e il monitoraggio dei sismi?
Io intanto distinguerei perché il dato GPS, le stazioni GPS che fanno parte della nostra rete GNSS nazionale, che si chiama Ring, sono ormai stazioni in uso e in funzionamento da decenni.
Loro registrano il movimento del suolo, come il GPS che uno ha sul telefonino, macchina o sulla nave ti dà la posizione del punto, per cui più è precisa questa misura di posizione, più siamo in grado di vedere acquisendo questo dato con una certa
scansione temporale se questo punto si muove, si sposta, per cui noi possiamo vedere i movimenti della terra più o meno lenti a diversa scala temporale attraverso delle stazioni GPS e calcolare ad esempio qual è la velocità di spostamento delle
placche, ma anche durante terremoti questi strumenti che ormai registrano a frequenze di campionamento molto alte, per cui con diversi punti al secondo sono in grado di visualizzare una forma d'onda che è quasi simile a quella di un sismometro sostanzialmente e questo lo è già da diversi anni e decenni.
La fibra invece è una cosa che si sta sviluppando molto negli ultimi anni e penso che dominerà il settore del monitoraggio nei prossimi decenni, perché permette attraverso delle sofisticate metodi di avere sostanzialmente come avere uno strumento
ogni 2 o 3 metri, perché si usa l'intera fibra e si verifica come si deforma al passaggio ad esempio di onde sismiche, quindi questo sarà uno sviluppo molto importante.
Oggi stiamo iniziando a implementare dei sistemi che sostanzialmente usano delle fibre e degli interrogatori che si chiamano DAS e che registrano appunto questo movimento del suolo in esclusiva, ma il vero futuro sarà quello di utilizzare fibre che
contemporaneamente sono utilizzate per i loro scopi principali e quindi senza interrompere o prendere in esclusiva l'uso stesso della fibra.
Ok quindi l'obiettivo come dicevi per il sommare è quello di utilizzare la fibra ottica che gli operatori di telecomunicazione penso ad esempio Open Fiber con cui avete fatto un accordo per sviluppare sistemi di questo tipo, utilizzano appoggiano la
rete per utilizzarla normalmente come stiamo facendo noi in questo momento per comunicare però la stessa rete può essere utilizzata per fare delle rilevazioni per monitorare delle onde sismiche giusto?
Sì, esatto, degli segnali ottici viaggiano comunque sul cavo che essendo solidale col terreno e avendo degli spostamenti possono essere apprezzati attraverso analisi sofisticate di queste pacchetti i dati che viaggiano.
Ok, Pparliamo di altre due tecnologie quindi l'utilizzo dei big data e dell'intelligenza artificiale nel vostro campo.
Come possono queste due tecnologie essere utilizzate oggi sia per monitorare il territorio ma anche arriveremo mai a poter prevedere un terremoto?
Sì, queste sono domande molto interessanti e stimolanti e penso che rappresentino oggi l'argomento più caldo che c'è sulla tema della sismologia strumentale, perché chiaramente noi siamo passati da un passato precedente nel quale il dato veniva
acquisito prima non in continuo, a poi in continuo e veniva processato magari da diversi analisti e quindi si estraeva dal segnale continuo di un sismometro un tot di informazioni che era possibile estrarre.
Il futuro è quello di estrarre tutto quello che si può estrarre da questa forma d'onda continua e quindi da un numero anche maggiore e crescente di strumenti, per cui andiamo lì anche verso una mole di dati che è grande sia in termini di numero
di strumenti e quindi forme d'onda, ma sia anche la capacità di analizzarle completamente attraverso chiaramente delle procedure che non possono che essere automatiche, quindi legate a uno sviluppo di sistemi di machine learning o intelligenza
artificiale che sono in grado di elaborare in maniera simile e anche migliore a quella che farebbe un operatore tecnico scientifico di riconoscimento di un terremoto e delle sue fasi a estrarre tutte quelle possibili idee da quell'onda.
A questo punto uno avrebbe cataloghi sismici, ogni tanto ci chiedono se è vero che avete registrato 1000 terremoti, 10000 quanti ne registrate?
Noi ne registriamo un tot in funzione della magnitudo, però è chiaro che se noi iniziassimo ad analizzare con tecniche sofisticate come questa, anche movimenti più piccoli, allora i nostri cataloghi sarebbero di ordini di grandezza superiori
perché sarebbero completi anche per magnitudo molto basse, cosa che oggi è difficilissimo fare semplicemente con il supporto umano e di un tecnico.
Con questa mole di dati estremamente più ampia di ordini di grandezza è chiaro che magari possono essere implementati e studiati e verificati se ci sono delle variazioni nel tempo e nello spazio che magari utilizzando dei data set più ristretti e più piccoli è molto più difficile riconoscere.
Per cui questo è lo sviluppo dei prossimi decenni, se questo poi porterà a riconoscere anche all'interno di questa sofisticata serie di nuovi studi qualcosa che possa essere utilizzato in termini di forecast è la nostra obiettivo e speranza.
Cioè di prevedere?
Prevedere o riuscire quantomeno, anche se non riconoscere dei segnali precursori che sono legati a un terremoto che sta arrivando, a vedere se tutta questa serie di dati e di loro analisi può rientrare in un processo di forecast più generale, che
poi si traduce in una variazione di probabilità di occorrenza di un evento, un po' come il forecaster che ti dà la probabilità di pioggia in un dato giorno.
Ok, e questi segnali precursori di cui parli, con i dati e con i sensori che ci sono oggi sono determinabili?
Cioè oggi è possibile entro un certo grado determinare quello che potrà essere un possibile terremoto?
Ma è chiaro che se noi andiamo a vedere ad esempio dei terremoti prodotti in laboratorio, stiamo parlando di terremoti di dimensioni infinitesime che sono prodotti appunto nei laboratori su piccoli campioni di roccia che si rompono e quindi si creano dei...
Lì sono riconosciute delle variazioni anche di parametri elastici, di velocità delle onde all'approssimarsi della rottura, questo riconoscerlo in natura è un passo ancora molto complesso, ci sono degli esempi, ci sono degli studi, però ovviamente
è un processo ancora non ben definito, però se riusciamo a migliorare le tecniche di monitoraggio, di analisi, quindi anche di calcolo di queste variazioni di parametri nel tempo potrebbe essere qualcosa anche da controllare e verificare anche in sito e non quindi soltanto nel campione di laboratorio.
Ok, e in questo caso, come dicevi, l'intelligenza artificiale può aiutare, però deve essere supportata da molti dati e quindi anche qui riprendiamo quello che dicevamo prima, quindi l'utilizzo di tecnologie come quella della fibra ottica che può essere utile per fornire una mole di dati sempre più grande e dettagliata.
Esatto, lì c'è un aumento già in sito della mola di dati che possono essere presi attraverso le fibre ottiche per cui già lì c'è necessario un processo di big data associato e magari riconoscere lì delle variazioni in futuro.
Ok e per quanto riguarda il rischio vulcanico invece ci puoi dare una panoramica generale sui progressi che sono stati compiuti negli ultimi anni se questo ha un legame con i movimenti sismici?
Il rischio vulcanico è una cosa estremamente complessa, dipendente anche dalle tipologie, non abbiamo vulcani che sono necessariamente simili, ma ci sono diverse tipologie vulcaniche.
Chiaramente le vulcaniche si comportano in modo diverso e anche solo in Italia la casistica dei vulcani che abbiamo è molto variegata con diverse situazioni.
È chiaro che l'aspetto vulcanico rispetto a quello sismico è un aspetto che nasce multidisciplinare, è un aspetto che non è solo sismico ma è anche di deformazione del vulcano sotto diversi punti di vista locali e di variazioni di parametri, ad
esempio geochimici e di altri osservabili, per cui il monitoraggio di un vulcano rispetto al monitoraggio di un terremoto è qualcosa che nasce multidisciplinare già da subito.
Questo aspetto lo stiamo anche recuperando e ritrattando anche per particolari zone di faglia, per cui per il terremoto non puntiamo solo al dato sismologico, puntiamo anche all'analisi di dati geodetici e geochimici per vedere se ci sono dei segnali transienti che possono essere utilizzati come precursori di un'attività.
Per ii vulcani questa cosa lo è già da tempo ed è molto più chiara perché tutti abbiamo in mente il magma che sale verso la superficie, il rigonfiamento, il sollevamento, questo è già descritto da Plinio, è più visivo, è sicuramente più di
impatto che in un caso sismico dove le cose sono comunque, almeno in termini precursori dell'ordine, solo avvisurabile da strumenti.
Quindi il rischio vulcanico su questo ha questa sua tipicità.
Chiaramente la parte sismologica e sismica con un insieme di analisi che non sono anche solo simili e soltanto a quelle che avvengono per i terremoti, ma perché nel processo vulcanico ci sono segnali anche diversi legati al gas, legati al magma, sono comunque una delle metodi più importanti nella definizione dell'attività di un vulcano.
Perfetto, per chiudere un ultimo aspetto che non è direttamente legato a ciò che fate ma è legato ad un aspetto di cui abbiamo sentito parlare spesso nell'ultimo periodo cioè IT-alert questo sistema di allarme pubblico nazionale che efficacia
può avere un sistema di questo tipo connesso appunto a quello che fate per salvare delle vite di persone che si trovano in situazioni legate appunto a terremoti, eruzioni vulcaniche e così via?
È un sistema di allerta molto veloce e quindi efficace e implementabile per tutte le occasioni nelle quali siamo in grado di definire un sistema di "early warning", cioè un avviso rapido di qualcosa che sta per accadere.
Oggi abbiamo tre esempi operativi sul territorio nazionale di early warning che noi facciamo e sono due di natura vulcanica, una a Stromboli e una all'Etna, è un early warning di quello che sta per accadere al vulcano e quindi questo può rientrare
in un sistema di IT-alert per chi ad esempio quel giorno sta sull'Etna per qualche motivo, anche turistico.
E l'altro sostanziale che facciamo è sugli tsunami, cioè noi siccome c'è un tempo di allerta possibile dalla misurazione di un terremoto e l'arrivo delle onde di maremoto sulle coste, si sfrutta questa latenza di tempi per attivare un sistema di early warning e quindi anche qui il IT-alert è in applicazione per il tema tsunami.
Sul tema terremoti è molto più complesso perché da una parte esistono tecniche di early warning, però nel nostro caso specifico le zone epicentrali che sono quelle che comunque sono più colpite, immediatamente colpite, i tempi di latenza per
applicare efficacemente questo protocollo potrebbero non essere tempi utili per applicare direttamente un sistema di questo tipo, ormai quando saremmo in grado di dire al terremoto che sta arrivando lì è già arrivato come onda, per cui sostanzialmente nelle zone epicentrali potrebbe avere un impatto minore.
Vediamo in futuro se casi di early warning di qualche natura potranno essere definiti anche per il tema terremoti ad esempio, magari fra decenni sul forecast.
Sì quindi non potendolo prevedere l'unica cosa che si può fare è come dicevi quando c'è questa latenza tra l'evento e gli effetti sfruttarla per poter avvisare le persone immediatamente di mettersi al riparo o proteggerci.
Esatto.
Sì, quando c'è la latenza tra il nostro capire, il nostro identificare il processo e l'abbattimento sul potenziale.
E certo e speriamo ovviamente che poter prevedere i terremoti diventi una cosa reale e che quindi si possa fare un'allerta preventiva anche per quello.
Sì, per lui è molto importante la tecnologia e sono degli expertise e degli skill di cui il nostro istituto ha molto bisogno ed è difficile ripetere come personale, per cui veramente sul mondo della tecnologia sarebbe importante stabilire un buon collegamento.
Noi abbiamo molta sofferenza su queste figure professionali, per cui sarebbe interessante riuscire a stimolarle.
Va bene allora grazie Claudio per averci parlato del ruolo della tecnologia in questo ambito così delicato come può essere appunto quello del monitoraggio dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche.
Alla prossima.
Grazie a voi e alla prossima.
E così si conclude questa puntata di INSiDER - Dentro la Tecnologia, io ringrazio come sempre la redazione e in special modo Matteo Gallo e Luca Martinelli che ogni sabato mattina ci permettono di pubblicare un nuovo episodio.
Per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione@dentrolatecnologia.it, seguiteci su Instagram a @dentrolatecnologia dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti.
In qualsiasi caso nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social.
Se trovate interessante il podcast condividetelo che per noi è un ottimo modo per crescere e non dimenticate di farci pubblicità.
Noi ci sentiamo la settimana prossima.





