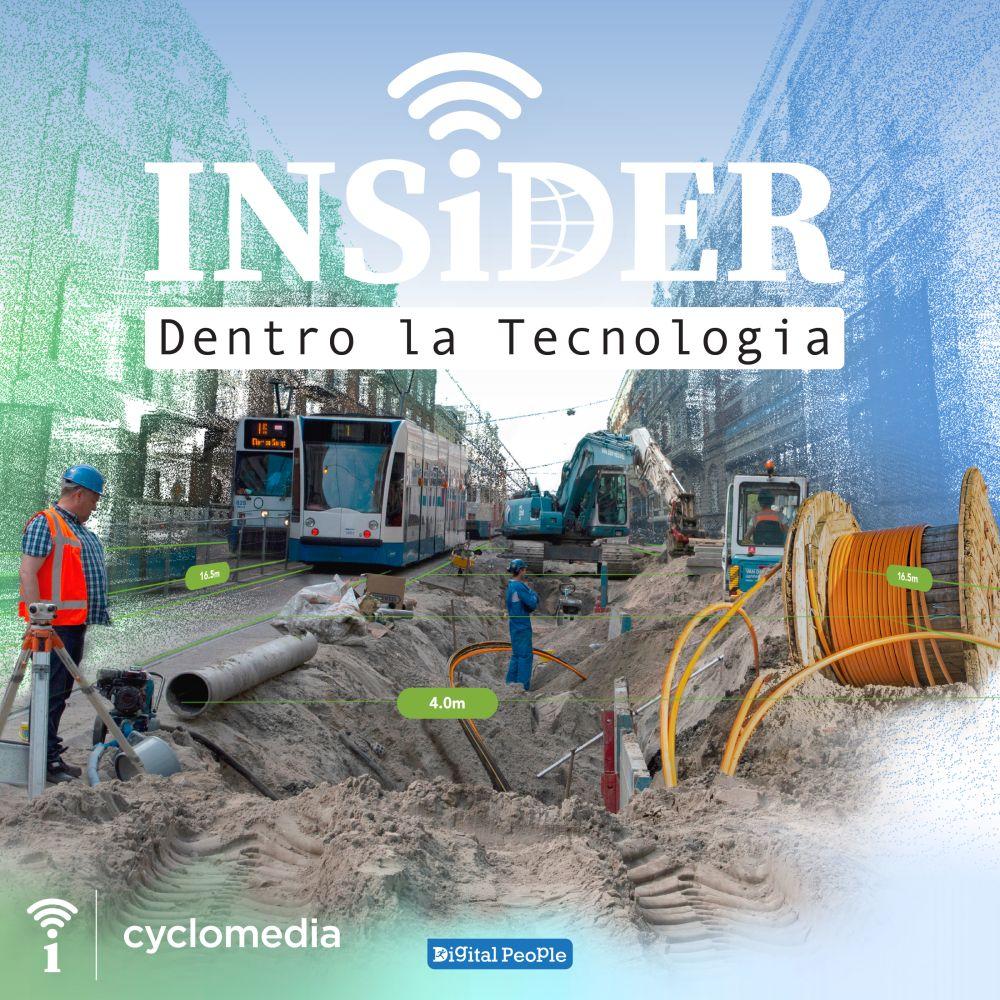La trasversalità della tecnologia è diventata la chiave per il progresso delle attività umane, dove l’innovazione può arrivare a coinvolgere decine di campi di applicazione diversi. Un esempio di questo tipo, che andiamo ad analizzare proprio in questa puntata, è il LIDAR, acronimo di Light Detection And Ranging, ovvero una tecnologia che oltre a permettere la misurazione della distanza di un oggetto illuminandolo con una luce laser, è in grado di restituire informazioni tridimensionali ad alta risoluzione dell’ambiente circostante e trova applicazione in settori diversissimi, passando dallo Spazio fino al nostro smartphone.
Nella sezione delle notizie parliamo del secondo lancio del sistema Starship, di Fussballliebe, il pallone intelligente per Euro 2024 e infine dell'Italia che si vuole proporre come apripista per le Comunità Energetiche.




Brani
• Ecstasy by Rabbit Theft
• There's Nobody Else by Chris Later & Dany Yeager
Salve a tutti, siete all'ascolto di INSiDER - Dentro la Tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host, Davide Fasoli.
Oggi parleremo dei sensori LiDAR, una tecnologia dalle possibilità pressoché illimitate che viene utilizzata sia nello spazio, sia sui nostri smartphone.
Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a @dentrolatecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina, su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito.
Nel primo pomeriggio di sabato 18 novembre si è concluso, con un buon successo, il secondo test del sistema di lancio spaziale Starship di SpaceX dopo la prima prova dello scorso 20 aprile.
Per via della distruzione causata dal decollo prolungato dovuto alla mancata accensione di alcuni motori Raptor al primo tentativo, SpaceX ha deciso di riprogettare e rendere più resistente la rampa di lancio che in questa occasione è rimasta
perfettamente integra, grazie anche all'accensione simultanea di tutti i motori del primo stadio Super Heavy.
Dopo la partenza da manuale, Starship ha proseguito il suo viaggio fino al momento cruciale della missione che la scorsa volta non si era conclusa, ovvero la fase di separazione a caldo dei due stadi avvenuta questa volta invece con grande successo.
A questo punto il piano avrebbe previsto l'amaraggio verticale dei due stadi per simulare la fase di rientro, ma purtroppo il primo stadio, nonostante la corretta rotazione, è stato fatto esplodere preventivamente dal sistema di terminazione di volo per evitare una caduta incontrollata.
La navicella madre invece ha continuato a volare come da programma fino a raggiungere la quota record di 148 km, durante la quale, a causa di un problema ancora non specificato da SpaceX, i motori della Starship si sono spenti e di conseguenza anche in questo caso si è scelto di concludere in anticipo il volo.
Il prossimo campionato europeo di calcio, Euro 2024 in Germania, sarà caratterizzato da un'innovazione importante, Fussballliebe, il pallone intelligente sviluppato da Adidas.
Questo strumento rivoluzionario integrerà per la prima volta la Connect Ball Technology, promettendo di trasformare il modo in cui vengono gestite le decisioni arbitrali.
L'integrazione di questa tecnologia segna un passo avanti significativo, in particolare per quanto riguarda la segnalazione del fuorigioco e i falli di mano.
Il pallone sarà dotato di un sensore di movimento inserito al centro in un sistema di sospensione e supportato da un'unità di misura inerziale a 500 Hz.
Questo sistema fornisce una visione dettagliata e senza precedenti del movimento del pallone.
Il sensore, alimentato da una batteria ricaricabile tramite induzione, invierà in tempo reale dati precisi sull'andamento del pallone ad arbitri e alla sala VAR, tecnologia fra l'altro di cui abbiamo parlato in una puntata qualche settimana fa.
La Connect Ball Technology renderà le segnalazioni di fuorigioco semi-automatiche, combinando dati sulla posizione dei giocatori con l'intelligenza artificiale.
Nella puntata "Le comunità energetiche per un futuro realmente sostenibile" avevamo parlato del ruolo che hanno e avranno le comunità energetiche, quelle rinnovabili in particolare, nello sviluppo di metodi sostenibili per produrre energia pulita.
In breve, le comunità energetiche non sono altro che impianti costruiti da associazioni, enti locali o anche privati cittadini, per produrre in modo autonomo energia rinnovabile, diminuendo il carico sulla rete nazionale.
E l'Italia vuole diventare un'apripista a livello europeo per quanto riguarda le comunità energetiche rinnovabili, sostenendone la loro diffusione sul territorio sia a livello burocratico che finanziario.
Il provvedimento italiano infatti prevede degli incentivi sull'energia rinnovabile prodotta e condivisa e sfruttando i 2,2 miliardi dei fondi del PNRR, un contributo a fondo perduto fino al 40% per le comunità energetiche realizzate nei comuni che hanno meno di 5.000 abitanti.
Il provvedimento è stato inoltre pienamente validato dalla Commissione europea e la speranza è che, seguendo il modello italiano, le comunità energetiche possano diffondersi anche nel resto dell'Unione.
Riflettendo sui numerosi temi che abbiamo affrontato negli ultimi anni in questo podcast, risulta ormai evidente quanto la tecnologia sia diventata pervasiva e fondamentale per il nostro modo di vivere nella società.
Oggi singoli strumenti che diamo per scontato, ma particolarmente innovativi come gli smartphone, ci consentono di compiere numerose operazioni in grado di semplificare il lavoro e la nostra vita sociale.
La trasversalità della tecnologia è infatti diventata la chiave per il progresso delle attività umane, dove l'innovazione può arrivare a coinvolgere decine di campi d'applicazione diversi.
Un esempio di questo tipo, e che andremo ad analizzare proprio in questa puntata, è il LiDAR, acronimo di Light Detection and Ranging, ovvero di una tecnologia che oltre a permettere la misurazione della distanza di un oggetto, illuminandolo con una
luce laser, è in grado di restituire informazioni tridimensionali ad alta risoluzione dell'ambiente circostante.
Per fare un esempio della duttilità di questa tecnologia, ci basti pensare che in passato il LiDAR veniva utilizzato anche per fare previsioni meteo, tema di cui abbiamo parlato nella puntata di sabato 11 novembre.
Prima dell'avvento di tecnologie più avanzate e specifiche per questo settore, i LiDAR terrestri erano infatti in grado di determinare l'altezza della base delle nubi e il loro spessore verticale inviando impulsi laser verso il cielo, e per di più
con lo stesso sistema si potevano determinare altri dati atmosferici come la concentrazione di ozono, biossido di azoto e particolato, in grado di influire significativamente sulle condizioni meteorologiche.
Ad oggi questa tecnologia riveste un ruolo chiave in molti altri settori, che vanno dal tele-rilevamento per l'acquisizione di informazioni territoriali, sino alla mappatura 3D di ambienti attraverso gli smartphone.
In ogni caso, nonostante la moltitudine di applicazioni, il funzionamento di base di tecnologia è pressoché lo stesso, e si fonda essenzialmente su un principio fisico chiave.
Sapendo che la velocità della propagazione della luce è sempre la stessa, ovvero 300.000 km al secondo, si può calcolare di conseguenza il tempo impiegato da un raggio luminoso per andare da una sorgente iniziale verso un bersaglio e ritornare.
In questo modo, l'unità del sensore che si occupa dell'elaborazione del segnale di ritorno è in grado di scannerizzare l'ambiente e generare un modello 3D dell'area interessata, costituito da milioni di punti.
I vantaggi nell'utilizzo di questa tecnologia sono legati ai sensori di ultima generazione, che nonostante la miniaturizzazione della tecnologia, risultano di facile utilizzo e garantiscono al contempo misurazioni veloci e ad ampia risoluzione.
Come premesso all'inizio di questa puntata, gli utilizzi della tecnologia LiDAR sono innumerevoli, talmente tanti che purtroppo non faremo in tempo a trattarli tutti.
Ma vediamone alcuni tra i più significativi.
Al giorno d'oggi i sensori LiDAR vengono spesso equipaggiati sui veicoli, come droni o aerei, per effettuare rilievi topografici del terreno con estrema precisione.
Tipicamente su questi mezzi i sensori LiDAR vengono supportati anche da un sistema di posizionamento satellitare GPS e un sistema inerziale di navigazione, il cui compito è quello di determinare la posizione e l'orientamento del mezzo aereo in ogni istante della fase di rilievo.
Come supporto di terra invece entra in gioco la stazione GPS, ovvero delle postazioni fisiche appositamente create per correggere la posizione del velivolo nella fase di elaborazione finale dei dati.
Grazie alla cooperazione tra questi strumenti è possibile ottenere un insieme preciso di punti georeferenziati tramite coordinate e una quota Z calcolata in base alla differenza di tempo intercorsa tra il segnale laser emesso e quello riflesso dalla superficie.
Alla fine dell'elaborazione la cosiddetta nuvola di punti acquisita verrà trasformata in un modello digitale di elevazione, detto DEM, dove verranno rappresentate le distribuzioni delle quote di un territorio in formato digitale.
I DEM successivamente possono essere impiegati in un sistema informativo geografico, o GIS, per produrre nuove informazioni sulla base di quelle originali.
Tra gli esempi più diffusi di rilievi aerei con i LiDAR troviamo la mappatura delle linee di trasmissione di distribuzione elettrica, la modellazione accurata di infrastrutture legate alle ferrovie, strade o fiumi, mentre nel campo dell'ingegneria
progettuale i prodotti dei rilievi LiDAR risultano fondamentali nel facilitare le fasi decisionali relative alla progettazione e alla costruzione di opere artificiali.
Un ulteriore impiego infine può essere effettuato nel campo ambientale per ottenere informazioni relative a coperture forestali o di aree inondabili nell'ambito del dissesto idrogeologico.
Per quanto riguarda i LiDAR spaziali, la NASA è in prima linea nello sviluppo di questa tecnologia per l'osservazione della Terra e dei cambiamenti che la interessano.
Attualmente a ricoprire un ruolo fondamentale nello studio delle superfici terrestri è l'ICESat-2, un satellite lanciato nel 2018 che si occupa di misurare con precisione centimetrica l'altezza degli strati di ghiaccio delle calotte polari, la topografia terrestre, le caratteristiche delle nubi e della vegetazione.
Nonostante il termine della missione fosse previsto per il 2021, l'operatività del satellite è stata prolungata di altri quattro anni almeno.
Tuttavia, nel 2024 è previsto il lancio della missione NASA-ISRO SAR, nonché del satellite NISAR, che si affiancherà ad ICESat-2 per condurre ricerche sui cambiamenti climatici e della morfologia terrestre.
Per quanto riguarda poi gli usi di questa tecnologia via terra, ne potremmo elencare parecchi, ma l'esempio più interessante e promettente è forse quello legato al settore dell'automotive.
I sensori LiDAR infatti vengono montati oggi sulle auto in modo tale che possano guidare autonomamente senza l'intervento di un conducente.
Di questo tema ne avevamo parlato ampiamente nella puntata "I progressi e le sfide per un futuro a guida autonoma" nella quale erano emerse le evidenti criticità nel rendere completamente autonomo il veicolo, soprattutto da un punto di vista legislativo.
E infatti i motivi per cui ancora non si sono affermati questi sistemi non è tanto legato alla ricerca scientifica e tecnologica, quanto invece al costo dei sistemi da installare nelle vetture.
Poiché dotare un'auto delle migliori tecnologie per far sì che guidi da sola è molto oneroso da un punto di vista economico.
Ed uno fra i sistemi cruciali che rendono possibile questa funzione è proprio il LiDAR.
Perciò se oggi procede ancora rilento la diffusione di questi sistemi è perché paradossalmente le case automobilistiche che intendono vendere auto tecnologiche e con sistemi di guida semi-autonoma si rifiutano di installare i sistemi LiDAR per
mappare le zone che circondano l'auto, che le renderebbero sicuramente più capaci di raggiungere l'automazione totale di livello 5.
I veicoli che attualmente utilizzano il LiDAR per ricostruire l'ambiente circostante sono le auto di Waymo, le quali offrono un servizio taxi senza conducente in alcune città della California come San Francisco.
Si tratta però di un caso particolare, perché stiamo parlando di una flotta molto più ridotta rispetto a quella di Tesla, che possiede invece auto in tutto il mondo in mano a singoli cittadini.
Il problema legato all'installazione della tecnologia LiDAR su auto commerciali è dovuto all'inevitabile aumento del prezzo finale, anche perché i sensori più avanzati che risolvono problemi, come quelli legati alle diverse condizioni meteorologiche tipo pioggia, neve o nebbia, possono comportare un rincaro anche di 5 o 6 mila euro.
Per di più un altro fattore che inficia sul rapporto prezzo qualità della vettura è l'elevato consumo di energia del sistema, che potrebbe comportare una riduzione dell'autonomia finale della batteria dell'auto elettrica del 2 o 3%.
Da qualche anno, infine, i sensori LiDAR vengono inseriti anche sugli smartphone top di gamma delle principali case di produzione come Apple, Samsung e Google, con i relativi pixel.
Nonostante si parli naturalmente di versioni depotenziate rispetto a quelle di cui abbiamo parlato poco fa, i sensori LiDAR hanno reso gli smartphone dei dispositivi in grado di creare esperienze immersive con una miglior comprensione del mondo reale rispetto a quello che facevano in precedenza le normali fotocamere.
Potendo acquisire i dettagli 3D dell'ambiente circostante, si sono aperte un sacco di funzionalità legate all'utilizzo della realtà aumentata e degli effetti fotografici come il tracking di più volti contemporaneamente, il motion capture o la
miglior gestione dell'occlusione, ovvero la possibilità di avere oggetti virtuali che vengono coperti nella scena da una persona reale.
La digitalizzazione dinamica delle aree circostanti ha permesso a tecnologie come la realtà aumentata e virtuale di lavorare al meglio possibile sugli smartphone, come nel caso dell'app Ikea Place, con la quale è possibile scansionare una stanza
della propria abitazione e successivamente inserire virtualmente un elemento che intendiamo acquistare come un mobile o una poltrona.
In definitiva, analizzando tecnologie rivoluzionari come i LiDAR, ci siamo resi conto di come un singolo strumento possa trovare applicazione in una moltitudine di campi, rivelando così un enorme potenziale.
La capacità di questo strumento di scansionare l'ambiente in 3D con precisione fino al millimetro stanno già trasformando settori fondamentali, come il monitoraggio ambientale, l'automotive o la robotica, ma le possibilità sono pressoché illimitate.
Anche perché quando una nuova tecnologia viene applicata per la prima volta in un campo, spesso rivela nuove possibilità che ispirano altri settori ad adottare questo tipo di innovazione tecnologica.
E così si conclude questa puntata di INSiDER - Dentro la Tecnologia, io ringrazio come sempre la redazione e in special modo Matteo Gallo e Luca Martinelli che ogni sabato mattina ci permettono di pubblicare un nuovo episodio.
Per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione@dentrolatecnologia.it, seguiteci su Instagram a @dentrolatecnologia dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti.
In qualsiasi caso nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social.
Se trovate interessante il podcast condividetelo che per noi è un ottimo modo per crescere e non dimenticate di farci pubblicità.
Noi ci sentiamo la settimana prossima.